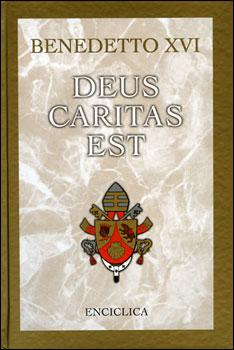
SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO. Una nota di Federico La Sala
- [...] Il grande discendente dei mercanti del Tempio si sarà ripetuto in cor suo e riscritto davanti ai suoi occhi il vecchio slogan: con questo ‘logo’ vincerai! Ha preso ‘carta e penna’ e, sul campo recintato della Parola, ha cancellato la vecchia ‘dicitura’ e ri-scritto la ‘nuova’: “Deus caritas est”
[Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006]!
 Nell’anniversario del “Giorno della memoria”, il 27 gennaio, non poteva essere ‘lanciato’ nel ‘mondo’ un “Logo” ... più ‘bello’ e più ‘accattivante’, molto ‘ac-captivante’!!! [...]
Nell’anniversario del “Giorno della memoria”, il 27 gennaio, non poteva essere ‘lanciato’ nel ‘mondo’ un “Logo” ... più ‘bello’ e più ‘accattivante’, molto ‘ac-captivante’!!! [...]
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- "AUT - AUT". “To be, or not to be, that is the question”(W, Shakespeare, "Amleto", III.1): "Voi non potete servire Dio ["Deus charitas est"] e Mammona ["Deus caritas est"] (Luca 16, 13).
Caro BENEDETTO XVI ...
Corra, corra ai ripari (... invece di pensare ai soldi)! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. L’Eu-angélo dell’AMORE (“charitas”) è diventato il Van-gélo del ’caro-prezzo’ e della preziosi-tà (“caritas”), e la Parola (“Logos”) è diventato il marchio capitalistico di una fabbrica (“Logo”) infernale ... di affari e di morte?! Ci illumini: un poco di CHIAREZZA!!! FRANCESCO e CHIARA di Assisi si sbagliavano?! Claritas e Charitas, Charitas e Claritas... o no?!
Federico La Sala
 "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE...
"CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE...
 DEUS CHARITAS EST"(1 Gv., 4.1-8)
DEUS CHARITAS EST"(1 Gv., 4.1-8)
 2008, L’ANNO DELLA PAROLA.
2008, L’ANNO DELLA PAROLA.
 IN EBRAICO: VERITA’ - "EMET", E MORTE - "MET".
IN EBRAICO: VERITA’ - "EMET", E MORTE - "MET".
 BENEDETTO XVI:"Deus caritas est", 2006)!!!
BENEDETTO XVI:"Deus caritas est", 2006)!!!
 DIO E’ MAMMONA ("CARITAS"): UN’ENCICLICA DI UNA CHIESA SENZA "H" E SENZA AMORE ("CHARITAS").
DIO E’ MAMMONA ("CARITAS"): UN’ENCICLICA DI UNA CHIESA SENZA "H" E SENZA AMORE ("CHARITAS").
[2006]
 “DEUS CARITAS EST”:
“DEUS CARITAS EST”:
 IL “LOGO” DEL GRANDE MERCANTE
IL “LOGO” DEL GRANDE MERCANTE
 E DEL CAPITALISMO
E DEL CAPITALISMO
 di Federico La Sala *
di Federico La Sala *
In principio era il Logos, non il “Logo”!!! “Arbeit Macht Frei”: “il lavoro rende liberi”, così sul campo recintato degli esseri umani!!! “Deus caritas est”: Dio è caro-prezzo, così sul campo recintato della Parola (del Verbo, del Logos)!!! “La prima enciclica di Ratzinger è a pagamento”, L’Unità, 26.01.2006 )!!!
Il grande discendente dei mercanti del Tempio si sarà ripetuto in cor suo e riscritto davanti ai suoi occhi il vecchio slogan: con questo ‘logo’ vincerai! Ha preso ‘carta e penna’ e, sul campo recintato della Parola, ha cancellato la vecchia ‘dicitura’ e ri-scritto la ‘nuova’: “Deus caritas est” [Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006]!
Nell’anniversario del “Giorno della memoria”, il 27 gennaio, non poteva essere ‘lanciato’ nel ‘mondo’ un “Logo” ... più ‘bello’ e più ‘accattivante’, molto ‘ac-captivante’!!!
Il Faraone, travestito da Mosè, da Elia, e da Gesù, ha dato inizio alla ‘campagna’ del Terzo Millennio - avanti Cristo!!! (Federico La Sala)
*www.ildialogo.org/filosofia, Giovedì, 26 gennaio 2006.
|
GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |
(per leggere gli art. seguenti, cliccare sul rosso)
- EPISTOLA ENCYCLICA - MIRAE CARITATIS SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS PAPAE XIII. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA
- MIRAE CARITATIS. LETTERA ENCICLICA DI SUA SANTITÀ LEONE PP. XIII. LA SANTA EUCARESTIA
- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)
- RETTIFICARE I NOMI: UNA LEZIONE DI CONFUCIO. Un giorno un giovane discepolo gli fece questa domanda: «Maestro, se vi fosse affidato un regno da governare secondo i vostri principi, che fareste per prima cosa?». Confucio rispose: «Per prima cosa rettificherei i nomi». A questa risposta il discepolo rimase molto perplesso: «Rettificare i nomi? Con tante cose gravi e urgenti che toccano a un governante voi vorreste sprecare il vostro tempo con una sciocchezza del genere? È uno scherzo?». Confucio dovette spiegare: «Se i nomi non sono corretti, cioè se non corrispondono alla realtà, il linguaggio è privo di oggetto. Se il linguaggio è privo di oggetto, agire diventa complicato, tutte le faccende umane vanno a rotoli e gestirle diventa impossibile e senza senso. Per questo il primo compito di un vero uomo di Stato è rettificare i nomi».
 "CARITAS IN VERITATE: "55.[...] La libertà religiosa non significa indifferentismo religioso e non comporta che tutte le religioni siano uguali (133). Il discernimento circa il contributo delle culture e delle religioni si rende necessario per la costruzione della comunità sociale nel rispetto del bene comune soprattutto per chi esercita il potere politico. Tale discernimento dovrà basarsi sul criterio della carità [caritatis] e della verità. Siccome è in gioco lo sviluppo delle persone e dei popoli, esso terrà conto della possibilità di emancipazione e di inclusione nell’ottica di una comunità umana veramente universale. «Tutto l’uomo e tutti gli uomini» è criterio per valutare anche le culture e le religioni. Il Cristianesimo, religione del « Dio dal volto umano » (134), porta in se stesso un simile criterio.
"CARITAS IN VERITATE: "55.[...] La libertà religiosa non significa indifferentismo religioso e non comporta che tutte le religioni siano uguali (133). Il discernimento circa il contributo delle culture e delle religioni si rende necessario per la costruzione della comunità sociale nel rispetto del bene comune soprattutto per chi esercita il potere politico. Tale discernimento dovrà basarsi sul criterio della carità [caritatis] e della verità. Siccome è in gioco lo sviluppo delle persone e dei popoli, esso terrà conto della possibilità di emancipazione e di inclusione nell’ottica di una comunità umana veramente universale. «Tutto l’uomo e tutti gli uomini» è criterio per valutare anche le culture e le religioni. Il Cristianesimo, religione del « Dio dal volto umano » (134), porta in se stesso un simile criterio.
 56 La religione cristiana e le altre religioni possono dare il loro apporto allo sviluppo solo se Dio trova un posto anche nella sfera pubblica, con specifico riferimento alle dimensioni culturale, sociale, economica e, in particolare, politica. La dottrina sociale della Chiesa è nata per rivendicare questo « statuto di cittadinanza » (135) della religione cristiana. La negazione del diritto a professare pubblicamente la propria religione e ad operare perché le verità della fede informino di sé anche la vita pubblica comporta conseguenze negative sul vero sviluppo."(Benedetto XVI, 29 giugno 2009).
56 La religione cristiana e le altre religioni possono dare il loro apporto allo sviluppo solo se Dio trova un posto anche nella sfera pubblica, con specifico riferimento alle dimensioni culturale, sociale, economica e, in particolare, politica. La dottrina sociale della Chiesa è nata per rivendicare questo « statuto di cittadinanza » (135) della religione cristiana. La negazione del diritto a professare pubblicamente la propria religione e ad operare perché le verità della fede informino di sé anche la vita pubblica comporta conseguenze negative sul vero sviluppo."(Benedetto XVI, 29 giugno 2009).
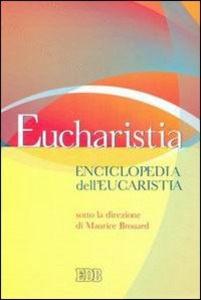
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
- THE CLOISTERS (MANHATTAN): LA TEOLOGIA DELL’INCARNAZIONE NELLA ANNUNCIAZIONE DEL TRITTICO DI MERODE (ROBERT CAMPIN, 1425).
- L’eletto - Thomas Mann: "Edipo Papa. Il regno di Edipo è di questa terra, ma può diventare anche quello dei cieli. Se allo sconosciuto padre terreno si sostituisce il Padre onnipotente che ha bisogno di un grande figlio perché lo rappresenti nel mondo" (Lea Ritter Santini, Introduzione, Oscar Mondadori 1979).
- "AUT - AUT". “To be, or not to be, that is the question”(W, Shakespeare, "Amleto", III.1): "Voi non potete servire Dio ["Deus charitas est"] e Mammona ["Deus caritas est"] (Luca 16, 13).
 CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Benedetto XVI, il papa teologo, ha gettato via la "pietra" ("charitas") su cui posava l’intera Costruzione...
CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Benedetto XVI, il papa teologo, ha gettato via la "pietra" ("charitas") su cui posava l’intera Costruzione...
 IL PAPATO DI BENEDETTO XVI: SETTE ANNI DI OFFESE ALLA CHIESA E ALL’ITALIA. Una nota su un incontro del 2005 e sugli eventi successivi, fino ad oggi
IL PAPATO DI BENEDETTO XVI: SETTE ANNI DI OFFESE ALLA CHIESA E ALL’ITALIA. Una nota su un incontro del 2005 e sugli eventi successivi, fino ad oggi
Federico La Sala
Forum
-
>DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO --- EUROPA E CHIESA CATTOLICA: ANTROPOLOGIA E STORIA. Le parole del Papa sulle donne e l’insolita nota dell’Università di Lovanio (di Gianni Cardinale).29 settembre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA) E COSMOTEANDRIA...
Il caso.
Le parole del Papa sulle donne (e l’insolita nota dell’Università di Lovanio)
- Discorso nella sede francofona dell’ateneo. Poi a sorpresa, quando l’incontro è al termine, arriva una nota dell’ateneo non firmata che critica le parole del Papa sul ruolo femminile. Cosa è successo
di Gianni Cardinale, inviato a Bruxelles (Avvenire, sabato 28 settembre 2024)
- [Foto] Il discorso del Papa agli universitari della Cattolica di Lovanio - Ansa
Papa Francesco incontra gli studenti e i docenti dell’Université Catholique di Louvain-la Neuve, la sezione francofona dell’antica Lovanio che nel 1968 dovette lasciare la casa madre in seguito alle proteste dei nazionalisti fiamminghi che ne reclamavano la soppressione. Ma di questa vicenda nessuno ha fatto cenno sia nella visita a Leuven, né a Louvain. Gli argomenti sono altri. Con una sorprendente contestazione dell’ateneo alle parole del Pontefice. Ma andiamo per ordine.
 Il Papa viene accolto dal saluto della rettrice Francoise Smets. E poi gli viene letta una lettera di studenti e professori che prendendo spunto dalla Laudato si’ afferma in modo netto che «l’appello allo sviluppo integrale ci sembra incompatibile con le posizioni sull’omosessualità e sul posto delle donne nella Chiesa cattolica».
Il Papa viene accolto dal saluto della rettrice Francoise Smets. E poi gli viene letta una lettera di studenti e professori che prendendo spunto dalla Laudato si’ afferma in modo netto che «l’appello allo sviluppo integrale ci sembra incompatibile con le posizioni sull’omosessualità e sul posto delle donne nella Chiesa cattolica».Il Papa non risponde direttamente a queste osservazioni, ma nel suo discorso oltre ad affrontare il tema del cristianesimo e l’ecologia («non siamo padroni, siamo ospiti e pellegrini sulla terra») affronta anche tale questione.
 «Pesano qui - spiega - violenze e ingiustizie, insieme a pregiudizi ideologici». Perciò «bisogna ritrovare il punto di partenza: chi è la donna e chi è la Chiesa». La Chiesa «è il popolo di Dio, non un’azienda multinazionale». La donna, «nel popolo di Dio, è figlia, sorella, madre. Come io sono figlio, fratello, padre».
«Pesano qui - spiega - violenze e ingiustizie, insieme a pregiudizi ideologici». Perciò «bisogna ritrovare il punto di partenza: chi è la donna e chi è la Chiesa». La Chiesa «è il popolo di Dio, non un’azienda multinazionale». La donna, «nel popolo di Dio, è figlia, sorella, madre. Come io sono figlio, fratello, padre».
 Per Francesco «ciò che è caratteristico della donna, ciò che è femminile, non viene sancito dal consenso o dalle ideologie». Ma «la dignità è assicurata da una legge originaria, non scritta sulla carta, ma nella carne». La dignità è «un bene inestimabile, una qualità originaria, che nessuna legge umana può dare o togliere».
Per Francesco «ciò che è caratteristico della donna, ciò che è femminile, non viene sancito dal consenso o dalle ideologie». Ma «la dignità è assicurata da una legge originaria, non scritta sulla carta, ma nella carne». La dignità è «un bene inestimabile, una qualità originaria, che nessuna legge umana può dare o togliere».
 A braccio ricorda che «la Chiesa è donna», e poi aggiunge: «La donna è più importante dell’uomo ma è brutto quando vuole fare l’uomo». E infine, sempre a braccio, invita a «non entrare nelle lotte con delle dicotomie ideologiche».
A braccio ricorda che «la Chiesa è donna», e poi aggiunge: «La donna è più importante dell’uomo ma è brutto quando vuole fare l’uomo». E infine, sempre a braccio, invita a «non entrare nelle lotte con delle dicotomie ideologiche». -
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" --- "La grazia è un incontro" (Adrien Candiard): il segreto perduto della grazia (di Roberto Italo Zanini).10 aprile 2024, di Federico La Sala
Teologia.
Imparare a lasciarsi amare da Dio: il segreto perduto della grazia
Il teologo domenicano Adrien Candiard torna su un tema antico ma dibattuto a suo avviso in modo fuorviante: la grazia è un incontro d’amore. Ma l’essenziale può essere abbagliante...
di Roberto Italo Zanini (Avvenire, martedì 9 aprile 2024)
«Maestro cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?». Un libro che comincia con la domanda del “giovane ricco” (Mt19,16) e finisce con una limpida considerazione sull’essenzialità della grazia di Dio che «è un incontro ed è un incontro d’amore» è certamente provocatorio. Lo stesso autore, il teologo domenicano Adrien Candiard, sottolinea che «tutti i discorsi teologici sulla grazia sviluppati nel corso dei secoli... sono andati fuori strada quando hanno mancato l’essenziale». La lista è lunga e attraversa i millenni fra dotti dibattiti teologici (domenicani-gesuiti), scismi, controriforma, concili, contrapposizioni pastorali e via dicendo. Eppure, quell’essenziale «abbaglia come il sole estivo di Galilea che si avvicina allo zenit», dice l’autore ricordando un recente pellegrinaggio al Monte delle beatitudini. È l’ineguagliabile e spesso misconosciuta originalità della vita cristiana, oggi sperduta nella nebbia di senso e di verità che avvolge le sempre più esigue Chiese d’Occidente.
L’essenziale «abbaglia», ma evidentemente non è facile da cogliere. Il giovane ricco va cercando proprio quello: la vita vera, fatta delle cose che contano, che danno piena soddisfazione, che ci fanno felici e restano per l’eternità. Lui, che è un’anima bella e osserva tutti i comandamenti, lo va a chiedere proprio alla “luce che brilla come il sole”, che prontamente lo ama, ma lui non riesce a restarne illuminato. Come noi e come i discepoli nel racconto evangelico, viene travolto dalla cruda risposta di Gesù: «Se vuoi essere perfetto, vai, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!».
Candiard si dice travolto anch’egli dall’enormità delle parole di Gesù e nel libro pone il quesito che interroga i cristiani fin da san Paolo: ma se, come dice l’Apostolo, è la fiducia nella grazia a donare la vita eterna, perché Gesù, che è sempre accogliente con tutti, domanda al giovane come se la cava coi comandamenti e poi formula una proposta di perfezione così esigente che gli stessi discepoli, sgomenti, si chiedono, ma allora chi può essere salvato? In quest’ottica la replica di Gesù, «impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile», risulta un chiarimento efficace, ma non risponde al quesito sul valore della grazia e su quello delle opere.
 Dilemma millenario e scismatico che riemerge ciclicamente e con prepotenza condizionante, al punto che papa Francesco ha più volte sottolineato il pericolo per la Chiesa di oggi di restare ingabbiata in un nuovo pelagianesimo. Perché puntando tutto sulla prassi, sulla dottrina sociale, sulle opere assistenziali, sulle cose da fare, sulla liturgia ridotta a routine, sulle preghiere senz’anima si finisce per perdere il carisma profetico e autenticamente cristiano, che viene dall’apertura totale all’amore di Dio, all’azione dello Spirito.
Dilemma millenario e scismatico che riemerge ciclicamente e con prepotenza condizionante, al punto che papa Francesco ha più volte sottolineato il pericolo per la Chiesa di oggi di restare ingabbiata in un nuovo pelagianesimo. Perché puntando tutto sulla prassi, sulla dottrina sociale, sulle opere assistenziali, sulle cose da fare, sulla liturgia ridotta a routine, sulle preghiere senz’anima si finisce per perdere il carisma profetico e autenticamente cristiano, che viene dall’apertura totale all’amore di Dio, all’azione dello Spirito.Ecco allora la provocazione di questo libro, che nell’edizione italiana, (Lev, pagine 109, euro 13) ha un titolo esplicativo e pratico: La grazia è un incontro. E nel sottotitolo specifica: Se Dio ama gratis, perché i comandamenti? Nell’originale francese, invece, il titolo, più simbolico, indica il percorso teologico-spirituale seguito da Candiard per fondare evangelicamente le ragioni della Grazia. Percorso che pone le sue radici nel Discorso della montagna: Sur la Montagne. L’aspérité et la grâce. E sulla Montagna Gesù comincia con le Beatitudini (Mt5, 3-12) che certamente costituiscono un programma esigente, e prosegue con altre “asperità” come: amate i nemici, porgete l’altra guancia, date a chi chiede, non preoccupatevi di quello che mangerete, non potete servire Dio e cercare la ricchezza... Raccomandazioni che a metterle in pratica, specifica il Vangelo, si fa come chi costruisce la propria casa sulla roccia (Mt7,24-27).
Se la parola “beati”, dice Candiard, può agevolmente essere resa con “felici”, le Beatitudini sono il percorso della vera felicità e restarne spiazzati è la prima conseguenza per il lettore attento. Cosa c’entra la felicità con la fame di giustizia, con la persecuzione, col pianto, con la povertà? Tanto più, possiamo aggiungere, che la gioia della risurrezione è pura felicità? Per uscire da questa rischiosa incomprensione, il padre domenicano ci ricorda che per Gesù la felicità non è nel non avere nulla, ma nel possedere il Regno di Dio, nell’abitarlo. Pertanto, «Quello che conviene cercare non è essere poveri, tristi o affamati di giustizia, ma è: essere consolati, saziati, perdonati, essere chiamati figli di Dio, è vedere Dio». Insomma, ciò che genera e dona la vera felicità, la vita vera; ciò che cercava il giovane ricco e che probabilmente cerca nel proprio intimo ognuno di noi, è tutto questo insieme, è il Regno di Dio, la perla preziosa da desiderare più di ogni altro bene al mondo. E il Regno di Dio non è l’Onnipotente che viene a prendere il controllo del mondo, ma è il suo amore incondizionato che si rivela in una povera mangiatoia e si offre sulla croce rigenerando la vita, la felicità eterna. Il Regno di Dio è amore, ed è amore donato, offerto a tutti, gratis, per sempre. Amore capace di renderci figli: divini come lui è divino. Questa è la buona novella. Questa è la grazia, sottolinea Candiard. E per cambiare le nostre vite, secondo il desiderio del giovane ricco, dobbiamo semplicemente desiderare di essere sanati e lasciarci sanare, desiderare di essere amati e lasciarci amare.
Facile? Evidentemente no se Pietro rifiuta, in prima battuta, che il Maestro lavi i suoi piedi (Gv 13,8); se tanta gente si indigna nel vedere Gesù che accetta di farsi profumare i piedi da una prostituta (Lc 7,38); se c’è chi si presenta alla festa di nozze senza essersi lasciato vestire con l’abito nuziale (Mt 22,12); se dopo secoli di dibattito teologico ancora adesso corriamo il rischio di restare irretiti dall’inganno pelagiano di conquistarci il Regno con le nostre forze, pur essendo stati avvertiti da Gesù in persona che non ne abbiamo a sufficienza.
 «Nella Chiesa - aggiunge Candiard, che si chiede come mai ci sia tanta difficoltà per i cristiani a parlare di grazia - spendiamo un sacco di energie, di omelie e conferenze a lamentarci di quanto sia difficile obbedire al comandamento di Cristo e quindi amare il prossimo come noi stessi. Ci sforziamo di aggirare la difficoltà a forza di abilità esegetica e di retorica, spiegando che amare non è necessariamente quello che pensiamo, che è già tanto fare del proprio meglio, volere il bene o non fare del male. E non mi spiego come mai, nel frattempo, ci occupiamo molto meno del nostro vero campo di attenzione, cioè lasciarci rivestire dell’abito nuziale, lasciarci amare, accogliere il Regno che ci è dato».
«Nella Chiesa - aggiunge Candiard, che si chiede come mai ci sia tanta difficoltà per i cristiani a parlare di grazia - spendiamo un sacco di energie, di omelie e conferenze a lamentarci di quanto sia difficile obbedire al comandamento di Cristo e quindi amare il prossimo come noi stessi. Ci sforziamo di aggirare la difficoltà a forza di abilità esegetica e di retorica, spiegando che amare non è necessariamente quello che pensiamo, che è già tanto fare del proprio meglio, volere il bene o non fare del male. E non mi spiego come mai, nel frattempo, ci occupiamo molto meno del nostro vero campo di attenzione, cioè lasciarci rivestire dell’abito nuziale, lasciarci amare, accogliere il Regno che ci è dato».Qui, Candiard affronta con efficace semplicità il tema della preghiera. Perché la preghiera è semplicità; è volgere l’attenzione a Dio che è nel nostro cuore «più intimo a me di me stesso», come dice Agostino (più volte citato da Candiard quale campione della teologia della grazia), lasciandosi aiutare dallo Spirito, anzi, lasciando che lui preghi per noi, come scrive san Paolo nella Lettera ai romani, perché «lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza e intercede per noi con gemiti inesprimibili» (8,26) e «per mezzo dello Spirito gridiamo “Abbà! Padre!”» (8,15). Estremo paradosso, per noi cristiani così poco avvezzi ad aprirci all’amore donato e alle cose autenticamente spirituali, scoprire, come anche Candiard, che Dio prega in noi. Perché, non solo lo Spirito è in noi, ma in noi «prega per farci pregare». Dio è nel nostro cuore che ci aspetta e cosa fa? Prega! E giunge incessantemente col suo Spirito a suscitare la nostra preghiera. Per il teologo domenicano è la Trinità che in noi mostra il suo volto: l’amore che si svela nell’amore. E allora: perché non lasciarsi amare?
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") --- FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA. Il cardinal Ravasi ricostruisce la “biografia” di Cristo (di Alessandro Zaccuri).29 ottobre 2021, di Federico La Sala
FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA: IL MESSAGGIO EVANGELICO, "IL FIGLIO DELL’UOMO", E IL "DIO AMORE", IL "DEUS CHARITAS"... *
Il nuovo libro di Ravasi. In parole e in opere: così si racconta Gesù
Il cardinal Ravasi ricostruisce la “biografia” di Cristo in una traversata della Scrittura che fa dell’Incarnazione un principio storico e interpretativo
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, mercoledì 27 ottobre 2021)
- [Foto] Giotto, ’L’ingresso a Gerusalemme’ - Padova, Cappella degli Scrovegni
Nessuno meglio del cardinale Gianfranco Ravasi conosce la complessità con la quale è chiamato a confrontarsi chi voglia ripercorrere la vicenda di Gesù. È una tradizione ricchissima, che risale perlomeno alla Vita Iesu Christi data alle stampe nel 1474 dal certosino Ludolfo di Sassonia, precoce best seller di età umanistica del quale si contano 88 edizioni. Ma anche prima, anche nella lunga stagione del Medioevo la storia del Figlio dell’Uomo era stata raccontata più volte, attraverso le immagini della Biblia Pauperum diffusa ovunque in Europa, nelle cattedrali più sfarzose come nelle più remote pievi di campagna. Per non parlare del Novecento, che è l’epoca di Giovanni Papini e di François Mauriac, di Norman Mailer e di José Saramago. Il «pensoso palpito» del Cristo di Ungaretti si percepisce chiaramente anche nel tempo dell’inquietudine e della secolarizzazione, secondo una traiettoria che lo stesso Ravasi ripercorre con la consueta precisione all’inizio di questa sua Biografia di Gesù. Secondo i Vangeli (Cortina, pagine 256, euro 19,00, in libreria dal 28 ottobre). A dispetto dell’apparente semplicità, titolo e sottotitolo meritano di essere esaminati con attenzione, perché comporre una biografia di Gesù “secondo i Vangeli” significa anche addentrarsi in una “biografia dei Vangeli”.
Forte della sua autorità di biblista, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura segue appunto questa strada, che è quella di un’esegesi tanto ragionata quanto appassionata. Non per niente, la “vita di Gesù” che più di ogni altra somiglia a questa di Ravasi è l’estroso Volete andarvene anche voi? di Luigi Santucci, uno scrittore che dello stesso Ravasi è stato amico e perfino complice sul piano spirituale e intellettuale. In quel libro, anziché ricondurre l’esistenza terrena di Cristo a uno schema narrativo, Santucci trasceglieva alcuni brani o versetti salienti e li commentava con la sua sensibilità di narratore e credente. Il metodo di Ravasi è un altro, ma risponde alla medesima logica di aderenza al testo.
C’è una biografia dei Vangeli, dicevamo, che coincide con la scoperta e con la valorizzazione della loro dimensione storica. Ravasi, com’è noto, non ha mai considerato come dato dirimente l’antichità del singolo frammento, preferendo insistere sul principio di storicità interna che preside alla struttura del canone neotestamentario, a sua volta convalidato dalle attestazioni di ambito profano (su tutte, il celebre dispaccio di Plinio il Giovane all’imperatore Traiano e la controversa ma comunque sintomatica menzione da parte di Giuseppe Flavio). Radicati nella storia, i Vangeli non sono tuttavia resoconti storici in senso stretto, ricorda Ravasi. Fin dal principio nel racconto della vita di Gesù gli elementi di cronaca si mescolano con l’interpretazione da parte della comunità dei discepoli, che in questo modo si fa partecipe dell’Incarnazione: proprio perché si è fatto uomo, Cristo può essere fatto oggetto di racconto; proprio perché è Dio, non può essere raccontato se non nella consapevolezza del mistero.
A rigore, la biografia dei Vangeli comincia fuori dai Vangeli stessi. Ravasi indica come punto germinale la dichiarazione di fede che, nella Pasqua dell’anno 57, Paolo riproduce nella Prima lettera ai Corinzi: «Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e fu sepolto. È risorto il terzo giorno secondo le Scritture e apparve a Cefa e quindi ai Dodici». La novità buona del kerygma si colloca qui, nell’indissolubilità tra Passione, Risurrezione e testimonianza proclamata dall’annuncio originario. Questo è anche il fuoco prospettico dell’intera Biografia di Gesù, nella quale Ravasi non si limita a passare in rassegna i quattro Vangeli, registrando le peculiarità di ciascuno dei Sinottici e argomentando la singolarità del testo di Giovanni.
L’aspetto più coinvolgente della sua Biografia di Gesù sta nell’individuazione dei grandi nuclei tematici che si ripresentando nelle sequenze narrative maggiori. Quelle riferite alla morte e Risurrezione, anzitutto, ma anche i racconti dell’infanzia, nei quali l’intonazione letteraria si fa più evidente, senza per questo inficiare la consistenza del fatto storico. Particolarmente convincente, fino a imporsi come l’aspetto più originale del libro, è la scelta di concentrarsi in modo specifico sulle due componenti essenziali del linguaggio di Gesù. La parola efficace delle parabole e il gesto eloquente dei miracoli sono indagati da Ravasi in capitoli carichi di spunti per la meditazione personale. «Le mani di Gesù - scrive tra l’altro l’autore - toccano ripetutamente carni malate, operano su persone sofferenti, s’intrecciano con le sue parole di speranza. Piaghe, organi paralizzati, corpi devastati o inerti sono ininterrottamente sotto l’azione di quelle mani».
Così come non comincia nei Vangeli, il racconto della vita di Gesù non si esaurisce in essi. A fianco del canone si situa infatti la lussureggiante biblioteca degli apocrifi, alla quale nel corso del tempo hanno attinto con larghezza artisti, poeti e narratori. Molte immagini alle quali siamo abituati e non poche figure fatte segno di devozione provengono da questa zona che Ravasi non manca di attraversare nelle ultime pagine del libro. Ancora una volta, si ritorna all’essenziale, ai giorni fatidici della condanna a morte e della Pasqua. Ripercorriamo così le peripezie di Pilato, che da personaggio storico diventa nella narrazione degli apocrifi esempio morale. E ci imbattiamo nella “correzione” più struggente, quella che nel Vangelo di Gamaliele rimedia al mancato incontro tra Gesù e la Madre. Episodio poi carissimo alla devozione popolare, a conferma di come la storia «di un Dio che si fa crocifiggere sul Golgota» (è la geniale sintesi di Borges) non smetta mai di essere raccontata.
* NOTARE BENE:
MESSAGGIO EVANGELICO E FIGLIO DELL’UOMO [nel senso di "Adamo" ed "Eva", di "Giuseppe" e "Maria"! - "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo [="Filius hominis" = "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου"] deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34=C.E.I.]).
LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO. Prima lettera ai Corinzi, 11, 1-3: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «aner, andròs - uomo»], e capo di Cristo è Dio" .
Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- "CLARITAS", UNA PAROLA BELLISSIMA CHE HA UNA SUA STORIA. Parla il professor Nicola Gardini (di Marta Vigneri).27 giugno 2021, di Federico La Sala
“Studiare il greco ed il latino porta felicità, vi spiego perché”: parla il professor Nicola Gardini
di Marta Vigneri ("TPI. The Post International", 25 Giu. 2021)
- [Foto] Immagine dell’autore
Dalla cattedra dell’Università di Oxford, dove è professore di letteratura italiana comparata, agli scaffali delle librerie, dove ha venduto decine di migliaia di copie con “Viva il latino, storia e bellezza di una lingua inutile” (Garzanti, 2016), “Viva il greco, alla scoperta della lingua madre” (Garzanti, 2021), “Elogio del latino. Una lingua da amare” (la Repubblica-GEDI, 2021) ed altri saggi dedicati alle lingue antiche, Nicola Gardini è uno degli studiosi che ha contribuito a diffondere, negli ultimi anni, il grido d’amore per il greco ed il latino, sempre più marginalizzate nelle Università italiane ma tornate in voga tra il pubblico non accademico grazie a best seller come il suo. Un salto che ha compiuto perché convinto che questi saperi “diano felicità e conforto”. A TPI ha spiegato perché.
Risale a cinque anni fa il boom della sua opera “Viva il latino”. Si aspettava questo successo?
No, è stata una bellissima sorpresa. Il successo non è stato soltanto del libro, ma del discorso che proponeva. Una riflessione critica, appassionata, ma non soltanto privata, perché il libro ha aperto un dibattito. Gli editori hanno cominciato ad interessarsi a questo tema, altri libri sono nati, io stesso ho continuato su questa linea capendo che quello che avevo fatto con il latino potevo farlo con altri libri. Oggi sono passato al greco, che conosco e che è parte di questo discorso, sebbene i pregiudizi che attaccano il latino non siano immediatamente trasferibili al greco. Questo perché è meno presente, è confinato ad una sola scuola, il liceo classico, e perché nell’immaginario collettivo è la lingua mitica, la lingua delle origini.
Si è più indulgenti verso il greco?
Sì, ma non solo: c’è una forma di fascino che forse il latino, imponendosi nel sistema educativo da secoli e sposandosi con la giurisprudenza e con la Chiesa, ha perso. È anche una questione di aura. Il greco mantiene qualcosa di libero, è associato all’idea di democrazia, di ginnastica, ha qualcosa di irrazionale. Del greco ci si invaghisce perché è una lingua un po’ erotica, ed ha creato una nostalgia secoli e secoli fa quando si è rannicchiato nella parte orientale dell’impero romano e lì è rimasto per lungo tempo fino a riemergere nel rinascimento e nell’umanesimo. Il greco è sempre visto come un ospite benvenuto, qualcuno che torna da lontano, che evoca un rispetto benevolo. Verso il greco non si ha quell’atteggiamento di fastidio e noia che purtroppo stupidamente molti hanno assunto verso il latino portandolo nel chiacchiericcio mediatico, che confonde solo le idee, perché qui si parla di istruzione e di quello che serve trasmettere alle future generazioni.
Possiamo dire che nel greco rintracciamo in modo più romantico le origini del nostro pensiero occidentale mentre la conoscenza del latino è stata al centro di polemiche perché considerata, anche dalla politica, elitaria?
Il latino si è compromesso con il potere mentre il greco è rimasto la lingua dell’individuo ragionante e curioso, dell’avventura. Se dici greco pensi immediatamente ad Odisseo, dicendo latino vengono in mente Cicerone, Virgilio, figure dell’ordine. Però questo è l’immaginario collettivo. Nei miei libri cerco di spiegare, senza pregiudizi, che li leggiamo non perché sono dei geni, ma perché la lingua grazie a loro procede in direzioni artistiche, intellettuali. Ed è questo che interessa: si può chiamare Saffo, Platone, Demostene, in ognuno di questi succede qualcosa di miracoloso, cioè la lingua scopre pensieri, idee, metafore. È molto importante poi il nesso tra lingua e verità, lingua ed immaginazione: il greco questo lo ha fatto molto prima del latino. Pensiamo all’Odissea, in cui si assiste ai fatti della vita e poi ci sono i poeti che la cantano. Il greco è la lingua della grande immaginazione che entra in rapporto con la realtà dei fatti, con le esperienze vissute e le éleva eroicamente, filosoficamente, linguisticamente. Ed è anche, come ha suggerito, l’origine del pensiero, dell’investigazione: per questo il mio libro sul greco si intitola “Alla ricerca della lingua madre” perché c’è dietro l’idea di un inizio.
Perché invece anche il latino è una lingua utile?
L’utilità del latino sta nella sua necessità formativa, si tratta di storia e memoria della nostra cultura e del nostro essere. Eliminare questi studi e chiamarli marginali o elitari è un torto che si fa alla costruzione del sapere storico. Sarebbe lo stesso che dire: niente filosofia o niente musica. Ridurre tutto all’applicazione immediata non significa andare avanti, ma fermare lo sviluppo della nostra mente. Le società hanno bisogno di conoscersi profondamente, e lo studio di queste lingue serve a farci capire che l’attualità non è il presente, il presente è fatto di passato, e che la tecnologia non è scienza: la scienza è fatta di interpretazione, come il latino e il greco. C’è un’utilità anche spirituale: farci sentire parte di un lungo cammino e traiettoria dove il latino e questi testi, la loro penetrazione e diffusione hanno determinato i nostri linguaggi, comportamenti mentali, metafore, il senso della nostra vita. Togliere il latino significa darci un alzheimer sociale.
Da ragazzo scrisse un libro violento sull’università italiana, spiegando perché era fuggito per proseguire la carriera all’estero. C’è un nesso con la marginalizzazione delle lingue antiche?
Il nesso tra i miei interessi per il latino e per il greco e il mio disgusto dell’università italiana c’è, perché io credo nella parola libera, nell’intelligenza, nel dialogo, che sono grandi temi del greco. Questo nelle università è difficile che accada, perché il sistema di reclutamento è molto personalistico, crea zone di potere e non un sistema per i migliori. Io me ne andai perché non mi trovavo bene in una mentalità baronale e corrotta, che fa male a chi cerca di entrare e non ci riesce, fa male agli studenti. Il discorso è complesso, recentemente i giornali hanno detto che non bisogna sparare sempre a zero, ma in realtà il sistema di assunzione va sistemato perché non è fatto per la libera circolazione degli intelletti.
Come si passa dal lavoro accademico alla scrittura di un best seller?
Io sono un accademico strano, sebbene lavori per una università molto solida, quella di Oxford. Anche quando scrivo per l’Università evito il gergo specialistico, obbedisco ad una scrittura personale che certo spesso si scontra con criteri molto conformistici. Dal lavoro accademico ho imparato il rigore e a trattare un po’ tutto il mondo come un’Università, che per me non sta soltanto negli edifici. C’è un’università di lettori che ha voglia di conoscere molte cose che magari normalmente sono riservate all’accademia. Parlo a questa università più grande, lo faccio con una lingua semplice, chiara, diretta ma anche molto personale. I miei libri sono un impegno che mi sono preso con me stesso, per comunicare il più possibile. Sono convinto che questi saperi diano felicità, conforto, stimolo ad andare avanti. Non danno risposte ma pongono moltissime domande, e questo ci aiuta a credere nel futuro.
Tra le sue opere dedicate alle lingue antiche compare “Dieci parole latine che raccontano il nostro mondo”: se dovesse sceglierne una, su quale consiglierebbe di soffermarsi?
Claritas, la chiarezza, una parola bellissima che ha una sua storia. La chiarezza non è un punto di partenza ma di arrivo, è una delle più grandi costruzioni perché richiede un apprendistato alla verità, all’ordine, ai pensieri e all’efficacia del ragionamento. La chiarezza ce l’ha chi scrive tanto, chi studia tanto e arriva a capire il modo più diretto e più rapido per attraversare il groviglio, anche rispetto alla conoscenza di sè.
-
> DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO. --- "En finir avec le cléricalisme": Finiamola con il sistema clericale. Un libro di Loïc de Kerimel (di Andrea Lebra).7 aprile 2021, di Federico La Sala
Recensione
Finiamola con il sistema clericale
di Andrea Lebra *
- Serrata l’argomentazione con la quale il filosofo e teologo francese Loïc de Kerimel affronta la radice malata del clericalismo ecclesiastico nel suo En finir avec le cléricalisme (Seuil, 2020).
È un libro che in Francia sta riscuotendo notevole successo. Esso affronta di petto e in modo meticoloso e documentato una delle questioni che stanno particolarmente a cuore a papa Francesco: come prevenire, contrastare e superare nella Chiesa quel «brutto male che ha radici antiche» (meditazione mattutina del 13 dicembre 2016) costituito dal clericalismo, «modo anomalo di intendere l’autorità nella Chiesa» e «atteggiamento che non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale» posta dallo Spirito Santo nel loro cuore (Lettera al popolo di Dio del 20 agosto 2018).
Il saggio (Edizioni du Seuil, aprile 2020) è intitolato En finir avec le cléricalisme. Lo ha scritto Loïc de Kerimel, padre di quattro figli e nonno di sei nipoti, fratello del vescovo di Grenoble-Vienne, Guy de Kerimel, apprezzato docente di filosofia per quasi trent’anni in un liceo di Le Mans, acuto teologo, assiduo lettore delle opere di uno dei più autorevoli teologi francesi, il gesuita Joseph Moingt deceduto ultracentenario il 28 luglio 2020.
Cofondatore dell’associazione Chrétiens en marche per una presenza attiva e responsabile del laicato nella Chiesa, particolarmente impegnato nell’ambito della Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones per una riforma profonda della Chiesa, Loïc de Kerimel ha anche un ruolo particolarmente attivo nell’Amitié judéo-chrétienne de France, associazione che ha come obiettivo quello di favorire il dialogo tra cristiani ed ebrei.
Radici culturali del clericalismo
Preceduto da una bella prefazione di Jean-Louis Schlegel, redattore di Esprit, la rivista fondata nel 1932 da Emmanuel Mounier, En finir avec le cléricalisme ha il merito di andare alle radici teoriche e culturali del clericalismo, una malattia cronica di cui soffre il cristianesimo dalla fine del secondo secolo dell’era cristiana. Pubblicato nell’aprile 2020, poco dopo la morte prematura dell’autore, può essere considerato come un suo testamento spirituale.
Intento di Loïc de Kerimel non è tanto quello di stigmatizzare le forme devianti del clericalismo nella Chiesa sfociate - come ha affermato papa Francesco nella Lettera al popolo di Dio del 20 agosto 2018 - negli abusi sessuali, di potere e di coscienza, quanto piuttosto quello di evidenziarne il carattere sistemico.
Quest’ultimo è individuato dall’autore nel fatto che si siano introdotte e reiterate in seno al “popolo di Dio” le categorie della separazione (clero/laici, uomini/donne, puro/impuro), della gerarchizzazione (vescovi/presbiteri/diaconi/religiosi/fedeli), dell’emarginazione della donna e della sacralizzazione di una persona mediante l’imposizione delle mani che crea le condizioni per sentirsi parte di una casta (quella “sacerdotale”) detentrice di competenze e di attribuzioni esclusive ed escludenti.
Il carattere sistemico di quello che papa Francesco denuncia come «un modo non evangelico» di concepire il ruolo ecclesiale del presbitero (discorso del 6 ottobre 2018 ai pellegrini della Chiesa greco-cattolica slovacca) o come «una caricatura e una perversione del ministero» del vescovo (discorso del 24 gennaio 2019 ai vescovi centroamericani), ovvero ancora come «un pericolo dal quale devono guardarsi anche i diaconi» (discorso del 25 marzo 2017 ai preti e ai consacrati in occasione della visita apostolica a Milano), viene sviscerato percorrendo dapprima la storia dei primi secoli della Chiesa.
Configurazione gerarchico-sacrificale del sistema clericale
Secondo Loïc de Kerimel, all’origine del clericalismo vi è un processo di sacralizzazione della funzione del presbiterato che, a partire dalla fine del terzo secolo, la Chiesa nascente ha mutuato dalle strutture centralizzatrici della tribù giudaica dei Leviti. Il ceto sacerdotale costituirebbe una casta depositaria di poteri divini implicante una differenza non solo di grado, ma di natura tra il clero e i laici. Rispetto alla generalità delle persone battezzate, il clero sarebbe depositario di una superiorità religiosa derivante dal sacramento dell’ordine.
Paradossalmente, mentre la religione ebraica, con la sostituzione del tempio con la sinagoga, del rabbinato con il sacerdozio e del sistema sacrificale con lo studio della Torà, si trova di fatto, dopo la distruzione del Tempio nell’anno 70 d.C., desacralizzata e desacerdotalizzata, la Chiesa si struttura secondo categorie levitiche, come l’istituzione del sommo sacerdote (cioè del vescovo), la distinzione sacerdoti/laici, l’esclusione delle donne, la concezione sacrificale del culto e la reintroduzione dello “spazio sacro” interamente ad esso dedicato e accessibile solo al clero.
L’autore, al riguardo, cita la formula lapidaria usata da Joseph Moingt nella sua opera Esprit, Église et monde - De la foi critique à la foi qui agit, Éditions Gallimard, Paris 2016, p. 216: l’Antico Testamento fondato sulla legge ha sopraffatto il Nuovo fondato sull’amore vicendevole (p. 29).
All’inizio non era così
Quindici i capitoli del libro distribuiti in tre parti. La prima (capitoli da 1 a 6) prende in esame la nascita del «sistema clericale», in contrasto con l’insegnamento di Gesù e con la vita delle prime comunità cristiane. L’elemento più problematico del processo che lungo la storia ha subìto il ministero ordinato - vissuto oggi concretamente nei distinti ruoli del vescovo, del presbitero e del diacono - è l’assunzione di un forte carattere sacrale e sacerdotale, che all’inizio gli era completamente estraneo.
Significativo che gli scritti neotestamentari, compresi gli apocrifi, concordino nell’attribuire a Gesù una discendenza genealogica che non ha nulla a che fare con la tribù di Levi, escludendolo così in radice dall’appartenenza al ceto sacerdotale.
A proposito di Gesù - e dei suoi apostoli - i Vangeli non parlano mai di sacerdozio. Tanti i titoli a lui attribuiti (Maestro, Profeta, Figlio di Davide, Figlio dell’uomo, Messia, Signore, Figlio di Dio), ma mai quello di Sacerdote o di Sommo sacerdote (p. 45).
«Leggendo i testi delle origini cristiane, ci si può rendere conto che nessun apostolo e nessun’altra persona si separa dalla comunità in virtù di un carattere sacro, o si comporta in quanto ministro di un culto nuovo o compie atti specificamente rituali. Si può osservare che non c’è alcuna distinzione tra persone consacrate e non consacrate... Non ci sono spazi occupati da un’istituzione sacerdotale». Lo scrive Joseph Moingt (in: Dieu qui vient à l’homme, t. 2/2, Les Éditions du Cerf, Paris 2008, p. 842), il teologo spesso richiamato da Loïc de Kerimel.
Ad essere indelebile nell’ambito del «santo popolo fedele di Dio» - scrive l’autore - è la condizione comune dei battezzati e delle battezzate alla quale tutto, compreso l’esercizio dell’autorità, è subordinato (p. 41).
È quanto emerge dalle Scritture ed è ciò che il concilio Vaticano II ha affermato in modo autorevole: prima del ministero ordinato, prima cioè del «sacerdozio ministeriale» del vescovo, del presbitero e del diacono, vi è la condizione comune di tutti i credenti in virtù del battesimo, significativamente definita «sacerdozio comune». Ed è ciò che, purtroppo, a livello pratico e diffuso, per il momento non pare essere stato recepito dalla Chiesa, anche se fa ben sperare l’insistenza di papa Francesco nel rimettere al centro il battesimo come base ineludibile della vita cristiana.
Detto in altri termini con riferimento al presbiterato, è dal battesimo che si origina non il “potere” su una comunità di credenti, ma il “servizio” ad essa. Il sacramento dell’ordine non sacralizza la persona sulla quale vengono imposte le mani, ma ne radicalizza piuttosto la vocazione battesimale.
Il clericalismo: un problema la cui soluzione non è dietro l’angolo
Nella seconda parte del suo saggio (capitoli da 7 a 11), l’autore si sofferma sull’evoluzione e sul rafforzamento del sistema clericale nel corso della storia della Chiesa.
Stigmatizzando i legami tra la violenza e il sacro a partire dagli studi di René Girard (p. 143), egli rilegge la Riforma di Lutero e il Concilio di Trento che ha accentuato la dimensione sacrificale dell’eucaristia e della sacralità della figura del prete, mettendo decisamente in ombra la centralità del fondamento battesimale che accomuna tutti i credenti.
Per quanto riguarda i nostri tempi, non nasconde la sua delusione in presenza del fenomeno della riclericalizzazione galoppante presente in alcuni ambiti ecclesiali e che sembra interessare soprattutto i «preti della generazione Giovanni Paolo II» che nutrono la nostalgia «di un sacro inglobante che esonera il singolo individuo dalla responsabilità di vivere e di pensare» (p. 197).
Il che lo induce a prendere atto che il sistema clericale sembra avere ancora un futuro decisamente roseo, anche perché a volere preti clericali sono numerose e potenti famiglie di affiliati appartenenti per lo più a categorie socioprofessionali elevate (p. 198). Presbiteri, non sacerdoti!
Nella terza parte (capitoli da 12 a 15) Loïc de Kerimel cerca di rispondere alla domanda se oggi sia possibile, da parte della Chiesa, uscire dal clericalismo concretizzando l’ideale cristico (p. 64) dell’uguaglianza di tutte le persone battezzate in ragione della medesima dignità cristiana proclamata certamente dal concilio Vaticano II, ma in modo non del tutto privo di equivoci.
L’autore cita al riguardo Gilles Routhier, uno dei più autorevoli storici del concilio Vaticano II, il quale ritiene che, a cinquant’anni dal Vaticano II, la prospettiva decisamente rivoluzionaria di considerare il tema del «popolo di Dio» prioritario rispetto alla costituzione gerarchica della Chiesa è rimasta a livello di pio desiderio.
In particolare, quanto all’immagine del ministro ordinato, il docente canadese di ecclesiologia ritiene che il Concilio si sia trovato davanti due prospettive: l’una, tradizionale, che parte dallo nozione di sacerdote - sul modello del “sacrificatore” delle religioni tradizionali, del greco hiéreus e dell’ebraico cohen -; l’altra, attestata nel Nuovo Testamento, basata sull’idea di presbiterato - lo statuto dell’anziano, dell’uomo (o della donna?) che, per esperienza maturata, è in grado di esercitare l’arte del discernimento e di contribuire a risolvere conflitti, dimostrando così di avere titolo per prendersi cura della comunità affidatagli, per dare il proprio contributo alla vita dei credenti in un servizio generoso e appassionato, per presiedere il culto.
Secondo Gilles Routhier, il Concilio ha scelto la seconda prospettiva e, conseguentemente, utilizza il termine presbitero là dove il concilio di Trento usa quello di sacerdote.
Citando, poi, Yves Congar, Routhier aggiunge che non solo il termine sacerdote non è biblico, ma che esso privilegia indebitamente, tra le tre funzioni attribuite a Cristo (sacerdotale, profetica, regale), quella sacerdotale a detrimento delle altre due.
Trattandosi di presbiteri, il loro ministero sacerdotale, cioè la celebrazione dell’eucaristia e dei sacramenti, non è che una delle dimensioni del loro ministero presbiterale. Quest’ultimo è in primo luogo ministero dell’evangelizzazione e del governo. La celebrazione dell’eucaristia non monopolizza la definizione di chi è e cosa fa il prete (p. 204).
Nessuna ineguaglianza in Cristo e nella Chiesa
Il riconoscimento - quanto a nazionalità, condizione sociale o sesso - della «eguale dignità in Cristo e nella Chiesa» (Lumen gentium 32 a commento di Gal 3,28) delle persone battezzate e la conseguente fine del «dominio maschile» costituiscono la condizione sine qua non sia della possibilità di uscita dalla crisi che attanaglia la Chiesa dopo gli scandali in tema di abusi sessuali, di potere e di coscienza, sia più semplicemente della fedeltà all’Evangelo (p. 229).
La radicale uguaglianza di tutti i membri del «popolo di Dio» senza discriminazioni di nazione, di condizione sociale o di sesso non annulla le differenze di funzioni, ma fa sì che l’esercizio di queste ultime non generi scissioni nel corpo ecclesiale, allontani ogni forma deviante di autoritarismo e, nello stesso tempo, valorizzi diversità e complementarietà dei carismi (cf. 1Cor 12) a servizio del bene comune (p. 257).
Soprattutto, «si potrà parlare - afferma l’autore - di uscita dal sistema clericale solo il giorno in cui a nessuna donna sarà impedito di esercitare le funzioni di governo, di insegnamento e di culto» riservate oggi ai maschi. Ma aggiunge anche che, prima di pensare di aprire alle donne la possibilità di accedere al ministero presbiterale, è necessario desacralizzarlo e desacerdotalizzarlo, evitando di strutturarlo secondo un rigido e discriminante ordine gerarchico (p. 241).
Mettere fine all’esclusione delle donne dovuta al sistema clericale dimostrerebbe davvero che, con Gesù di Nazaret, si è passati dal sacro al santo, da una concezione elitaria di salvezza alla convinzione che Dio si dona immediatamente a tutti e a tutte senza escludere nessuno (p. 244).
* Fonte: Settimana News, 23 novembre 2020 (ripresa parziale).
-
> DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO. -- Con Dante (e Ponzio Pilato), rimeditare sui "due Soli" e sull’amor "ch’a lor s’intrea" (Paradiso, XIII, 57).9 febbraio 2021, di Federico La Sala
-
> DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO. --- SPIRITUS DOMINI. Con il motu propio, Papa Francesco primo paragrafo del canone 230 del Codice di Diritto canonico.13 gennaio 2021, di Federico La Sala
Papa. «Le donne accedano ai ministeri del lettorato e dell’accolitato»
Con un motu proprio Francesco abroga la limitazione dell’accesso ai due ministeri istituiti ai laici maschi. Nessuna relazione con il sacerdozio. Riconoscimento del contributo femminile all’annuncio
di Mimmo Muolo (Avvenire, lunedì 11 gennaio 2021)
Le donne potranno accedere da ora in poi ai ministeri del lettorato e dell’accolitato nella Chiesa Cattolica. Senza che però questo debba essere confuso con una sia pur parziale apertura verso l’ordinazione sacerdotale. -Con il motu proprio “Spiritus Domini”, infatti, il Papa ha modificato il primo paragrafo del canone 230 del Codice di Diritto canonico, stabilendo che le donne possano accedere a questi ministeri (la lettura della Parola di Dio durante le celebrazioni liturgiche o lo svolgimento di un servizio all’altare, come ministranti - chierichette o come dispensatrici dell’eucaristia), che essi vengano attribuiti anche attraverso un atto liturgico che li istituzionalizza. Nella nuova formulazione del canone si legge ora: “I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti”. Viene così abrogata la specificazione “di sesso maschile” riferita ai laici e presente nel testo Codice fino alla modifica odierna.
Francesco tuttavia specifica che si tratta di ministeri laicali “essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con il sacramento dell’ordine”. E in una lettera indirizzata al Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Luis Ladaria, cita le parole di san Giovanni Paolo II secondo cui “rispetto ai ministeri ordinati la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale”.
 Per i ministeri non ordinati come il letterato e l’accolitato, però, "è possibile, e oggi appare opportuno - sottolinea il Pontefice -, superare tale riserva”. Il Papa spiega che “offrire ai laici di entrambi i sessi la possibilità di accedere al ministero dell’Accolitato e del Lettorato, in virtù della loro partecipazione al sacerdozio battesimale incrementerà il riconoscimento, anche attraverso un atto liturgico (istituzione), del contributo prezioso che da tempo moltissimi laici, anche donne, offrono alla vita e alla missione della Chiesa”.
Per i ministeri non ordinati come il letterato e l’accolitato, però, "è possibile, e oggi appare opportuno - sottolinea il Pontefice -, superare tale riserva”. Il Papa spiega che “offrire ai laici di entrambi i sessi la possibilità di accedere al ministero dell’Accolitato e del Lettorato, in virtù della loro partecipazione al sacerdozio battesimale incrementerà il riconoscimento, anche attraverso un atto liturgico (istituzione), del contributo prezioso che da tempo moltissimi laici, anche donne, offrono alla vita e alla missione della Chiesa”.Già da tempo, infatti, in moltissime chiese le donne leggono durante le celebrazioni e le bambine (soprattutto) svolgono il servizio di ministranti. Tuttavia questi ruoli venivano svolti, come ricorda anche Vatican News, senza un mandato istituzionale vero e proprio, in deroga a quanto stabilito da san Paolo VI, che nel 1972, pur abolendo i cosiddetti “ordini minori”, aveva deciso di mantenere riservato l’accesso a questi ministeri alle sole persone di sesso maschile perché li considerava propedeutici a un eventuale accesso all’ordine sacro.
Francesco, invece, recepisce quanto richiesto anche da diversi Sinodi dei vescovi e menzionando il documento finale del Sinodo per l’Amazzonia osserva come “per tutta la Chiesa, nella varietà delle situazioni, è urgente che si promuovano e si conferiscano ministeri a uomini e donne... È la Chiesa degli uomini e delle donne battezzati che dobbiamo consolidare promuovendo la ministerialità e, soprattutto, la consapevolezza della dignità battesimale”.
Ministero istituito, non ordinato
Come sottolinea il Papa nella Lettera che accompagna il motu proprio, al cardinale Ladaria Ferrer prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, il lettorato e l’accolitato sono ministeri “istituiti”, cioè affidati con atto liturgico del vescovo, dopo un adeguato cammino, «a una persona che ha ricevuto il Battesimo e la Confermazione e in cui siano riconosciuti specifici carismi». Sono altro rispetto ai ministeri “ordinati”, che hanno invece origine in uno specifico Sacramento: l’Ordine sacro. Si tratta dei ministeri ordinati del vescovo, del presbitero, del diacono.
- Leggi anche
- Motu Proprio. Così il Papa riconosce ruolo essenziale e servizio reso dalle donne.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
L’"UOMO SUPREMO" DELLA CHIESA CATTOLICA:"Dominus Iesus": RATZINGER, LO "STERMINATORE DI ECUMENISMO". Un ’vecchio’ commento del teologo francescano Leonard Boff.
LO SPIRITO DI ASSISI. LA LEZIONE DI GIOVANNI PAOLO II SULLA DONNA E SULL’UOMO E SU DIO: Karol J. Wojtyla ha compreso il "segreto" delle due persone che gli hanno dato la vita (il padre di religione cattolica e la madre di religione ebraica) e, al di là della loro identità e differenza, ha ritrovato l’Arca dell’Alleanza d’Amore ("Charitas") dei "due cherubini". Per questo ha potuto ri-illuminare il mondo e ri-unificare l’intera umanità intorno a sé, non per altro e non - confondendo Dio-Mammona ("caritas") con Dio-Amore ("charitas") - per negare e uccidere addirittura l’Altro!!! (Federico La Sala, 08.02.2008).
FLS
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") --- "Diccionario de Autoridades" (Tomo II, 1729).8 marzo 2020, di Federico La SalaCHARIDAD. s. f. Virtud Theologál, y la tercera en el orden. Hábito infuso, qualidad inherente en el alma, que constituye al hombre justo, le hace hijo de Dios, y heredero de su Gloria. Viene del Griego Charitas. Pronúnciase la ch como K: y aunque se halla freqüentemente escrito sin h, diciendo Caridád, debe escribirse con ella. Lat. Charitas. PARTID. 1. tit. 5. l. 42. La primera Charidád, que quiere tanto decir como amor de Dios mäs que de otra cosa, è de sí, è de su Christiano. NIEREMB. Aprec. lib. 1. cap. 1. El Angélico Doctor con mäs acierto dice, que aunque no es el mismo Dios, ni es infinita la Charidád, hace efecto infinito, juntando al alma con Dios. CORNEJ. Chron. lib. 1. cap. 38. Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád ("Diccionario de Autoridades" - Tomo II, 1729).
-
> DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO. --- E uscire dall’orizzonte dell’immaginario "cosmoteandrico" costantiniano.3 gennaio 2020, di Federico La Sala
“DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” (COSMOLOGIA, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA!) DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINANA... *
- Nota di commento a margine di "De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò" (cfr. "Fondazione Terra d’Otranto", https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/#comment-257181)
CARDINALE CASTRILLON HOYOS: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio”(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
PAPA FRANCESCO: “«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]” (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200101_omelia-madredidio-pace.html)
*
A) - La costruzione del ’presepe’ cattolico-romano .... e la ’risata’ di Giuseppe!!!
 MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;B) Il magistero della Legge dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti non è quello di “Mammona” (“Deus caritas est”, 2006)! EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA “NON CLASSIFICATA”!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907.
C) GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di “pensare un altro Abramo”.
Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") --- 6 DICEMBRE 2019: VERSO NICEA 325 O VERSO "NICEA 2025"?! VERSO "BARI 2020"!6 dicembre 2019, di Federico La Sala
VERSO "BARI 2020", "NICEA 2025": MESSAGGIO EVANGELICO, FILOLOGIA, ED ECUMENISMO. Quale "carità" (Kapitas o Xapitas, caritas o charitas)?! *
Nicola. Protettore del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente
di Matteo Liut (Avvenire, giovedì 6 dicembre 2018)
La carità è il "miracolo" più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313.
Difensore dell’ortodossia, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. La tradizione gli attribuisce un’attenzione particolare nei confronti dei bisognosi, come le due giovani ragazze che poterono sposarsi solo grazie al dono da parte del vescovo di una dote. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 le sue reliquie arrivarono a Bari, dove è venerato come patrono e considerato un protettore anche del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente.
 Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
 Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
 Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.*
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
Commenti a Presicce, il suo patrono Sant’Andrea e la tela del suo martirio, opera del Catalano (Fondazione Terra d’Otranto).
- CHARITÉ: BERLINO RICORDA A PAPA RATZINGER IL NOME ESATTO DELL’ OSPEDALE E DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA.
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.Federico La Sala
-
> A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO --- Le categorie arcaiche del sacrificio del nuovo "Agnello" e una lettura della Passione come "prezzo"!30 ottobre 2019, di Federico La Sala
IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT.... *
Botta e riposta.
Cristo ci rivela che l’espiazione non è prezzo, ma sinonimo di perdono
La croce del Figlio è il ’luogo’ dove Dio Padre dà risposta d’amore all’amore fedele estremo. E io resto convinto che una lettura della Passione come prezzo della salvezza rischia di allontanarci ...
di Luigino Bruni (Avvenire, mercoledì 30 ottobre 2019)
- [Foto] Deposizione di Cristo Caravaggio
- Gentile direttore,
- ho letto con interesse l’articolo di Luigino Bruni su “Avvenire” di domenica 27 ottobre. Ho alle spalle una formazione religiosa “meritocratica” ed “espiatoria”, verso la quale in verità, sento una profonda ribellione. Ma mi chiedo: il sacrificio espiatorio del sangue di Cristo «per riconciliare al Padre tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli». (Col 1,20) era necessario?. Se non era necessario, che senso ha, dunque, la Passione? Vorrei invitare il professor Bruni ad aiutarmi a capire. Grazie.
- Maria Carla Pilloni Piasco (Cn)
Cara signora Maria Carla, a proposito della teologia dell’espiazione ho scritto più volte in questi anni su “Avvenire”. In sintesi: nel Nuovo Testamento, compreso Paolo, si usa l’immagine del sangue e del riscatto pagato dal figlio, ma è solo un’immagine e sempre presa in prestito dall’Antico Testamento.
Se guardiamo il messaggio generale che emerge nei Vangeli sulla Passione di Cristo, non abbiamo elementi per pensare che il Padre abbia voluto la morte del Figlio come prezzo della salvezza.
Ormai la maggior parte degli esegeti, soprattutto dopo il Vaticano II è concorde nel leggere la Passione come fedeltà estrema del Figlio al suo compito che lo ha portato a una morte cruenta, non voluta né dal Padre né da Lui, ma accettata come conseguenza dell’incarnazione e della cattiveria degli uomini.
Poi una certa teologia, soprattutto medioevale, e anche alcuni Padri hanno voluto leggere il sacrificio del Cristo (sulla base di testi Neotestamentari, tra cui la lettera agli Ebrei), con le categorie arcaiche del sacrificio del nuovo Agnello etc. Anche la lettera ai Colossesi (che, come saprà, secondo gran parte degli studiosi non sarebbe di Paolo, ma di un suo discepolo) si muove nel passaggio che lei cita in questa stessa tradizione. Anche le preghiere liturgiche, soprattutto quelle della Settimana Santa, risentono di queste letture dell’espiazione, nella versione che ne ha dato Anselmo d’Aosta, la cosiddetta “Satisfactio”: il Padre era così adirato con gli uomini che solo il sangue del Figlio lo poteva soddisfare.
Inoltre, per la parola espiazione, bisogna stare attenti al significato. Quello normale è essere punito per riparare un male e placare l’ira divina. Ma nella Bibbia, quasi sempre il soggetto del verbo espiare è Dio, non il peccatore; ed espiare è praticamente sinonimo di perdonare. È Dio che espia, non l’uomo. Vedi per esempio Rm 3,25: Dio non ha esposto Gesù per espiare cioè punirlo al nostro posto e così placare la sua ira o ricevere soddisfazione, ma Dio è il soggetto che procura espiazione mediante la morte di Gesù, cioè concede il perdono; la Croce è vista come il “luogo” dove Dio dà il perdono, come risposta d’amore all’amore fedele estremo.
Resto convinto che una lettura della Passione come prezzo ci allontana dalla novità del Cristianesimo, ci dà una idea di Dio molto più vicina a Mardok e a Baal che al Dio Amore di Gesù o al Padre Misericordioso delle Parabole e fino a tempi recenti ci ha impedito di comprendere le pagine più belle della Bibbia e dei Vangeli. Grazie a lei per la sua lettera.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- RENE’ GIRARD INSISTE: DIO NON E’ VIOLENTO. MA CONFONDE IL PADRE NOSTRO (DEUS CHARITAS EST) CON IL DIO DEL CATTOLICISMO PLATONICO-ROMANO DI RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006) E RICADE NELLE BRACCIA DI "MAMMASANTISSIMA".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO. --- "AMORE E RESPONSABILITÀ". LA LEZIONE DI CARLO WOJTYLA (Marietti, 1968)12 ottobre 2019, di Federico La Sala
Polonia. Beati i genitori di Wojtyla? I vescovi chiedono di aprire la causa
Emilia Kaczorowska morì quando il futuro pontefice aveva solo 9 anni. Il padre di Wojtyla, anch’egli di nome Karol, morì invece nel 1941, durante la Seconda guerra mondiale
di Redazione Catholica (Avvenire, venerdì 11 ottobre 2019)
- [Foto] I genitori di Wojtyla e il piccolo Karol
Nel corso della 384ª plenaria dell’episcopato polacco (8-9 ottobre) i vescovi hanno discusso diversi aspetti delle celebrazioni del 100° anniversario della nascita di Karol Wojtyla che cadrà il 18 maggio 2020. L’arcidiocesi di Cracovia ha ottenuto così da parte della Conferenza episcopale, come riporta l’agenzia Sir, l’assenso a rivolgersi alla Santa Sede per il nulla osta all’istruzione a livello diocesano del processo di beatificazione dei genitori di Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla e Emilia Kaczorowska.
«Non c’è il minimo dubbio che la spiritualità del futuro santo pontefice si sia formata in famiglia e grazie alla fede dei suoi genitori», ha osservato il cardinale Stanislaw Dziwisz, già segretario particolare di Giovanni Paolo II. Il porporato si è detto convinto che «i genitori del Papa polacco possano diventare un valido esempio per le famiglie moderne» e ha ricordato che papa Francesco, durante la cerimonia di canonizzazione ha conferito a Wojtyla proprio il titolo di «Papa delle famiglie».
 Emilia Kaczorowska morì quando il futuro pontefice aveva solo 9 anni. Il padre di Wojtyla, anch’egli di nome Karol, morì invece nel 1941, durante la Seconda guerra mondiale.
Emilia Kaczorowska morì quando il futuro pontefice aveva solo 9 anni. Il padre di Wojtyla, anch’egli di nome Karol, morì invece nel 1941, durante la Seconda guerra mondiale.L’episcopato polacco, nel corso della plenaria ha inoltre appoggiato l’idea che Giovanni Paolo II diventi patrono della riconciliazione tra polacchi e ucraini, necessaria in seguito ai terribili crimini commessi durante l’ultimo conflitto mondiale. La «teologia del dialogo, della riconciliazione e del perdono» promossa dal Papa polacco «in base ai valori del Vangelo» ha permesso ad entrambi i popoli “di compiere dei passi importanti sulla strada della reciproca comprensione”, concordano i vescovi.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Chiesa ed Eucharistia. Il comandamento dell’amore e la norma personalistica ....
 Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)!!!
Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)!!!INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") --- Un canto del cigno triste e inopportuno (di Marcello Neri)15 aprile 2019, di Federico La Sala
A proposito del documento con cui Ratzinger si congeda dalla Chiesa
Un canto del cigno triste e inopportuno
di Marcello Neri (Il Mulino, 15 aprile 2019)
Inadeguato e inopportuno, così è il recente testo di Ratzinger sulla genesi sociale e culturale degli abusi nella Chiesa cattolica. Inadeguato non solo rispetto al tema che si vuole trattare, ma anche alla logica interna che si vorrebbe perseguire. Un affastellarsi di frasi, memorie personali, giudizi, osservazioni, senza un principio argomentativo che renda coerente l’impianto. Inopportuno per i tempi, le maniere, gli esiti prodotti.
Dalla storia, in cui a diritto l’aveva fatto entrare la scelta spirituale delle sue dimissioni da pontefice romano, Ratzinger ha iniziato a uscire quasi subito dopo: troppa devota obbedienza nominale al successore e troppe parole che andavano in altra direzione.
Ratzinger, volente o nolente, ha contribuito ad alimentare il mito di un «doppio» canonicamente e teologicamente mai esistito, reso possibile solo dalla logica mediatica e dalla perfidia di coloro che hanno piegato a essa il lento declino di un uomo che per mezzo secolo ha avuto in mano le sorti della Chiesa cattolica. Fino al punto di dover riconoscere, in un momento di folgorante obbedienza ecclesiale, di non esserne stato all’altezza.
L’ultimo scritto è quello di un uomo solo con i suoi demoni e i suoi conti da regolare, senza un amico che lo consigli saggiamente di tenere per sé le annotazioni su cui è stata costruita una vera e propria campagna di delegittimazione della Chiesa cattolica (dal Vaticano II all’analisi delle ragioni strutturali da parte di Francesco degli abusi sessuali).
Non solo, ma anche lo scritto di un uomo usato da amici privi di quel rispetto e di quella devozione con i quali, come Bibbia e sapienza popolare ci insegnano, dobbiamo circondare il tempo finale dei nostri vecchi. L’ethos uscito dal Sessantotto sarà traballante, finanche scanzonato e ignaro del prezzo che avrebbe fatto pagare alle generazioni future. Ma l’ethos che ha fatto di una «senile» prova di Ratzinger un piano di battaglia per imbrattare i muri del Vaticano II e ostacolare ancora una volta il percorso intrapreso dalla Chiesa sotto la mano severa di Francesco non è altro che il risentimento della rivalsa per il potere perduto.
Entrare nel merito dell’articolo di Ratzinger è quasi imbarazzante. Mi chiedo, d’altro lato, se si possa assistere inermi all’autodistruzione di una mente che ha fatto della propria personale visione del cristianesimo lo schema di base dell’ortodossia cattolica a livello globale.
Agghiacciante la parte che elabora le ragioni della dimissione dallo stato clericale dell’abusatore comprovato. Il crimine lede la fede dogmatica e per questa ragione deve essere perseguito in maniera implacabile. Le vittime nel testo di Ratzinger non esistono, ridotte al silenzio più assordante e alla dimenticanza del non venire nominate neanche en passant. Esse sono solo lo strumento mediante il quale il perpetratore violenta l’innocenza originaria e la perfezione perpetua della fede.
In questo momento, addebitare in toto le ragioni degli abusi nella Chiesa cattolica ai processi sociali e culturali di cambiamento degli assetti relazionali tra le generazioni, le persone, i singoli e le autorità costituite è semplicemente indice di cattivo gusto - anche nel caso uno sia profondamente convinto di ciò. Non si può dire, semplicemente perché si è visto che non è vero.
Distorsioni indebite e legittimazioni improprie del potere che circola nella Chiesa non possono essere ricondotte alla caduta morale di alcuni, neanche di molti dei suoi; si tratta piuttosto - come ha ricordato poco tempo fa monsignor Heiner Wilmer, vescovo di Hildesheim - di qualcosa che appartiene al dna della Chiesa stessa e come tale va trattato.
Non a tutti è concessa una platea globale per il proprio canto del cigno. Quando questo accade si dovrebbe raccogliere presso di sé le poche forze rimaste e prendere congedo con dignità dalla Chiesa che è di tutti. Altro è stato con Ratzinger, che si è lasciato avvincere da ancestrali paure e da una vendicatività di basso profilo, a uso e consumo di una combriccola di filibustieri che non provano un briciolo di sentimento per lui.
Che «un Dio che inizia con noi una storia d’amore e vuole includere in essa tutta la creazione» sia l’orizzonte ultimo da cui prende le mosse questo testo, così come esso si è prodotto e con gli effetti intenzionali che ha messo in circolo, è la piegatura drammatica del canto del cigno di Ratzinger.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") --MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA.23 novembre 2018, di Federico La Sala
MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA. Per un rinascimento senza toga...*
- "LE VIE DELLA VERITÀ. [...] per la verifica rinascimentale, analizzare la letteratura dei cristiani offesi, a partire dal Contra hypocritas di Poggio Bracciolini fino all’Isola dei papòmani nel Gargantua di Rabelais. In una lettera del 2 luglio 1497 Savonarola esortò un monaco «all’animosa libertà» contro le parole abbiette, ossia agli ordini ipocriti, pur indorate dalla potestà papale, detta suprema o delle Chiavi. Chi passava dalla collera etica contro la menzogna delle parole [...] alla satira beffarda, si soffermava soprattutto sull’evoluzione del titolo papale di servo dei servi di Dio, per dimostrare che avesse preso senso di signore dei signori, «dominus dominantium»: si legga l’Eremita di Antonio de’ Ferraris detto il Galateo. Anzi era pensiero di Michelangelo che servo dei servi si diviene in croce e perciò quel titolo compete solo a Cristo (Rime, n. 298). Per parte mia sono convinto dell’ironia di Raffaello quando nelle Stanze Vaticane figura Pietro scalzo e i papi Giulio II e Leone X nella pompa della gloria" (cfr. Romeo De Maio, Rinascimento senza toga, Alfredo Guida Editore, Napoli, 1999, p. 18).
* SUL TEMA, CFR.: IL "PADRE NOSTRO" E IL "CRISTO RE": IL REGNO DI DIO-MAMMONA ("CARITAS") O DI DIO-AMORE ("CHARITAS")!?
Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" -- "La filologia al servizio delle nazioni". Quale tipo di filologia può ancora servire il mondo e servire al mondo?25 ottobre 2018, di Federico La Sala
La filologia al servizio delle nazioni. Storia, crisi e prospettive della filologia romanza
di Stefano Rapisarda *
Se un giorno la filologia morisse, la critica morirebbe con lei, la barbarie rinascerebbe, la credulità sarebbe di nuovo padrona del mondo». Così Ernest Renan ne "L’avenir de la science" (1890) tesseva un altissimo elogio della filologia, una delle scienze regine del XIX secolo.
Oggi, al tempo delle fake news e della post-verità, quelle parole ci ricordano che la filologia può essere ancora argine alla barbarie. E ci ricordano che la filologia, quella con aggettivi e quella senza, è intrinsecamente politica. Non è utile o interessante in sé: lo è quando è schierata, militante, "calda", quando tocca interessi, quando serve interessi. Quando è "al servizio" di un Principe o di un partito o di uno Stato o di una visione del mondo.
Ci ricordano insomma che la filologia è anche politica, come sapevano Lorenzo Valla e Baruch Spinoza, Ernest Renan e Ulrich Wilamowitz-Möllendorff, Gaston Paris e Paul Meyer, Eduard Koschwitz e Joseph Bédier, Ernst Robert Curtius e Erich Auerbach, Cesare Segre e Edward Said.
Eppure la filologia, con o senza aggettivi, oggi sa di polvere e di noia. Ciò sollecita varie domande: perché questa antica "scienza del testo" si è ridotta al margine della cultura di oggi? Può tornare al centro dei bisogni intellettuali dell’uomo contemporaneo? Quale tipo di filologia può ancora servire il mondo e servire al mondo?
*
SCHEDA - Academia.Edu
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") --- La rabbia e l’orgoglio dei filologi. A proposito di "La filologia al servizio delle nazioni" di Stefano Rapisarda.24 ottobre 2018, di Federico La Sala
La rabbia e l’orgoglio dei filologi. A proposito di "La filologia al servizio delle nazioni" di Stefano Rapisarda
di Claudio Giunta ("Le parole e le cose", 24.10.2018) *
Chissà se i medici dubitano della medicina, gli ingegneri dell’ingegneria, i parrucchieri della parruccheria con lo stesso zelo con cui gli umanisti di oggi dubitano dell’umanesimo? Probabilmente no: ci saranno sempre tumori da curare, ponti da costruire, capelli da tagliare, sarà sempre abbastanza facile, per loro, rispondere alla domanda «Sì, ma a che cosa servite?». Le discipline umanistiche sono sempre state un po’ meno necessarie, ma c’è la diffusa impressione che il loro credito sia andato diminuendo in fretta negli ultimi decenni, per l’indebolirsi delle culture nazionali, l’impoverimento degli Stati che pagano i professori di ‘umanità’, il prevalere del sapere tecnico-scientifico, internet e le solite altre cose. In questo quadro non roseo, in La filologia al servizio delle nazioni Stefano Rapisarda riflette sulla sorte - anch’essa parrebbe non rosea - di una delle discipline in cui si articola lo studio della letteratura: la filologia, appunto, e la filologia romanza in particolare.
Il libro ha tre parti. Nella prima, Rapisarda constata la crisi degli studi filologici: crisi che non dipende dalla diminuita qualità dei prodotti (anzi, soprattutto in Italia i prodotti di questi studi continuano ad essere eccellenti, e nel novero vanno inclusi quelli dello stesso Rapisarda, che è un medievista insigne) bensì da una sorta di fine del mandato sociale che i filologi un tempo detenevano, non solo nel campo della cultura ma anche in quello, più ristretto, dello studio universitario della letteratura: delle ricerche e dei pareri dei filologi non ci si cura più granché.
Nella seconda parte Rapisarda racconta la storia della filologia romanza negli ultimi due secoli isolando una serie di ‘paradigmi’, cioè di modelli che hanno informato lo studio delle letterature neolatine del Medioevo: un paradigma nazionalistico sviluppatosi soprattutto in Germania e in Francia, vigorosissimo per tutto l’Ottocento e il primo Novecento; un paradigma Curtius, che mira invece al superamento delle moderne frontiere nazionali e cerca l’unità culturale là dove si erano cercati soprattutto i documenti delle distinte identità nazionali; un paradigma della ‘semiotica filologica’, che prova a far dialogare la filologia con lo strutturalismo e le altre scienze umane e sociali (non credo di forzare il pensiero dell’autore se dico che i frutti di questo dialogo gli paiono, come paiono anche a me, praticamente nulli); un paradigma della ‘filologia materiale’, che in vario modo valorizza la materialità dei testimoni manoscritti.
Nella terza parte Rapisarda si domanda «Che fare?», e risponde - più o meno - che la disciplina va reimpostata in chiave davvero comparatistica come Weltphilologie, allargando lo sguardo alle linee di confine, in particolare studiando meglio di come si sia fatto sinora i rapporti tra Europa continentale e Mediterraneo (filologia euro-mediterranea) e i rapporti tra Europa e Oriente (filologia euro-asiatica). Orizzonti tanto vasti non incoraggeranno il dilettantismo? E di fronte alla globalizzazione imposta dall’economia e dai media la missione delle discipline umanistiche, e della filologia in ispecie, non dovrebbe essere proprio quella di distinguere con pazienza, badando alle differenze anziché alle analogie superficiali? Rapisarda oscilla. Da un lato, è un filologo troppo esperto per non vedere che questa neo-Weltphilologie produce spesso studi fragili, velleitari, ideologici in senso deteriore («Atene nera» di Bernal? Davvero?); dall’altro, prova una certa nostalgia per l’Età dell’Impegno, e pur prendendo le distanze dagli eccessi comparatistici, elogia il fatto che anziché di minuzie che non interessano nessuno si parli di cose: «Sotto il profilo probatorio [European Modernity and the Arab Mediterranean di Karla Mallette] è un libro discutibile, e infatti se ne discute e io stesso ne ho discusso. Ma almeno c’è vita, passione, entusiasmo, ardimento intellettuale. Ciò che da molto manca all’algido tecnicismo della filologia europea». Non mi unirei all’elogio.
A unificare le tre parti, infine, un’idea fissa, un motivo ricorrente che è poi anche la tesi fondamentale del libro, e che potremmo definire come un sobrio appello alla militanza: «La filologia non è utile o interessante in assoluto, lo è quando si applica ai temi ideologicamente caldi intorno ai quali è nata [...]. L’auspicio è che le filologie si ridefiniscano intorno ai ‘temi caldi’ di un’epoca, alle passioni politico-ideologiche, ai Grandi Libri sui quali ogni civiltà è costruita, e che esse riannodino i legami con la comunità di cui sono espressione». Vasto programma.
Sono d’accordo su molte delle opinioni che Rapisarda sviluppa nel suo libro, sottoscriverei quasi ogni pagina, anche se quasi nessuna pagina avrei saputo scrivere: perché sono ben lontano dall’avere l’ampiezza d’informazione e di visione che ha lui (ma credo che ben pochi tra gli studiosi in attività sappiano padroneggiare un campo di studi così ampio, che va dai poeti federiciani alla narratologia, dalle ricerche sul folklore alla Postcolonial Theory).
 Sono meno d’accordo sulla sua tesi principale, quella che ispira anche il titolo del libro, e cioè che gli studi filologici, per prosperare, abbiano bisogno di ritagliarsi un ruolo nella battaglia delle idee, di diventare armi da adoperare nel conflitto politico. C’è del vero, ovviamente, in questa opinione, c’è storicamente del vero, e Rapisarda lo documenta bene, ma lo stesso si potrebbe dire della storia, della geografia, della linguistica, della storia letteraria, e insomma di ogni disciplina che - semplifico - faccia centro non sull’oggettività delle cose (da quante carte è formato il tal manoscritto?) ma sulla loro interpretazione (in quale lingua è scritto quel dato documento? Quale popolo si è insediato per primo su quel dato territorio?): cioè appunto quasi tutte le discipline umanistiche.
Sono meno d’accordo sulla sua tesi principale, quella che ispira anche il titolo del libro, e cioè che gli studi filologici, per prosperare, abbiano bisogno di ritagliarsi un ruolo nella battaglia delle idee, di diventare armi da adoperare nel conflitto politico. C’è del vero, ovviamente, in questa opinione, c’è storicamente del vero, e Rapisarda lo documenta bene, ma lo stesso si potrebbe dire della storia, della geografia, della linguistica, della storia letteraria, e insomma di ogni disciplina che - semplifico - faccia centro non sull’oggettività delle cose (da quante carte è formato il tal manoscritto?) ma sulla loro interpretazione (in quale lingua è scritto quel dato documento? Quale popolo si è insediato per primo su quel dato territorio?): cioè appunto quasi tutte le discipline umanistiche.
 Personalmente (ma credo di poter parlare a nome di molti), il mio interesse per la filologia nasce soprattutto dalla sua avalutatività, cioè dal suo tenersi a dati oggettivi - che ci sono: non è tutto interpretazione - sui quali possono convergere studiosi e lettori di indole disparata: il luogo dell’intesa, non quello del conflitto (e basta vedere che cosa è successo negli ultimi decenni in Catalogna, un caso che Rapisarda infatti menziona un po’ di sfuggita, ma su cui conveniva forse indugiare di più: ecco una situazione nella quale le humanities sono state mobilitate per avallare ipotesi storiche quantomeno peregrine; a me non pare una strada da seguire).
Personalmente (ma credo di poter parlare a nome di molti), il mio interesse per la filologia nasce soprattutto dalla sua avalutatività, cioè dal suo tenersi a dati oggettivi - che ci sono: non è tutto interpretazione - sui quali possono convergere studiosi e lettori di indole disparata: il luogo dell’intesa, non quello del conflitto (e basta vedere che cosa è successo negli ultimi decenni in Catalogna, un caso che Rapisarda infatti menziona un po’ di sfuggita, ma su cui conveniva forse indugiare di più: ecco una situazione nella quale le humanities sono state mobilitate per avallare ipotesi storiche quantomeno peregrine; a me non pare una strada da seguire).Qui però sta il problema, che è in fondo anche il problema che ha indotto Rapisarda a scrivere questo libro. Ha ancora senso, oggi, reclutare giovani studiosi e metterli a lavorare per anni, per decenni, alla mappa di un mondo culturale (il Medioevo romanzo) che, oltre ad essere in buona misura già stato mappato, appare così lontano dagli interessi odierni, dalla vita odierna? Può durare, è giusto far durare, finanziandola, la disciplina che produce contributi come «Appunti sulle maiuscole del cod. Hamilton 90», «Tradizioni regionali e tassonomie editoriali dei canzonieri antico-francesi», «Sinalefe e dialefe: appunti per una tipologia degli incontri vocalici interverbali nella versificazione occitana» (gli esempi sono di Rapisarda, che è questa rara avis: un filologo spiritoso)?
Mi pare che le ragioni dell’odierna ‘crisi delle humanities’ - e della più seria e fondativa delle humanities, la filologia - vadano cercate meno nella loro contingente irrilevanza per la battaglia delle idee (così Rapisarda) che nella loro radicale estraneità all’aria del tempo presente. L’epoca eroica delle filologie è il secolo che va dalla metà dell’Ottocento alla metà del Novecento. Prima prevale l’empiria. Dopo, nel tempo presente appunto, cominciano ad affiorare i dubbi, le esitazioni di fronte alla domanda «Sì, ma a che serve?». Anche per questo, in questa età argentea, la filologia e la critica sono state anche troppo propense a salire sul carro del vincitore di turno: il marxismo, Bachtin, lo strutturalismo, gli studi postcoloniali eccetera - tutto il nuovo cemento col quale i filologi hanno sperato di puntellare le proprie rovine.
 Il libro di Rapisarda è, tra le altre cose, un utile promemoria sulle tante scemenze che gli studiosi di letteratura, e purtroppo anche i filologi, hanno preso sul serio nel tentativo di mostrarsi à la page. Qualcuno continua ancora adesso, imperterrito; ma i più hanno capito: le cose vanno meglio oggi che trenta o quarant’anni fa; anche se parliamo continuamente di crisi, la disciplina è in piena salute.
Il libro di Rapisarda è, tra le altre cose, un utile promemoria sulle tante scemenze che gli studiosi di letteratura, e purtroppo anche i filologi, hanno preso sul serio nel tentativo di mostrarsi à la page. Qualcuno continua ancora adesso, imperterrito; ma i più hanno capito: le cose vanno meglio oggi che trenta o quarant’anni fa; anche se parliamo continuamente di crisi, la disciplina è in piena salute.Perché questo nervosismo, allora? Non è tutto semplice? I filologi devono fare bene il loro mestiere: studiare la storia e la tradizione dei testi, allestirne l’edizione, commentarli con erudizione e intelligenza. Solo che è una semplicità difficile a farsi. Nelle università italiana ci sono ancora molte persone, e molti giovani, che fanno esattamente questo, tenendo vivo un habitus che sembra essersi già perso in quasi tutte le altre nazioni occidentali.
 Ma - Rapisarda ha ragione - questo sembra non bastare più: da un lato per la spinta anti-filologica che sempre più forte si avverte all’interno dell’università (parliamo di idee, di diritti, di conflitti, non di varianti manoscritte!); dall’altro per il disinteresse che il vasto mondo che sta al di fuori dell’università sembra nutrire per un sapere umanistico che non sia direttamente spendibile nel dibattito (meglio le scienze sociali di quelle storiche filologiche) o sul mercato culturale (meglio la storia dell’arte, col suo indotto di mostre, della paleografia, che di mostre quasi non ne produce). Perché allora darsi da fare per acquisire un habitus che richiede molto tempo e infinita dedizione, una dedizione tale da escludere quasi qualsiasi altro interesse culturale nonché di vita, se poi la voce di coloro che hanno acquisito questo habitus, i filologi, è così flebile? -Questo poteva non essere un problema un tempo, quando la cultura era un prodotto o un’emanazione della scuola e dell’università; ma è un problema oggi, quando quella cultura non solo è travolta dall’infinita produzione d’idee e di opere d’arte che ignorano il filtro scolastico ma sembra addirittura inadatta a ‘preparare alla vita’, per come la vita è diventata (per non lasciare il discorso nel vago: in tanta concentrazione sui libri del passato, sempre più incombe il rischio di non saper capire quel che succede nel presente, o di voler applicare al presente, sventatamente, i principi di Tucidide o di Dante Alighieri: che è un altro nome della stupidità).
Ma - Rapisarda ha ragione - questo sembra non bastare più: da un lato per la spinta anti-filologica che sempre più forte si avverte all’interno dell’università (parliamo di idee, di diritti, di conflitti, non di varianti manoscritte!); dall’altro per il disinteresse che il vasto mondo che sta al di fuori dell’università sembra nutrire per un sapere umanistico che non sia direttamente spendibile nel dibattito (meglio le scienze sociali di quelle storiche filologiche) o sul mercato culturale (meglio la storia dell’arte, col suo indotto di mostre, della paleografia, che di mostre quasi non ne produce). Perché allora darsi da fare per acquisire un habitus che richiede molto tempo e infinita dedizione, una dedizione tale da escludere quasi qualsiasi altro interesse culturale nonché di vita, se poi la voce di coloro che hanno acquisito questo habitus, i filologi, è così flebile? -Questo poteva non essere un problema un tempo, quando la cultura era un prodotto o un’emanazione della scuola e dell’università; ma è un problema oggi, quando quella cultura non solo è travolta dall’infinita produzione d’idee e di opere d’arte che ignorano il filtro scolastico ma sembra addirittura inadatta a ‘preparare alla vita’, per come la vita è diventata (per non lasciare il discorso nel vago: in tanta concentrazione sui libri del passato, sempre più incombe il rischio di non saper capire quel che succede nel presente, o di voler applicare al presente, sventatamente, i principi di Tucidide o di Dante Alighieri: che è un altro nome della stupidità).Tutto sommato, perciò, sono un po’ più pessimista di Rapisarda. La politica cambia in fretta, le ideologie anche, e alla stasi di un decennio può seguire un’epoca di conflitti (non è quella che viviamo oggi?), un’epoca che potrà essere, per ipotesi, più congeniale a quella seria, metodica critica del passato che è la filologia. Ma l’aria del tempo sfugge alla volontà degli uomini, si orienta verso ciò che è utile più che verso ciò che è giusto; e dura a lungo. Che fare, dunque, da cultori di discipline umanistiche? Andare contro l’aria del tempo, è ovvio.
* Già pubblicato in una versione più breve sul Domenicale del Sole 24 ore del 21 ottobre 2018
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" -- "PURGATORIO DE L’INFERNO": MAMMONA!!! “Questo è il gatto con gli stivali”.8 marzo 2018, di Federico La Sala
IL DIO MAMMONA (“CARITAS”), IL DENARO, E “IL GATTO CON GLI STIVALI”.
LA LEZIONE DI EDOARDO SANGUINETI *
PURGATORIO DE L’INFERNO, 10. “Questo è il gatto con gli stivali”
- Mentre con il figlio osserva un libro illustrato, il poeta sollecita con amore e affetto a guardare le immagini con attenzione e spirito critico, dietro a ogni cosa in esso rappresentata, e a ogni manifestazione della vita, si nasconde l’onnipotenza del ’dio’ denaro.
Questo è il gatto con gli stivali, questa è la pace di Barcellona
fra Carlo V e Clemente VII, è la locomotiva, è il pesco
fiorito, è il cavalluccio marino: ma se volti pagina, Alessandro,
ci vedi il denaro:
questi sono i satelliti di Giove, questa è l’autostrada
del Sole, è la lavagna quadrettata, è il primo volume dei Poetae
Latini Aevi Carolini, sono le scarpe, sono le bugie, è la scuola di Atene, è il burro,
è una cartolina che mi è arrivata oggi dalla Finlandia, è il muscolo massetere,
è il parto: ma se volti foglio, Alessandro, ci vedi
il denaro:
e questo è il denaro,
e questi sono i generali con le loro mitragliatrici, e sono i cimiteri
con le loro tombe, e sono le casse di risparmio con le loro cassette
di sicurezza, e sono i libri di storia con le loro storie:
ma se volti il foglio, Alessandro, non ci vedi niente
Edoardo Sanguineti
* SI CFR. : KARL MARX E WALTER BENJAMIN - “PURGATORIO DE L’INFERNO”: IL DIO MAMMONA (“CARITAS”), IL DENARO, E “IL GATTO CON GLI STIVALI”. LA LEZIONE DI EDOARDO SANGUINETI
Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" -- Quella cosa molto seria che si chiama dono (di Luigino Bruni)..16 novembre 2017, di Federico La Sala
Quella cosa molto seria che si chiama dono.
di Luigino Bruni *
Una delle povertà più grandi del nostro tempo è quella delle domande generative. Siamo inondati di risposte a domande che non facciamo, a ricette per soluzioni di problemi che non avvertiamo come tali, e al contempo siamo dentro una carestia impressionante di domande grandi, capaci di farci intravvedere orizzonti nuovi, di attivare la nostra creatività individuale e collettiva, di spingerci all’azione per cambiare il mondo, e non solo per gestire l’ordinario business.
Una delle domande non fatte, ma che attraversa tacita l’intera nostra civiltà ha a che fare con una delle parole più abusate e umiliante della nostra generazione: il dono. Dovremmo sempre più tornare ad interrogarci, in un tempo dominato dal consumo e dalla ricerca del piacere che fine ha fatto il dono nella nostra vita, soprattutto nella sfera pubblica. E’ infatti il dono che crea la comunità (cum-munus, dono reciproco), veniamo al mondo e qualcuno ci accoglie con gratuità e la vita si rigenera non per i contratti ma per i doni.
E allora chiediamoci: che cosa diventa il dono quando lo trasformiamo in filantropia, quando finisce per svolgere il ruolo di tappabuchi dello stesso capitalismo? Possiamo ancora chiamare dono le donazioni che le multinazionali dell’azzardo fanno alle associazioni che si occupano delle loro vittime? Che cosa sta allora diventando il dono? E che cosa il mercato?
Domande impegnative, questioni che negli ultimi decenni sono uscite troppo velocemente dall’orizzonte della nostra società, dai temi trattati sui giornali e nei media, dagli argomenti insegnati nei corsi di economia e business. Il mercato nasce come elaborazione del dono. Millenni fa abbiamo iniziato a scambiare con il linguaggio del dono, il contratto è nato dal patto, le monete avevano come effige gli dei, e il primo contratto che troviamo nella Bibbia è l’acquisto di Abramo della terra per la tomba della moglie Sara (Genesi).
Se giungiamo alla modernità, vediamo che il capitalismo nasce come riflessione sul rapporto fra dono (grazia, charis) e mercato. La Riforma protestante è stata decisiva per la natura del capitalismo moderno. Nata dalla ferita di un mercato che era penetrato nel cuore del dono (il mercato delle indulgenze), l’umanesimo luterano e calvinista si è caratterizzato per una netta separazione tra l’ambito del mercato e quello del dono, tra l’economia for-profit intesa come il regno degli interessi e dei contratti e quella non-profit vista come il luogo della gratuità.
L’umanesimo latino-cattolico, invece, non ha mai smesso di mescolare dono e contratto, grazia e mercato, profitto e gratuità, e l’economia cooperativa, l’impresa famigliare e la cosiddetta Economia civile sono comprensibili solo all’interno di un umanesimo meticcio, con le sue tipiche ferite e benedizioni - come ho cercato di dimostrare nel mio ultimo saggio Il mercato e il dono. Gli spiriti del capitalismo, Egea Bocconi 2015. Il nostro tempo sta conoscendo un appiattimento delle differenze regionali, del genius loci dei diversi capitalismi, sotto l’incedere di una ideologia che ci sta convincendo che il capitalismo «buono» è uno solo, quello costruito attorno agli incentivi, all’individuo e all’efficienza, i tipici valori dell’umanesimo protestante, relegando così il dono e i suoi valori in una sfera sempre più angusta e irrilevante.
Il dono è una cosa molto seria. E’ diventato quasi impossibile parlare bene oggi del dono, perché lo abbiamo messo in un angolo, e ridotto a ben poca cosa, soprattutto nella sfera pubblica, civile, economica. L’attacco al dono è comunque cosa antica. Abbiamo iniziato a relegarlo in ambiti molto angusti quando, anche per responsabilità di una certa teologia cristiana, tra l’Umanesimo e la modernità abbiamo iniziato a pensare che la giustizia fosse veramente essenziale per la costruzione di una buona società, e che, invece, la carità fosse un di più. La giustizia - abbiamo pensato e scritto - chiede di dare a ciascuno il suo, la carità di andare oltre il proprio. La giustizia è necessaria, la carità è facoltativa. La giustizia è essenziale, la carità volontaria, quindi inessenziale. La giustizia è importante, la carità superflua.
Il passo verso l’inutilità della carità è stato immediato, e così abbiamo immaginato una giustizia possibile senza agape, e una vita in comune buona senza amore civile. Abbiamo pensato che la carità/agape/amore potesse essere utile in alcuni ambiti specialistici - famiglia, le chiese, un certo non-profit, nella gestione delle emergenze umanitarie ... - ma che per la vita ordinaria pubblica ci bastasse la giustizia, che è già cosa molto ardua. I contratti e gli interessi sono necessari, il dono no: ci viene sempre più presentato come qualcosa di carino, il limoncello alla fine di una cena, che se c ’è fa piacere, ma se non c ’è in fondo nessuno se n ’accorge (tranne, nel lungo periodo, i produttori di limoncello). Il dono nella nostra società finisce per pesare per il 5 o l’8 per mille, e dobbiamo anche scontare l’evasione fiscale.
Il primo colpo, quasi mortale, al dono lo abbiamo allora dato quando, ormai da un po’ di anni, abbiamo ridotto la carità all’elemosina, alle donazioni, alla filantropia, alle offerte in chiesa, alle pesche di beneficienza o (molto più recentemente) ai due euro degli SMS umanitari. Abbiamo così, e nel giro di qualche decennio, annullato quell’operazione mirabile che fecero i cristiani dei primi secoli, quando scelsero di tradurre agape (l’amore gratuito) con charitas.
La caritas (senza h ) era, nel tardo latino, una parola economica - è antico il rapporto tra dono e mercato. Era usata dai mercanti per indicare il valore delle cose: un bene era caro se valeva e costava molto, come diciamo ancora oggi. Ai cristiani, in cerca di una parola latina per tradurre l’amore-agape, una parola diversa da amor (troppo vicino all’eros greco), trovarono in caritas una buona soluzione. Ma volevano differenziarla, almeno un po’, dalla parola economica del loro tempo. E così vi aggiunsero quella ‘h’, che era tutt’altro che muta, perché voleva dirci una cosa importante: charitas traduce le due grandi parole greche su cui si stava fondando la chistianitas (ancora questo ch): agape e charis, amore e gratuità, grazia. In quella charitas c’era praticamente quasi tutto: le vite donate dai martiri del loro tempo, gran parte dell’insegnamento delle lettere di Paolo, il kerigma dei vangeli; ma c ’era soprattutto un messaggio: la persona umana è capace di charitas, perché è capace di amare oltre l’eros e oltre la già grande philia (amicizia). È capace di oltrepassare il registro della condizionalità, persino oltre quel bisogno radicale di reciprocità che muove il mondo, e anche le stelle.
Questo era il dono: agape, charis, charitas. Questo non è più il dono nella nostra società. Cose, parole, realtà, che hanno generato, come ingredienti coessenziali, Notre Dame de Paris, il Duomo di Milano, gli affreschi di Signorelli a Orvieto e quelli di Michelangelo a Roma, la cappella Baglioni a Spello, le prime scuole per le ragazze povere a Viterbo, Barbiana, tante Costituzioni democratiche, le casse rurali che ci hanno salvato dalla miseria dei campi e generato il miracolo economico, una casa e un cuore per i disperati di Calcutta. E questo continua ad essere ancora in alcune periferie della nostra civiltà il dono: una energia straordinaria che continua a far nascere, per motivazioni più grandi del denaro, molte istituzioni, associazioni, cooperative, imprese. Che continua a farci alzare al mattino per andare a lavorare, per soffrire molto quando perdiamo il lavoro, perché smettendo di lavorare smettiamo non solo di percepire un reddito, ma non possiamo più donare la nostra vita lavorando, e ci fa gioire molto quando il lavoro lo ritroviamo. Tutto questo è il dono, ma non lo vediamo più. Se vogliamo veramente cominciare a sognare e costruire una nuova civiltà, prima di prevedere gli incentivi, gli sgravi fiscali e la crescita del PIL, dobbiamo tornare a vedere quella cosa molto seria che si chiama dono.
* Cfr. [DOC] 151028_BCC_Quella cosa molto seria che si chiama dono.docx
 www.consorziofarsiprossimo.org/il-contenuto-della-chiavetta.../14-bruni?...bruni
www.consorziofarsiprossimo.org/il-contenuto-della-chiavetta.../14-bruni?...bruni* Cfr.INTRODUZIONE a Il mercato e il dono. Gli spiriti del capitalismo
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" -- RICCHEZZA E NOBILTÀ. CELESTINO V E IL POSTUMO "RISARCIMENTO" ARALDICO.27 settembre 2017, di Federico La Sala
RICCHEZZA E NOBILTÀ: LA CHIESA DI COSTANTINO, CELESTINO V E IL POSTUMO "RISARCIMENTO" ARALDICO ...
"ORIA. UN CASO DI ARALDICA PONTIFICIA IMMAGINARIA": UN LAVORO MAGISTRALE DI GRANDE INTERESSE. Tra le sue righe una notazione che getta luce sulla intera storia della Chiesa e non solo su Celestino V (la Congregazione dei Celestini, la città di Oria e al Salento), ma anche su papa Bonifacio VIII (Benedetto Caetani), su Benedetto XVI (Joseph A. Ratzinger), papa Francesco (Jorge M. Bergoglio), e, ancora, su DANTE ALIGHIERI (con la sua profetica lezione teologico-politica, cfr. "Monarchia" e "Commedia") e al tempestoso presente storico entro cui ancora oggi (nel III Millemnio d. C.) naviga l’Istituzione nata e cresciuta all’ombra di COSTANTINO, della sua "donazione", del suo "LATINORUM", e della sua "CARITAS" (da non confondere con la "CHARITAS", cfr. i commenti all’art. di Marcello Gaballo, "L’affresco di aant’Agostino nella cattedrale di Nardò", Fondazione Terra d’Otranto):
"Com’è noto, il primo pontefice di cui si possa attestare con certezza l’uso di uno stemma nell’esercizio della sua carica fu Bonifacio VIII (1294-1303), ma è con Clemente VI (1342-1352) che la conformazione dell’arma papale si canonizza nella forma che diventerà classica (...), mantenendosi tale fino al pontificato di Benedetto XVI";
 nota 16: "Com’è noto, Benedetto XVI abolì l’uso della tiara come timbro dello stemma papale, sostituendola con una mitria d’argento ornata da tre fasce d’oro, unite da un palo dello stesso colore. Il suo successore, Francesco, ha mantenuto tale uso" (cfr. Marcello Semeraro, "Oria. Un caso di araldica pontificia immaginaria").
nota 16: "Com’è noto, Benedetto XVI abolì l’uso della tiara come timbro dello stemma papale, sostituendola con una mitria d’argento ornata da tre fasce d’oro, unite da un palo dello stesso colore. Il suo successore, Francesco, ha mantenuto tale uso" (cfr. Marcello Semeraro, "Oria. Un caso di araldica pontificia immaginaria").Federico La Sala
-
> PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO. --- Francesco non dà tregua al male oscuro della Chiesa: "Soldi e potere, tentazioni che distruggono".17 maggio 2016, di Federico La Sala
Francesco non dà tregua al male oscuro della Chiesa: "Soldi e potere, tentazioni che distruggono"
Nell’omelia a Santa Marta, il Papa ricorda il passo del Vangelo in cui Gesù parla di umiltà e i discepoli preferiscono discutere su chi tra di loro sia il più grande. "Accade anche oggi in ogni istituzione della Chiesa. Tutti con la voglia di ricchezza, vanità, orgoglio. Nessuno di noi può dire: sono una persona santa e pulita" *
CITTA’ DEL VATICANO - "La via che indica Gesù è la via del servizio, ma spesso nella Chiesa si ricercano potere, soldi e vanità". Sono le parole con cui Papa Francesco, nell’omelia di Santa Marta, ha messo in guardia dagli "arrampicatori" che anche nel mondo cattolico sono tentati di distruggere l’altro "per salire in alto". Tornando dunque a ribadire il messaggio lanciato lanciato ieri all’Assemblea dei vescovi italiani: i cristiani devono vincere la "tentazione mondana" che divide la Chiesa.
A Santa Marta, Francesco ha commentato il passo del Vangelo in cui "Gesù insegna ai suoi discepoli la via del servizio, ma loro si domandano chi sia il più grande tra loro. Il Maestro parla un linguaggio di umiliazione, di morte, di redenzione. Loro parlano un linguaggio da arrampicatori: chi andrà più in alto nel potere?". Esattamente, ha accusato il Papa, quanto "accade oggi in ogni istituzione della Chiesa: parrocchie, collegi, istituzioni, anche i vescovadi. Tutti con la voglia dello spirito mondano di ricchezza, vanità, orgoglio. Nessuno di noi può dire: no, io sono una persona santa e pulita. Tutti noi siamo tentati da queste cose, siamo tentati di distruggere l’altro per salire su. Questo spirito mondano, nemico di Dio, è una tentazione che divide e distrugge la Chiesa".
"Questa voglia mondana di essere con il potere - ha proseguito Bergoglio -, non di servire ma di essere servito, non si risparmia mai come arrivare: le chiacchiere, sporcare gli altri. L’invidia e le gelosie fanno questa strada e distruggono. Questo noi lo sappiamo, tutti. E tutti siamo tentati da queste cose, siamo tentati di distruggere l’altro per salire in su. E’ una tentazione mondana, ma che divide e distrugge la Chiesa, non è lo Spirito di Gesù".
Il Papa ha invitato quindi a immaginare la scena: Gesù che parla di umiltà e i discepoli che preferiscono discutere su chi di loro sarà il più grande. "Ci farà bene - ha sottolineato il Pontefice - pensare alle tante volte che noi abbiamo visto questo nella Chiesa. E alle tante volte che noi abbiamo fatto questo. E chiedere al Signore che ci illumini, per capire che l’amore per il mondo, cioè per questo spirito mondano, è nemico di Dio".
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" --- "Il grande idolo è il mercato. Tutti i governi sono inginocchiati di fronte a questo potere idolatrico" (Enzo Bianchi, priore di Bose)..26 dicembre 2015, di Federico La Sala
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- UN FALSO FILOLOGICO, ANTROPOLOGICO E TEOLOGICO. DIO e’ AMORE ("CHARITAS") non MAMMONA ("CARITAS"), COME SCRIVE BENEDETTO XVI ("Deus caritas est", 2006).
 Così "il Dio del denaro" inganna Papa Ratzinger, e Papa Ratzinger inganna gli uomini.... e rende cieco anche Enzo Bianchi
Così "il Dio del denaro" inganna Papa Ratzinger, e Papa Ratzinger inganna gli uomini.... e rende cieco anche Enzo Bianchi
Enzo Bianchi, il priore di Bose si racconta: “Tutti i governi sono inginocchiati al mercato”
"L’atteggiamento oscillante della politica italiana è una manifestazione di incapacità, serve un azione condivisa". Nominato come esperto da Benedetto XVI dal Sinodo dei vescovi e da Francesco consultore del Pontificio consiglio per l’unità dei cristiani, nel 1965 ha fondato la comunità in provincia di Magnano di Biella. "Bisogna rifondare la grammatica umana".
di Silvia Truzzi (il Fatto, 24 dicembre 2015)
La strada sembra fatta apposta per prepararti a Bose. Dal casello si attraversano solo campi, boschi umidi di nebbia e paesi deserti di tapparelle abbassate. Negozi con insegne scolorite chiusi chissà da quanto, strade strette che passano sotto ponti di pietra. A parte un trattore, non incroci nessuno, né a piedi né in auto. L’autoradio l’hai spenta quasi subito dopo l’autostrada. Poi l’hai riaccesa e di nuovo spenta: alla pace ci si abitua con difficoltà, ma a un certo punto bisogna arrendersi. Dunque è soprattutto silenzio, fino alla radura che ospita il monastero che ospita tutti: pellegrini, migranti, fedeli e infedeli, affamati, amici e persone smarrite.
Enzo Bianchi ha una faccia conosciuta: occhi limpidi e chiari, rughe scolpite; ingannevole invece la mitezza. Il file audio dell’intervista è pieno di picchi: tutte le volte che qualcosa lo fa arrabbiare il tracciato s’impenna. È nato il giorno prima di Gesù Bambino, 3 marzo ’43. Non c’è un porto in questa storia, ma il bric di Zaverio, le colline del Monferrato. E ci sono le bombe. “Quando sono nato, mio papà non c’era: stava in montagna con i partigiani. Faceva il magnan, lo stagnino. Ma anche il barbiere, il vetraio e l’elettricista per tirar su qualche soldo. Mia madre soffriva di una malattia al cuore, che si sarebbe potuta curare: dal 1952 hanno cominciato a fare gli interventi per operare la valvola mitralica. Ma lei è morta nel ’51, a trent’anni, io appena otto. Già da piccolo sapevo che se ne sarebbe andata presto. Sono nato in casa e fu una nascita difficile: i medici avevano sconsigliato a mia madre, così malata, di avere figli. Mio padre, che veniva da una famiglia rossa di anticlericali, voleva per me un nome che non fosse di un santo, e scelse ‘Enzo’. Ma mia madre, che invece era una donna piena di fede, volle chiamarmi ‘Giovanni’: con questo nome fui battezzato di notte, portato al parroco da una vicina di casa, amica di mia madre. Quando lei se n’è andata, siamo rimasti io e mio padre, pieni di debiti per le spese mediche: vita misera, ma dignitosa. Riuscii, con l’aiuto economico di due donne vicine di casa e le borse di studio, a iscrivermi a Economia. Poi abbandonai tutto per la vita monastica che iniziai a Bose”.
Com’è successo?
Ero impegnato in politica: fanfaniano, ero il segretario dei giovani democristiani in provincia di Asti. Poi, nel 1965, sono stato tre mesi alla periferia di Rouen, insieme all’abbé Pierre. Vivevo con ex legionari, ex alcolizzati, ex carcerati, passavo tra le case a raccogliere stracci e ferraglia. Quei tre mesi mi hanno dato un insegnamento enorme. Ho capito che i poveri non sono i destinatari della carità, ma soprattutto maestri. Se c’è qualcuno degno di una cattedra sono i poveri: sanno insegnare tante cose che di solito s’ignorano. Vedere la capacità di amore e di cura che avevano questi poveri tra di loro mi ha profondamente cambiato. Ha modificato la mia idea di cattolicesimo, fino a quel momento legata all’azione cattolica, al ‘fare il bene per dare testimonianza’.
Lì ha capito che voleva diventare monaco?
Fin da giovane sono stato legato alla religione: come ho detto, mia madre era profondamente cattolica. Due donne si sono prese cura di me: mia madre e una maestra che mi ha dato in mano San Basilio a 13 anni. Tenevo le Regole sul tavolino da notte ed ero solo un ragazzino.
E dopo Rouen?
In quel periodo ero stato sospeso dal partito: avevo firmato un manifesto dei comunisti contro la tortura e la condanna a morte di Julián Grimau, il leader del Partito comunista spagnolo perseguitato da Franco. Intanto avevo costituito a Torino un gruppo ecumenico - cattolici, valdesi, battisti, ortodossi - che si riuniva nel mio alloggio: tutte queste circostanze insieme e l’apertura ecumenica del Concilio vaticano II, mi fecero maturare l’idea della vita monastica. Così arrivai qui a Bose.
Come la scoprì?
Tramite amici che mi fecero conoscere la chiesa romanica adiacente alla frazione. Le case erano tutte disabitate e, con alcuni del gruppo, abbiamo pensato di affittarle. Anche se all’ultimo momento di quelli che avevano risposto sì alla mia proposta, non venne nessuno: due ragazze avevano trovato il fidanzato, un ragazzo aveva avuto una crisi di fede e si era iscritto a Sociologia a Trento. Poi entrò nelle Brigate rosse e fu condannato. Il cardinal Pellegrino, che era il mio riferimento spirituale, mi disse di continuare la vita iniziata a Bose.
Per quanto tempo ha vissuto qui da solo?
Quasi tre anni: non c’era l’acqua corrente e nemmeno la luce elettrica. Ma non ho mai trascorso un sabato e una domenica da solo: amici e conoscenti venivano a trovarmi, facevamo giornate di meditazione su alcuni temi di vita spirituale. Poi, nel ’68, quattro persone sono venute a vivere qui, due uomini e due donne. I voti li abbiamo presi nel ‘73, eravamo in sette. Da allora la comunità ha continuato a crescere: ogni anno arrivano tre-quattro persone nuove. Di solito finiscono per fare l’itinerario monastico: tre anni di noviziato, quattro di probandato. Dopo sette anni si può fare la professione monastica definitiva. I monaci sono laici che devono vivere lavorando con le proprie mani. Il vescovo mi aveva chiesto di diventare prete, ma io volevo restare un semplice cristiano, marginale nelle istituzioni perché la Chiesa può fare a meno dei monaci. Sant’Antonio diceva: ‘Noi monaci abbiamo le sante Scritture e la libertà’.
Qui cosa producete?
Ci sono un grande orto e un frutteto, grazie ai quali abbiamo verdura e frutta tutto l’anno. Abbiamo le api, una falegnameria, un laboratorio di ceramica, un panificio, facciamo confetture e marmellate. Produciamo icone, c’è la tipografia e le nostre edizioni Qiqajon molto apprezzate.
Quante persone passano da Bose?
Quindici-diciassettemila all’anno, più o meno. C’è chi viene per pregare, chi per pensare, chi per parlare perché è in difficoltà, chi cerca il silenzio. E poi ci sono anche quelli che vengono a chiedere da mangiare. Ormai ci chiedono pasta, pane, olio perché non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Una volta venivano più zingari e girovaghi, senza casa. Dal 2000 hanno cominciato a bussare gli extracomunitari e adesso - da circa cinque anni - si sono aggiunte povere famiglie e pensionati che non ce la fanno. Arrivano da Biella, Vercelli, Ivrea. Da settembre abbiamo quattro migranti dall’Africa. Gli abbiamo dato una casa e li stiamo aiutando a imparare l’italiano: ci sembra giusto condividere con loro. Se non lo facciamo noi qui, chi lo deve fare?
“Accoglienza” non è una parola di moda oggi.
Purtroppo no. Abbiamo spiegato ai nostri concittadini di Magnano che noi garantivamo per loro, che li accoglievamo in una bella casa, seguendoli in un percorso di integrazione vero: mi pare che il clima sia più disteso. Pesa, e molto, la burocrazia: capisco che le istituzioni ci vogliono, che servono garanzie. Il rischio però è che questo sia un processo completamente disumanizzato, che dimentica di avere a che fare con persone: se si vuole una conoscenza vera, reciproca, culturalmente stimolante, non si può passare solo da luoghi separati dalla vita comune.
Adesso c’è paura per il rischio terrorismo.
Ma è esagerata, esasperata dagli imprenditori della paura. Forze politiche che da un lato istigano la paura, dall’altro aumentano il risentimento dei migranti e dei popoli arabi verso di noi. Anche loro sono responsabili della violenza, che è una risposta - ingiusta perché contro gli innocenti - ad altra violenza.
L’emergenza “sicurezza” è più generale. A Vaprio d’Adda un pensionato ha ucciso un ladro che era entrato, disarmato, nella sua abitazione. E sarà candidato con Forza Italia.
La paura va presa sul serio: nei paesi qui intorno sono tutti vecchi, che spesso abitano da soli. Ma bisogna anche aiutare a razionalizzare. Le forze sociali dovrebbero contenere la paura, non usarla come macchina macina voti. Spesso si esagera: allora ecco il giustificare sempre - a qualunque costo - chi si difende, a prescindere dalle situazioni. Ecco che s’invoca una maggiore diffusione delle armi: il far west porta alla barbarie, che è iniziata già da anni. Prima la gente non era così cattiva, adesso è solo diffidente, chiusa. La responsabilità se la devono prendere i coltivatori di odio. E attenzione: questi signori hanno quasi sempre la scorta, quasi sempre vivono protetti da sette cancelli, dieci telecamere di sicurezza e non hanno nulla da temere.
Cosa manca ai nostri governanti, secondo lei?
Una vera politica dovrebbe prendersi cura degli ultimi, anche di quelli che arrivano alle nostre frontiere. Avere un atteggiamento oscillante, per cui ogni tanto bisogna mitragliare i barconi e ogni tanto si appare disposti all’accoglienza, mi sembra sia una manifestazione d’incapacità, una mancanza di visione. Anche a livello europeo. Bisogna sollecitare un’azione condivisa: ma se nessuno alza la voce, continua tutto come adesso.
La politica è subordinata al potere finanziario?
Il grande idolo è il mercato. Tutti i governi sono inginocchiati di fronte a questo potere idolatrico. Non c’è un governo, uno, che porti avanti un vero discorso di giustizia sociale, necessario in un momento in cui il divario tra i pochissimi che hanno tanto e i tantissimi che hanno poco o nulla è sempre, tragicamente, maggiore. La libertà e l’uguaglianza hanno bisogno della fraternità. Se prima non c’è il valore fondante della fraternità - tutti uguali, tutti fratelli, tutti con lo stesso diritto a una vita degna, a partecipare alla tavola del mondo - allora anche la libertà e l’uguaglianza sono deboli. Ogni uomo che viene al mondo ha diritto di vivere, di essere, per quanto possibile, felice e amato. Anche se per tutti la vita è un duro mestiere.
È la prima parte della Costituzione.
La Costituzione non è mai stata completamente applicata. Negli ultimi vent’anni si è addirittura teorizzato di abbandonarla perché ‘invecchiata’. È stato possibile dirlo, e in parte farlo, senza la resistenza di nessuno. Nemmeno delle forze di sinistra che hanno sposato la peggior ideologia radicale, portandoci a una situazione d’illegalità diffusa in cui è sempre più difficile affermare i diritti. Ormai c’è un individualismo imperante, la parola d’ordine è meritocrazia. Non si tiene conto della realtà più semplice: la vita fa i disgraziati. La morte, la malattia, la miseria fanno gli ultimi. O a questi ci pensa lo Stato o sono persone perdute.
Le reti sociali sono scomparse.
Si tratta di rifondare la grammatica umana nell’educazione. È un lavoro a lungo termine. Amartya Sen ha ragione quando rilegge la giustizia in termini nuovi: avere tutti gli stessi mezzi di sviluppo e affermazione. Non basta nemmeno una redistribuzione dei beni che tolga la fame. Su queste strade chi cammina? Le forze politiche sono sorde.
Quando lei era ragazzo era diverso?
Una volta per le forze politiche - sia quelle socialiste-comuniste sia quelle cattoliche - la giustizia sociale era un valore fondante. Oggi non conta nulla, non c’è nessuna possibilità di affermarla. Contano la produzione, lo sviluppo economico e poi che la distribuzione avvenga secondo i meriti. Ma cos’è il merito? Per gli ultimi non c’è nessuna possibilità di attenzione. È una vertigine di egoismo, di filautia. Il benessere è solo personale, tutto è lasciato al gioco del mercato che da solo sarebbe in grado di calmierare le disuguaglianze. Ma guardi come abbiamo ridotto la Grecia, umiliata dall’Europa con l’aiuto dell’Italia. È più grave che un povero umili un altro povero, come ha fatto l’Italia in crisi con la Grecia, una terra dove abbiamo portato una vergognosa guerra nel 1940. Non hanno capito che dove c’è la guerra tra poveri, i più ricchi ne approfittano.
Cosa ha pensato il giorno delle stragi a Parigi?
Ci saranno di nuovo i cortei, le manifestazioni e il grande sdegno, com’è capitato per Charlie Hebdo. Ma crescerà l’odio verso i Paesi arabi e nessuno si interrogherà sulle nostre responsabilità.
Ne abbiamo?
Noi abbiamo portato la guerra nel Golfo, in Iraq, in Libia. Se un uomo come Blair - che non è proprio un giusto - fa un mea culpa sull’Iraq vuol dire che è un dato di fatto. Abbiamo degli amici monaci in Iraq che provano a resistere alla guerra, qualche volta riusciamo a parlarci. Certo non ci vedono come i liberatori. Ci dicono: è colpa vostra.
Natale che cosa vuol dire?
Il Natale è l’occasione per riaccendere una speranza che riguarda l’umanità intera; in questo senso tutti noi sappiamo benissimo ‘cos’è’ il Natale. Dovrebbe voler dire che al centro di tutto c’è un uomo. La nascita di quel bambino è la nascita di una creatura che ha un diritto di vivere. Abbiamo diritto a vivere: pensiamo a quante persone stanno morendo sotto le bombe dei francesi, dei russi, degli altri che stanno facendo la guerra per procura.
Ha delle speranze?
Ne avevo di grandi, fino alla fine degli anni Novanta. La caduta del Muro di Berlino ci aveva dato speranza... Invece guardiamo oggi, quanti muri continuano a essere eretti!
La sua fede nell’uomo ha mai vacillato?
Ho avuto una grande crisi quando l’Italia è andata a fare la guerra nell’ex Jugoslavia: una vergogna su cui tutti tacciono. È stata una resa alle ragioni delle armi, del potere, del denaro. Ho capito che l’Europa non mi dava più speranze: a otto anni mi hanno dato la tessera dei ‘giovani per l’Europa’, per noi era un grande mito.
Il futuro?
Per ora manca un’insurrezione delle coscienze. Ma non c’è più nessuna mobilitazione: dopo il G8 non c’è stato più nulla. Neanche tra i giovani c’è interesse a mobilitarsi per la pace, la giustizia sociale, il lavoro che non c’è. Questo è grave, si passerà subito all’insurrezione violenta. Prima o poi i poveri si ribelleranno.
*
 Da il Fatto Quotidiano del 24 dicembre 2015
Da il Fatto Quotidiano del 24 dicembre 2015
 di Silvia Truzzi | 24 dicembre 2015
di Silvia Truzzi | 24 dicembre 2015 - UN FALSO FILOLOGICO, ANTROPOLOGICO E TEOLOGICO. DIO e’ AMORE ("CHARITAS") non MAMMONA ("CARITAS"), COME SCRIVE BENEDETTO XVI ("Deus caritas est", 2006).
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") --- «Quando Martini disse a Ratzinger: la Curia non cambia, devi lasciare» (di Gian Guido Vecchi)16 luglio 2015, di Federico La Sala
«Quando Martini disse a Ratzinger: la Curia non cambia, devi lasciare»di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 16.07.2015)
CITTÀ DEL VATICANO Padre Silvano Fausti raccontava che il momento era stato quando Benedetto XVI e Carlo Maria Martini si videro per l’ultima volta. Milano, incontro mondiale delle Famiglie, 2 giugno 2012, il cardinale malato da tempo era uscito dall’Aloisium di Gallarate per raggiungere il Papa. Fu allora che si guardarono negli occhi e Martini, che sarebbe morto il 31 agosto, disse a Ratzinger: la Curia non si riforma, non ti resta che lasciare.
 Benedetto XVI era tornato sfinito dal viaggio a Cuba, a fine marzo. In estate cominciò a parlarne ai collaboratori più stretti che tentavano di dissuaderlo, a dicembre convocò il concistoro dove creò sei cardinali e neanche un europeo per «riequilibrare» il Collegio, l’11 febbraio 2013 dichiarò la sua «rinuncia» al pontificato. Dimissioni «già programmate» dall’inizio del papato - se le cose non fossero andate come dovevano -, fin da quando al Conclave del 2005 Martini spostò i suoi consensi su Ratzinger per evitare i «giochi sporchi» che puntavano a eliminare tutti e due ed eleggere «uno di Curia, molto strisciante, che non ci è riuscito», rivela il padre gesuita.
Benedetto XVI era tornato sfinito dal viaggio a Cuba, a fine marzo. In estate cominciò a parlarne ai collaboratori più stretti che tentavano di dissuaderlo, a dicembre convocò il concistoro dove creò sei cardinali e neanche un europeo per «riequilibrare» il Collegio, l’11 febbraio 2013 dichiarò la sua «rinuncia» al pontificato. Dimissioni «già programmate» dall’inizio del papato - se le cose non fossero andate come dovevano -, fin da quando al Conclave del 2005 Martini spostò i suoi consensi su Ratzinger per evitare i «giochi sporchi» che puntavano a eliminare tutti e due ed eleggere «uno di Curia, molto strisciante, che non ci è riuscito», rivela il padre gesuita.Silvano Fausti è morto il 24 giugno a 75 anni, dopo una lunga malattia. Biblista e teologo, una delle voci più ascoltate e lette del pensiero cristiano contemporaneo, era la persona più vicina a Carlo Maria Martini, il cardinale lo aveva scelto come guida spirituale e confessore, si confidava con lui. Il retroscena affidato tre mesi prima di morire a glistatigenerali.com - l’intervista video è stata ora diffusa in Rete - corrisponde a ciò che padre Fausti raccontava in privato nella cascina di Villapizzone, alla periferia di Milano, dove viveva da 37 anni con altri gesuiti nella comunità che aveva fondato. Quasi un testamento che, a proposito di Ratzinger e Martini, risale ai giorni del Conclave di dieci anni fa. Erano le due personalità più autorevoli e, racconta Fausti, «i due che avevano più voti, un po’ di più Martini» (già allora malato di Parkinson), uno per i «conservatori» e l’altro per i «progressisti». C’era una manovra per «far cadere ambedue» ed eleggere il cardinale «molto strisciante» di Curia. «Scoperto il trucco, Martini è andato la sera da Ratzinger e gli ha detto: accetta domani di diventare Papa con i miei voti» . Si trattava di fare pulizia. «Gli aveva detto: accetta tu, che sei in Curia da trent’anni e sei intelligente e onesto: se riesci a riformare la Curia bene, se no te ne vai».
Martini, rivela Fausti, disse che il Papa fece poi un discorso «che denunciava queste manovre sporche e ha fatto arrossire molti cardinali». Il 24 aprile 2005, nell’omelia di inizio pontificato, Benedetto XVI disse: «Pregate per me, perché io non fugga, per paura, davanti ai lupi». Padre Fausti ricorda anche il gesto che avrebbe fatto Ratzinger, il 28 aprile 2009 nell’Aquila devastata dal terremoto. Era previsto solo un omaggio, ma Benedetto XVI seminò il panico varcando la porta santa della basilica pericolante di Collemaggio per deporre il suo pallio sulla teca di Celestino V, il Papa del «gran rifiuto». Ratzinger e Martini, pur diversi, si riconoscevano e si stimavano. «Cercavano sempre di metterli contro per fare notizia. Mentre, con Wojtyla, Martini dava ogni anno le dimissioni...». Le dimissioni di Benedetto XVI erano una possibilità dall’inizio del pontificato, spiega Fausti. Finché a Milano, quel giorno, Martini gli disse «è proprio ora, qui non si riesce a fare nulla». Nell’ultima intervista, Martini parlò di una Chiesa «rimasta indietro di 200 anni: come mai non si scuote?».
Ratzinger non è scappato davanti ai lupi, nonostante attacchi e veleni interni che fino a Vatileaks ne hanno funestato il pontificato. Sa che è urgente agire e fare pulizia, ma sente di non averne più la forza. Ci vuole una scossa. Nella sua rinuncia «in piena libertà» dice che «per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo» che «negli ultimi mesi» gli è venuto a mancare. Il conclave, di lì a un mese, eleggerà Jorge Mario Bergoglio. Padre Fausti, nel video, sorride: «Quando ho visto Francesco vescovo di Roma ho cantato il nunc dimittis , finalmente!, ho aspettato dai tempi di Gregorio Magno un Papa così...».
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") --- L’IRLANDA, LA CHIESA CATTOLICA, E LA NECESSITA’ DI PENSARE UN ALTRO ABRAMO28 maggio 2015, di Federico La Sala
- PENSARE UN ALTRO ABRAMO. GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE.
Fuori la Chiesa dalle lenzuola d’Irlanda
di Deborah Dirani (L’Huffington Post, 27/05/2015)
Che enorme occasione di evangelizzazione ha perso, ancora una volta, la Chiesa di Roma definendo la vittoria dell’amore irlandese una sconfitta per l’umanità. E che infinita tristezza racchiudono le parole del suo Segretario di Stato, un servo di Dio, in teoria. Un servo di quel Dio che raccontano essere buono e misericordioso, incline al perdono e dispensatore di infinito amore. Così lo raccontano, così ce lo propongono dal giorno in cui veniamo al mondo in quella parte di mondo in cui quel Dio lì ancora resiste. Per quanto? Per quanto potrà resistere l’incoerenza di questa chiesa che si riempie la bocca della necessità dell’amore e si chiude gli occhi davanti a una sua umana forma?
L’umanità non è sconfitta per il riconoscimento del diritto di sposarsi tra persone dello stesso sesso, l’umanità è sconfitta ogni volta che non accetta se stessa, in tutte le sue infinite sfumature. L’umanità è sconfitta ogni volta che si ostina, granitica, a non accettare la propria evoluzione. Lo chiamano oscurantismo, io necessità di controllo sociale. Del resto non sono certo la prima a identificare nelle religioni la beatificazione di questa umanissima esigenza: l’ordine sociale va mantenuto, ad ogni costo. Anche se questo costo sono donne ammalate bruciate su un rogo, infedeli trapassati da una spada, miscredenti infiammati o ostracizzati. Il rogo e la spada sono memoria lontana (mai abbastanza), l’ostracismo è il presente di una congregazione di anziani incapaci di mettere in pratica ciò di cui parlano.
Non sono cattolica, non lo sono per la mia impossibilità di accettare l’ineluttabilità di un destino che non mi posso scegliere, innanzitutto. Non lo sono per la poca misericordia nella quale continuo a imbattermi tra i massimi rappresentanti di questa vecchia Chiesa. No, non parlo dei preti di periferia, di quelli che si preoccupano più della vita che del suo ordine: quelli so che ci sono e a loro destino la mia più profonda e sincera ammirazione. Parlo di quei pii uomini ostinati a confondere la salvezza delle anime devote con la quotidianità della vita, con la necessità inviolabile che ogni essere umano ha di amare e di vedere legittimamente riconosciuto il suo amore.
Sotto le lenzuola la Chiesa, lo Stato e la politica non hanno il diritto di entrare: nessuno può decidere sulla liceità di un amplesso, nessuno può definire giusto un sentimento stigmatizzandone al contempo una delle sue possibili sfumature. L’omosessualità è vita, nonostante non sia in grado di generarne. Continuare a negarne la dignità è un errore talmente colossale da meritare, questo sì, le fiamme dell’inferno.
Pietro Parolin, portavoce del pensiero della Chiesa di Cristo, è molto triste per la vittoria del referendum sulle unioni gay avvenuta in un pio Stato quale è l’Irlanda. Ad avercelo vicino mi premurerei di passargli un fazzoletto per asciugarsi le lacrime, quindi gli consiglierei di essere molto felice perché quella che lo rattrista in realtà è la vittoria del principe dei suoi valori: l’amore. Non mi preoccuperei di snocciolargli il rosario delle empietà di cui la sua Chiesa continua a macchiarsi, tra preti che amano un po’ troppo i bambini e cercano di soffiare a Robert Mapplethorpe un posto nell’Olimpo dei fotografi del nudo.
Non mi preoccuperei neanche di ricordargli che tanti di quei bambini troppo amati sono diventati degli adulti incapaci di amare a causa di qualche innamorato con la tonaca. A che serve rinfacciare gli orrori commessi a chi ne è ben consapevole, nonostante l’omertoso silenzio dietro il quale per tanto tempo ha trovato un sicuro rifugio? Com’è, pure che diceva il Figlio di Dio? Ah, ecco: "Chi è senza peccato...". No, a Pietro Parolin offrirei una birretta, gli proporrei un brindisi: "Alla salute dell’amore, Monsignore!". Perché nonostante lei e quelli come lei alla fine vince lui, non dovunque, ma non dispero. Il tempo e la storia sono dalla mia parte.
Anche lei, o chi verrà dopo di lei, Monsignore, sarà costretto a piegare il capo davanti alla meravigliosa realtà della natura umana che ama. Non importa chi e non importa come: anche lei piegherà il capo e onorerà chi mette in pratica nella sua vita la parola di quel Dio di cui lei è devoto. Nel frattempo, Monsignore, mi premurerò di farle arrivare una buona scorta di fazzolettini, prevedo che in futuro gliene serviranno molti, moltissimi. E meno male!
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO. --- CUORI PIETRIFICATI (di Papa Francesco)12 marzo 2015, di Federico La Sala
Cuori pietrificati
·Messa a Santa Marta ·
12 marzo 2015 *
Nessun compromesso: o ci lasciamo amare «dalla misericordia di Dio» o scegliamo la via «dell’ipocrisia» e facciamo quello che vogliamo lasciando che il nostro cuore «si indurisca» sempre più. È la storia del rapporto tra Dio e l’uomo, dai tempi di Abele ai giorni nostri, al centro della riflessione proposta da Papa Francesco durante la messa a Santa Marta di giovedì 12 marzo.
Il Pontefice è partito dalla preghiera del salmo responsoriale - «Non indurite il vostro cuore» - e si è chiesto: «Perché accade questo?». Per comprenderlo ha fatto riferimento anzitutto alla prima lettura tratta dal libro del profeta Geremia (7, 23-28) dove è, per così dire, sintetizzata la «storia di Dio». Ma come, ci si potrebbe chiedere, «Dio ha una storia?». Come è possibile visto che «Dio è eterno»? È vero, ha spiegato Francesco, «ma dal momento che Dio è entrato in dialogo con il suo popolo, è entrato nella storia».
E quella di Dio con il suo popolo «è una storia triste» perché «Dio ha dato tutto» e in cambio «soltanto ha ricevuto cose brutte». Il Signore aveva detto: «Ascoltate la mia voce: io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò e così sarete felici». Quella era la «strada» per la felicità. «Ma essi non ascoltarono, né prestarono orecchio» e anzi: «procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio»: non volevano, cioè, «ascoltare la Parola di Dio».
Questa scelta, ha spiegato il Papa, ha caratterizzato tutta la storia del popolo di Dio: «pensiamo all’assassinio, alla morte di Abele, ucciso da suo fratello, cuore malvagio di invidia». Nonostante però il popolo abbia continuamente «voltato le spalle» al Signore, egli afferma: «Io non mi sono stancato». E invia «con assidua premura» i profeti. Ancora, però, gli uomini non hanno ascoltato. Anzi, si legge nella Scrittura, «hanno reso dura la loro cervice divenendo peggiori dei loro padri». E così «la situazione del popolo di Dio è peggiorata, nelle generazioni».
Il Signore dice a Geremia: «Di’ tutte queste cose, ma non ti ascolteranno, non ti risponderanno. E tu dirai: questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, né accetta la correzione». E poi, ha sottolineato il Papa, aggiunge una parola «terribile: “La fedeltà è sparita. Voi non siete un popolo fedele”». Qui, ha commentato Francesco, sembra che Dio pianga: «Ti ho amato tanto, ti ho dato tanto e tu... tutto contro di me». Un pianto che ricorda quello di Gesù «guardando Gerusalemme». Del resto, ha spiegato il Pontefice, «nel cuore di Gesù c’era tutta questa storia, dove la fedeltà era sparita». Una storia di infedeltà che riguarda «la nostra storia personale», perché «noi facciamo la nostra volontà. Ma facendo questo, nel cammino della vita seguiamo una strada di indurimento: il cuore si indurisce, si pietrifica. La parola del Signore non entra. Il popolo si allontana». Per questo, ha detto il Papa, «oggi, in questo giorno quaresimale, possiamo domandarci: Io ascolto la voce del Signore, o faccio quello che io voglio, quello che a me piace?».
Il consiglio del salmo responsoriale - «Non indurite il vostro cuore» - si ritrova «tante volte nella Bibbia» dove, per spiegare l’«infedeltà del popolo», si usa spesso «la figura dell’adultera». Francesco ha ricordato, ad esempio, il brano famoso di Ezechiele 16: «Tutta una storia di adulterio, è la tua. Tu, popolo, non sei stato fedele a me, sei un popolo adultero». O anche le tante volte in cui Gesù «rimprovera questo cuore indurito ai discepoli», come fece con quelli di Emmaus: «O stolti e duri di cuore!».
Il cuore malvagio - ha spiegato il Pontefice ricordando che «tutti ne abbiamo un pezzettino» - «non ci lascia capire l’amore di Dio. Noi vogliamo essere liberi», ma «con una libertà che alla fine ci fa schiavi, e non con quella libertà dell’amore che ci offre il Signore».
Questo, ha sottolineato il Papa, succede anche alle «istituzioni»: ad esempio «Gesù guarisce una persona, ma il cuore di questi dottori della legge, di questi sacerdoti, di questo sistema legale era tanto duro, sempre cercavano scuse». E così gli dicono: «Ma tu cacci i demoni in nome del demonio. Tu sei uno stregone demoniaco». Sono cioè dei legalisti «che credono che la vita della fede sia regolata soltanto dalle leggi che fanno loro». Per loro «Gesù usa quella parola: ipocriti, sepolcri imbiancati, tanto belli al di fuori ma dentro pieni di putredine e di ipocrisia».
Purtroppo, ha detto Francesco, lo stesso «è accaduto nella storia della Chiesa». Pensiamo «alla povera Giovanna d’Arco: oggi è santa! Poverina: questi dottori l’hanno bruciata viva, perché dicevano che era eretica». O ancora più vicino nel tempo, pensiamo «al beato Rosmini: tutti i suoi libri all’indice. Non si potevano leggere, era peccato leggerli. Oggi è beato». A tale riguardo il Pontefice ha sottolineato che come «nella storia di Dio con il suo popolo, il Signore mandava, per dirgli che amava il suo popolo, i profeti». E «nella Chiesa, il Signore manda i santi». Sono loro «che portano avanti la vita della Chiesa: sono i santi. Non sono i potenti, non sono gli ipocriti». Sono «l’uomo santo, la donna santa, il bambino, il ragazzo santo, il prete santo, la suora santa, il vescovo santo...»: quelli cioè «che non hanno il cuore indurito», ma «sempre aperto alla parola d’amore del Signore», quelli che «non hanno paura di lasciarsi accarezzare dalla misericordia di Dio. Per questo i santi sono uomini e donne che capiscono tante miserie, tante miserie umane, e accompagnano il popolo da vicino. Non disprezzano il popolo».
Con questo popolo che «ha perso la fedeltà» il Signore è chiaro: «Chi non è con me, è contro di me». Qualcuno potrebbe chiedere: «Ma non ci sarà una via di compromesso, un po’ di qua e un po’ di là?» No, ha detto il Pontefice, «o tu sei sulla via dell’amore, o tu sei sulla via dell’ipocrisia. O tu ti lasci amare dalla misericordia di Dio, o tu fai quello che tu vuoi, secondo il tuo cuore che si indurisce di più, ogni volta, su questa strada». Non c’è, ha ribadito, «una terza via di compromesso: o sei santo, o vai per l’altra via». E chi «non raccoglie» con il Signore, non solo «lascia le cose», ma «peggio: disperde, rovina. È un corruttore. È un corrotto, che corrompe».
Per questa infedeltà «Gesù pianse su Gerusalemme» e «su ognuno di noi». Nel capitolo 23 di Matteo, ha ricordato in conclusione il Papa, si legge una maledizione «terribile» contro i «dirigenti che hanno il cuore indurito e vogliono indurire il cuore del popolo». Dice Gesù: «Verrà su di loro il sangue di tutti gli innocenti, incominciando da quello di Abele. Saranno i colpevoli di tanto sangue innocente, versato dalla loro malvagità, dalla loro ipocrisia, dal loro cuore corrotto, indurito, pietrificato»
*
 See more at: http://www.osservatoreromano.va/it/news/cuori-pietrificati#sthash.KvXHgovA.dpuf
See more at: http://www.osservatoreromano.va/it/news/cuori-pietrificati#sthash.KvXHgovA.dpuf -
>DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO. ---- Bergoglio e la società senza padri (di Gian Guido Vecchi).29 gennaio 2015, di Federico La Sala
Bergoglio e la società senza padri
«Assenti e troppo presi da sé»
di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 29.01.2015)
CITTÀ DEL VATICANO Una «società di orfani», una «società senza padri», perché non ci sono oppure cercano un rapporto «alla pari», da amici, ed è come se non ci fossero. Si è passati «da u n e s t re m o a l l ’a l t ro » , dice Francesco. «Il problema dei nostri giorni non sembra essere più tanto la presenza invadente dei padri, quanto piuttosto la loro assenza, la latitanza. I padri sono talora così concentrati su se stessi, sul lavoro e alle volte sulle proprie realizzazioni individuali, da dimenticare anche la famiglia. E lasciano soli i piccoli e i giovani».
Nell’udienza di ieri il Papa ha sviluppato un tema che gli sta molto a cuore. «Vorrei dire a tutte le comunità cristiane che dobbiamo essere più attenti: l’assenza della figura paterna nella vita dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite che possono essere anche molto gravi», avverte Francesco. «E in effetti le devianze di bambini e adolescenti si possono in buona parte ricondurre a questa mancanza, alla carenza di esempi e di guide autorevoli, alla carenza di vicinanza e amore da parte dei padri. È più profondo di quel che pensiamo il senso di orfanezza che vivono tanti giovani».
È interessante notare che Bergoglio ha una devozione particolare per San Giuseppe, «uomo forte e silenzioso», padre putativo che «custodisce e a c c o m p a g n a G e s ù n e l s u o cammino di crescita» e rappresenta «il modello dell’educatore». A San Giuseppe era dedicata la chiesa di Flores, il quartiere di Buenos Aires dove è nato, la stessa nella quale sentì la sua vocazione.
L’inizio solenne del suo pontificato è avvenuto il 19 marzo, festa di San Giuseppe educatore. Nella stanza 201 a Santa Marta tiene sul tavolo una statua del santo che dorme, «e quando ho un problema, una difficoltà, io scrivo un foglietto e lo metto sotto San Giuseppe, perché lo sogni; questo gesto significa: prega per questo problema!».
Francesco chiede spesso: giocate con i vostri figli, perdete tempo con loro? «Un papà mi diceva: quando vado a lavorare dormono, quando torno la sera lo stesso. Ma questa non è vita, è disumano», raccontava tempo fa.
Così ieri ha ripercorso il passaggio dalla figura «autoritaria» al suo opposto. Si dice che la figura del padre, «specie nella cultura occidentale», sia ormai «simbolicamente assente, svanita, rimossa». Il che, ha ricordato, è stato considerato all’inizio come una «liberazione dal padre padrone». In alcune case «regnava in passato l’autoritarismo o addirittura la sopraffazione».
I figli trattati «come servi».
E ora siamo all’opposto: «I figli sono orfani in famiglia, perché i papà sono spesso assenti da casa ma soprattutto perché, quando ci sono, non si comportano da padri, non dialogano, non adempiono il loro compito educativo, non danno ai figli, con il loro esempio accompagnato dalle parole, quei principi, valori, regole di vita di cui hanno bisogno come del pane». A volte «sembra che i papà non sappiano bene quale posto occupare» e allora «nel dubbio si astengono e trascurano le loro responsabilità, magari rifugiandosi in un improbabile rapporto “alla pari”. È vero che tu devi essere “compagno” di tuo figlio, ma senza dimenticare che tu sei il padre!».
Lo stesso problema si vede pure nella «comunità civile, con le sue istituzioni», ha concluso Francesco: «Così i giovani rimangono orfani di strade sicure da percorrere, di maestri, di ideali. Vengono riempiti di idoli ma si ruba loro il cuore; sono spinti a sognare divertimenti e piaceri, ma non si dà loro il lavoro; illusi col dio denaro, sono negate loro le vere ricchezze».
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- Quaresima 2015. “Rinfrancate i vostri cuori” - Testo integrale del Messaggio di Papa Francesco28 gennaio 2015, di Federico La Sala
AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?!. QUALE SPIRITO?! QUALE FEDE?! QUALE TESTIMONIANZA?! "La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con il suo insegnamento e, soprattutto, con la sua testimonianza". (fls)
Papa Francesco \ Documenti
Papa, Messaggio Quaresima. Il testo integrale *
“Rinfrancate i vostri cuori”. È il titolo del Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2015. Di seguito, il testo integrale del messaggio:
“Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli impedisce di essere indifferente a quello che ci accade. Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono... allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene.
 Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come cristiani, dobbiamo affrontare. Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte a quelle domande che continuamente la storia gli pone. Una delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della globalizzazione dell’indifferenza.
Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come cristiani, dobbiamo affrontare. Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte a quelle domande che continuamente la storia gli pone. Una delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della globalizzazione dell’indifferenza.L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano.
Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si apre definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa è come la mano che tiene aperta questa porta mediante la proclamazione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la testimonianza della fede che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6). Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso e a chiudere quella porta attraverso la quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respinta, schiacciata e ferita.
Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non diventare indifferente e per non chiudersi in se stesso. Vorrei proporvi tre passi da meditare per questo rinnovamento.
1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono” (1 Cor 12,26) - La Chiesa
La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con il suo insegnamento e, soprattutto, con la sua testimonianza. Si può però testimoniare solo qualcosa che prima abbiamo sperimentato. Il cristiano è colui che permette a Dio di rivestirlo della sua bontà e misericordia, di rivestirlo di Cristo, per diventare come Lui, servo di Dio e degli uomini. Ce lo ricorda bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi. Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi, ma poi ha capito che Gesù non vuole essere solo un esempio per come dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. Questo servizio può farlo solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da Cristo. Solo questi ha “parte” con lui (Gv 13,8) e così può servire l’uomo.
La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così diventare come Lui. Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di Dio e quando riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo quell’indifferenza che sembra prendere così spesso il potere sui nostri cuori, non trova posto. Poiché chi è di Cristo appartiene ad un solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. “Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui” (1 Cor 12,26).
La Chiesa è communio sanctorum perché vi partecipano i santi, ma anche perché è comunione di cose sante: l’amore di Dio rivelatoci in Cristo e tutti i suoi doni. Tra essi c’è anche la risposta di quanti si lasciano raggiungere da tale amore. In questa comunione dei santi e in questa partecipazione alle cose sante nessuno possiede solo per sé, ma quanto ha è per tutti. E poiché siamo legati in Dio, possiamo fare qualcosa anche per i lontani, per coloro che con le nostre sole forze non potremmo mai raggiungere, perché con loro e per loro preghiamo Dio affinché ci apriamo tutti alla sua opera di salvezza.
2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) - Le parrocchie e le comunità
Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita delle parrocchie e comunità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a sperimentare di far parte di un solo corpo? Un corpo che insieme riceve e condivide quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna lontano nel mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto davanti alla propria porta chiusa ? (cfr Lc 16,19-31). Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i confini della Chiesa visibile in due direzioni.
In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo nella preghiera. Quando la Chiesa terrena prega, si instaura una comunione di reciproco servizio e di bene che giunge fino al cospetto di Dio. Con i santi che hanno trovato la loro pienezza in Dio, formiamo parte di quella comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore. La Chiesa del cielo non è trionfante perché ha voltato le spalle alle sofferenze del mondo e gode da sola. Piuttosto, i santi possono già contemplare e gioire del fatto che, con la morte e la resurrezione di Gesù, hanno vinto definitivamente l’indifferenza, la durezza di cuore e l’odio. Finché questa vittoria dell’amore non compenetra tutto il mondo, i santi camminano con noi ancora pellegrini. Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa, scriveva convinta che la gioia nel cielo per la vittoria dell’amore crocifisso non è piena finché anche un solo uomo sulla terra soffre e geme: “Conto molto di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è di lavorare ancora per la Chiesa e per le anime” (Lettera 254 del 14 luglio 1897).
Anche noi partecipiamo dei meriti e della gioia dei santi ed essi partecipano alla nostra lotta e al nostro desiderio di pace e di riconciliazione. La loro gioia per la vittoria di Cristo risorto è per noi motivo di forza per superare tante forme d’indifferenza e di durezza di cuore.
D’altra parte, ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone in relazione con la società che la circonda, con i poveri e i lontani. La Chiesa per sua natura è missionaria, non ripiegata su se stessa, ma mandata a tutti gli uomini.
Questa missione è la paziente testimonianza di Colui che vuole portare al Padre tutta la realtà ed ogni uomo. La missione è ciò che l’amore non può tacere. La Chiesa segue Gesù Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino ai confini della terra (cfr At 1,8). Così possiamo vedere nel nostro prossimo il fratello e la sorella per i quali Cristo è morto ed è risorto. Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto questi fratelli possiedono è un dono per la Chiesa e per l’umanità intera.
Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!
3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) - Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza?
In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa necessità della preghiera.
In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo interesse all’altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra partecipazione alla comune umanità.
E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite possibilità che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere alla tentazione diabolica che ci fa credere di poter salvarci e salvare il mondo da soli.
 Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima come un percorso di formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 31). Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e si spende per l’altro.
Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima come un percorso di formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 31). Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e si spende per l’altro.Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Rendi il nostro cuore simile al tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione dell’indifferenza. Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca”.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE ... "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") ---- DIO E IL VITELLO D’ORO (di Ernesto Balducci)11 giugno 2014, di Federico La Sala
DIO E IL VITELLO D’ORO
di Ernesto Balducci *
«La suggestiva narrazione di Mosè che, dopo avere spezzato le pietre - il popolo, mentre egli parlava con Dio si era costruito il vitello d’oro -, se ne ritorna alla sorgente, al Dio dell’alleanza per invocare perdono ed avere una nuova legge, suscita immediatamente una analogia che non può non diventare un discorso di severa condanna per noi che ci diciamo e siamo popolo di Dio. Se scendesse ancora una volta il profeta dalla montagna e venisse verso di noi con la legge, dovrebbe spezzare di nuovo le tavole perché questo popolo di Dio che ha eretto templi, ha scritto biblioteche intere sul mistero di Dio però l’ha fatto per potersi meglio consentire la costruzione del vitello d’oro. Ditemi voi se non c’è il vitello d’oro nelle piazze della società evoluta di oggi, la quale ha costruito intorno al vitello d’oro una cintura di armi spaventosa per la sua difesa.
Questo è, seguendo il filo dell’immaginazione messomi in mano dalla Scrittura, lo stato delle cose. Il dramma è che noi continuiamo a parlare di Dio - eccoci qui anche oggi - noi continuiamo a girovagare per il mondo con i suoi simboli, con le sue tavole, mentre indisturbata, sicura di sé la società danza attorno al vitello d’oro, unica vera onnipotenza, quella che in un piccolo sgarro mistico il padre dell’economia moderna chiamò «la mano invisibile», la logica del profitto, una specie di Spirito Santo invisibile che tutto fa e tutto può. E questo popolo, a diversità di quello delle origini che fu oggetto delle ire di Mosè, non è funestato da nessuna ira, anzi gli esperti, gli scribi e i pontefici, sono, tutto sommato, benevoli, spesso anche complici di questa danza attorno al vitello d’oro. Ecco perché tutte le nostre creazioni portano in sé almeno qualche segno del culto del vitello d’oro. Perfino gli sforzi - come quello che noi oggi generosamente facciamo - di creare una Europa unita si poggiano sulla logica del mercato onnipotente.
Ogni volta che la nozione di Dio è contaminata dal culto del vitello d’oro, occorre risalire la montagna per avere di Dio un’altra definizione, perché Dio si contamina nelle nostre contaminazioni. La Sua immagine, la Sua nozione non è una nozione, una immagine pura, estranea ai miasmi del nostro esistere. Attraverso i concetti, anche i più limpidi e cristallini, passa il fiato malefico delle nostre passioni.
Quando si elaborò la mirabile teologia sulla Trinità, sul dogma si posò la spada di Costantino che disse: «chi non ci crede, lo ucciderò!». Vuol dire che c’era, perfino in quella teologia, una specie di omogeneità allo spirito di potenza. E difatti, una volta chiuso il mistero di Dio negli alti logaritmi teologici, chi ne poteva parlare? Soltanto gli esperti. Il Dio di Gesù Cristo fu annunciato da degli analfabeti i quali non avevano nessuna preoccupazione di spiegare che Dio è Uno in Tre persone uguali fra loro, dato che nessuno si preoccupava di interrogarli su questa uguaglianza.
Quel messaggio era un messaggio di salvezza e non la rivelazione di arcani segreti o di arcane dottrine. Poi, invece, è avvenuto che questa dottrina sulla unità e trinità di Dio si è resa raffinatissima, tanto che chiunque ne osa parlare senza i titoli di studio adeguati incappa in gravissimi errori. Allora, per evitare l’errore, si impedisce la predicazione, o meglio, si monopolizza.
Avvenne, nel cuore del Medio Evo, che quel santo dei santi che è Francesco d’Assisi potesse, sì, andare a predicare, purché non parlasse di Dio, dato che di Dio potevano parlare soltanto i «clerici», gli esperti, e lui era un laico. Francesco, con una specie di inconscia astuzia, tutta evangelica, predicò la pace, tema su cui i clerici lasciavano fare».
*
Ernesto Balducci, Il Vangelo della Pace; vol. 1; pag. 189-191 - segnalazione di don Aldo Antonelli)
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- EVANGELII GAUDIUM. Il manifesto del Papa: no al dio denaro. Ecco la Chiesa di Bergoglio.27 novembre 2013
Il manifesto del Papa: no al dio denaro
di Franca Giansoldati (Il Messaggero, 27 novembre 2013)
La road map di Bergoglio è racchiusa in 214 pagine, un manifesto programmatico di sette punti. E’ la rivoluzione gentile della Chiesa, anche se per certi versi più che di rivoluzione gentile si tratta di un vero e proprio terremoto che sta per abbattersi su un certo modo di pensare.
Papa Francesco vuole scardinare quel «tanto si è sempre fatto così», comodo criterio pastorale in bilico tra il clericalismo e l’immobilismo, destinato a finire in soffitta.
Perchè bisogna dare una scossa esistenziale ai cattolici, a cominciare dai vertici ecclesiali. Innanzitutto con l’esempio personale e il papato di certo non può stare alla finestra: «Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una conversione del papato» scrive Bergoglio nell’esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, scritta quest’estate di ritorno dal Brasile.
Il testo riprende il filo delle grandi riforme sul ministero petrino introdotte da Giovanni Paolo II nell’enciclica Ut unum sint. Finora però, ammette il Papa «siamo avanzati poco in questo senso». Ecco perché ci si trova ancora a combattere «contro un centralismo burocratico» che rischia di soffocare le iniziative delle periferie. Tutto il contrario di quello che afferma il Vaticano II.
Bergoglio vuole più collegialità tra i vescovi, dando anche maggiore potere alle conferenze episcopali, persino in campo dottrinale, il che significa che alcuni episcopati particolarmente progressisti potrebbero forse sperimentare strade pastorali innovative per andare incontro, ad esempio, al grande problema dei divorziati risposati, delle coppie di fatto, dell’uso degli anticoncezionali. Chissà.
IL CORAGGIO
«Una eccessiva centralizzazione anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria». Sicché la Chiesa che il nuovo Papa sta disegnando giorno dopo giorno dovrà dimostrare audacia nel ripensare ai metodi di evangelizzazione, ma anche allo stile, applicando in toto la Evangelii Gaudium «senza divieti né paure».
Il Papa avverte: se questo invito «non risplenderà con forza e attrattiva, l’edificio morale della Chiesa corre il rischio di diventare un castello di carte e questo è il nostro peggior pericolo». E’ la Chiesa delle periferie, dei lontani, aperta a tutti che bussa alla porta di San Pietro, nel cuore del potere arroccato e autoreferenziale. «La Chiesa non è una dogana, ma è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa».
Un invito che non dovrebbe essere oscurato da approcci pastorali incapaci di fare risplendere la misericordia, la tenerezza, la forza propulsiva del Vangelo. L’analisi di Bergoglio sullo stato delle cose per certi versi è impietosa.
Troppe regole, accenti dottrinali «procedono determinate opzioni ideologiche» soffocano la freschezza della Parola. «Vogliamo essere generali di eserciti sconfitti o semplici soldati di uno squadrone che continua a combattere?» Che fare? Tanto per cominciare invertire la tendenza di tanti preti ad un eccesso di mondanità. Comodità, carriera, denaro sono bandite. E poi modificare il modo di parlare alla gente con un linguaggio efficace e semplice. Infine i poveri devono essere il perno della visione sociale di una Chiesa intesa come la totalità del popolo di Dio che evangelizza.
L’INDIVIDUALISMO
I pericoli all’orizzonte restano l’individualismo e una «nuova idolatria del denaro», che poi sono i mali che hanno portato «alla dittatura di una economia senza volto e senza uno scopo veramente umano». Dove i mercati la fanno da padroni, dove la corruzione e l’evasione fiscale dilagano, e la brama del potere «non conosce più limiti».
Ai cristiani chiede di portare avanti una solidarietà disinteressata perché il denaro «deve servire e non governare». Bergoglio risponde anche (indirettamente) a chi lo accusa di pauperismo: «Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma ha l’obbligo, in nome di Cristo, di ricordare che i ricchi devono aiutare i poveri, rispettarli e promuoverli».
E a chi, invece,lo critica per i suoi accenti populisti ribatte: «l’economia non può più ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, come quando si pretende di aumentare la redditività riducendo il mercato del lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi». Sulla famiglia e sul matrimonio, invece, ripete che la Chiesa non può che difendere la tradizione, sarebbe un errore «modificarsi secondo la sensibilità di ognuno».
Così come sull’aborto, non ci si potrà certo «attendere che cambi la sua posizione» perché «non è progressista pretendere di risolvere i problemi eliminando una vita umana».
Infine una avvertenza: «Se qualcuno si sente offeso delle mie parole, gli dico che le esprimo con la migliore delle intenzioni, lontano da qualunque interesse personale o ideologia politica. Mi interessa fare in modo che chi è individualista possa liberarsi da quelle catene». Ecco la Chiesa di Bergoglio.
Franca Giansoldati
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA --- PER DIRIMERE GLI EQUIVOCI. Papa Francesco: un’enciclica sulla fede scritta insieme a Benedetto XVI (di Rosario Amico Roxas)13 giugno 2013, di Federico La Sala
Un’enciclica per dirimere gli equivoci nella Chiesa di Papa Francesco.
di Rosario Amico Roxas
Papa Francesco: un’enciclica sulla fede scritta insieme a Benedetto XVI (Il Messaggero del 12 giugno 2013)
*******************
Deve essersi mossa la diplomazia vaticana per individuare il modo come far retrocedere Ratzinger dalla sua personale interpretazione teologica e sociale, senza doversi attendere una pubblica retromarcia dell’Emerito. E’ stata scelta una via mediana con una enciclica a quattro mani, dove “le mani” di Papa Francesco riprenderanno la via dei Vangeli e dell’insegnamento di Cristo, ma non si saprà mai quali parti saranno da attribuire a l’uno o all’altro dell’imminente enciclica.
Sarà interessante valutare le parole i concetti che andremo a leggere e studiare, con la storia culturale, teologica e sociale di Ratzinger e non limitatamente al suo pontificato, ma regredendo all’attività svolta in tanti anni ai vertici della Congregazione per la Fede, ex sant’ufficio, ex Inquisizione.
Pretendere che un pontefice, oltre alle dimissioni ,che considero come un fatto non eludibile e consequenziale al fallimento della sua teologia personalistica, rinnegasse se stesso, sarebbe stato eccessivo, ma, pur tuttavia, era necessario fare il punto sulla posizione ufficiale della Chiesa, a cominciare da quelle “radici cristiane dell’Europa” che sono apparse più come una caratteristica antropologica che non una condizione scaturita dall’insegnamento di Cristo.
Né rimane credibile quella presentazione al libercolo di Pera “Perché dobbiamo dirci cristiani”, firmato Benedetto XVI, quindi nella qualità di Pontefice in carica, dove il liberismo, in auge con i governi Berlusconi, veniva assimilato al cristianesimo, come se la predicazione della montagna e le “Beatitudini” fossero state solamente una recita a soggetto, con l’aggiunta della confermata impossibilità di aprire un dialogo interreligioso con le altre religioni, contraddicendo le determinazioni del Concilio Vaticano II. Il lavorio a quattro mani di Ratzinger con Pera ha rappresentato una involuzione verso il nulla delle certezze che i credenti affidano alla Fede più che alle speculazioni filosofico-teologiche.
Anche Paolo VI ebbe una vivificante collaborazione con un laico, ma si trattava di j. Maritain; così è emersa la distinzione dei valori tra Montini e Maritain da una parte e Ratzinger e Pera dall’altra che non poteva concludersi diversamente dalle dimissioni che con due anni di anticipo ebbi a prevedere.
Andavano chiariti gli equivoci e gli errori, pur senza dividere il mondo cattolico e rinnegare il pontificato di Ratzinger che così viene dimensionato “senza infamia e senza lode”.
Credo che si sarà molto da valutare in una analisi parallela, perché si tratterà di grande lezione di cultura diplomatica insieme alla conferma della strada maestra che Papa Francesco ha lasciato già intravedere; non potevano rimanere gli equivoci che hanno fatto rischiare uno scisma, così parlerà Papa Francesco con i fatti e le azioni, ma con la voce di Rartzinger che non apparirà nemmeno sul proscenio.
Rosario Amico Roxas
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE --- CON L’ AIUTO DEL PAPA PASTORE, LA SUA "LUMEN FIDEI". La prima enciclica scritta da due papi (di Frederic Mounier)5 luglio 2013, di Federico La Sala
FRANCESCO, IL NUOVO PAPA, OLTRE IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI:
DAL "DEUS CARITAS EST" AL "DEUS CHARITAS EST"?
“Lumen Fidei”, la prima enciclica scritta da due papi
di Frédéric Mounier
in “La Croix” del 5 luglio 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)
Ci saranno le firme di entrambi i papi sulla “loro” enciclica, pubblicata oggi a metà giornata? Si può pensare di no, dato che la Sala stampa della Santa Sede la presenta come l’enciclica di papa Francesco. Resta il fatto che Lumen Fidei, che sarà ampiamente diffusa in Italia, dove la Libreria editrice del Vaticano ne ha già stampato 500 000 copie (pp. 90, € 3,50), è sicuramente, e la cosa è già di per sé un evento nuovo, frutto del lavoro “a quattro mani”, come ha detto lo stesso papa Francesco, dei due papi viventi, l’emerito e il regnante.
L’indomani della rinuncia di papa Ratzinger, l’11 febbraio scorso, la sorte di questo testo era ancora molto incerta. Si sapeva che Benedetto XVI aveva deciso di completare la sua trilogia cominciata il 25 gennaio 2006 con Deus caritas est sulla carità, proseguita il 30 novembre 2007 con Spe salvi sulla speranza, con un’enciclica sulla prima delle tre virtù cardinali: la fede.
Questo testo, che si dava già per molto avanzato, avrebbe potuto restare nella grande scatola bianca posta sul tavolo di Castel Gandolfo durante l’incontro storico tra i due uomini in bianco, il 23 marzo scorso. Joseph Ratzinger avrebbe anche potuto, come aveva scelto per la sua trilogia su Gesù, di firmarla con il suo nome personale, e non come atto del suo magistero.
Papa Francesco ha deciso altrimenti, spazzando via le previsioni ufficiali. Il 13 giugno, improvvisando davanti ai membri della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, si è lasciato andare ad una confidenza: “Ora deve uscire un’enciclica a quattro mani”. Proprio quella che Benedetto XVI aveva cominciato: “Me l’ha trasmessa. È un documento forte. È lui che ha fatto il grosso del lavoro, e io lo proseguirò”.
Ormai è cosa fatta. Segnando così una continuità pontificia evidente sui contenuti, se non sulla forma, il papa argentino, pastore dei poveri, riprende in prima persona il lavoro minuzioso e preciso realizzato dal teologo professore universitario tedesco. Sia l’uno che l’altro si preoccupano di un ritorno essenziale ai dati fondamentali della fede cristiana, che deve essere sempre e ovunque approfondita. Come ha ripetuto nella sua omelia a Santa Marta martedì scorso, papa Francesco rifiuta sia il pelagianesimo che lo gnosticismo, sia il rigorismo formale che l’evanescenza spirituale.
Per i due papi, l’incontro con Cristo è centrale. Sarà probabilmente al centro di questa enciclica. Firmando la sua prima enciclica esattamente a quattro mesi dalla sua elezione, papa Francesco ha, anche in questo ambito, sconvolto i tempi pontifici. Il suo predecessore aveva aspettato otto mesi.
È vero che già Deus caritas est aveva beneficiato di apporti importanti lasciati da Giovanni Paolo II. Che aveva dedicato sei mesi a redigere Redemptoris hominis , il suo primo testo forte. Paolo VI aveva avuto bisogno, invece, di quattordici mesi per Ecclesiam suam del 6 agosto 1964.
Se l’impostazione ratzingeriana di Lumen Fidei suscita pochi interrogativi, l’apporto del papa argentino sarà invece scrutato con grande interesse. In effetti, le fonti “bergogliane” in materia di teologia fondamentale non sono così numerose.
Nell’ottobre 2012, l’arcivescovo di Buenos Aires aveva scritto alla sua diocesi in occasione dell’apertura dell’Anno della fede. Invitava gli uomini di buona volontà a “varcare la soglia della fede” poiché “Gesù ne è la porta”.
Precedentemente, nel 2007, ricordiamo che era stato uno dei redattori essenziali del documento detto “di Aparecida” , pubblicato al termine dell’incontro di tutti gli episcopati latino-americani. Insieme, avevano lanciato un appello alla “missione continentale”.
Più recentemente, il 18 maggio scorso, la vigilia di Pentecoste, papa Francesco aveva improvvisato in Vaticano davanti ad una folla composta di membri di movimenti di evangelizzazione. Si era situato in una prospettiva molto dinamica, insistendo sulla persona di Cristo, sulla necessità della preghiera “che non è una strategia”.
Ai suoi occhi, la testimonianza è vitale, così come l’attenzione ai poveri, “carne di Cristo”. E il battezzato, facendo di tutto per evitare di “chiudersi”, deve però coltivare la modestia, l’umiltà. Questi elementi, rielaborati da papa Francesco, potrebbero costituire la prefazione, o la conclusione, di questa prima enciclica comune ai due papi viventi.
Lumen Fidei aprirà la strada ad altri testi molto attesi del papa argentino. Dedicherà il mese d’agosto, in Vaticano, ma senza udienze, a lavorare sulla esortazione apostolica successiva al sinodo del 2012 sulla nuova evangelizzazione. Riprendendo le proposizioni e il messaggio finale, ha previsto di dare loro maggiore ampiezza, anche in questo caso spianando la via a prospettive dinamiche aperte a tutti. Ma di quel testo, sarà autore lui solo.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE --- La "Lumen Fidei", l’ enciclica, a quattro mani. Il testo porta la firma di Bergoglio ma in controluce si legge la prima stesura di Ratzinger (di Andrea Gualtieri)5 luglio 2013, di Federico La Sala
 Lumen Fidei, enciclica a quattro mani.
Lumen Fidei, enciclica a quattro mani.
 "La luce della Fede illumina la vita"
"La luce della Fede illumina la vita"Il testo porta la firma di Bergoglio ma in controluce si legge la prima stesura di Ratzinger. Una riflessione sull’amore e sulla natura dell’uomo. Con riferimenti al matrimonio, alla famiglia e ad un mondo che non si basi solo su utili e profitti. "Papa Giovanni e Woytjla saranno santi"
di ANDREA GUALTIERI (la Repubblica, 05.07.2013)
Lumen Fidei, enciclica a quattro mani. "La luce della Fede illumina la vita" (ansa) QUATTRO capitoli più un’introduzione e una conclusione. E una traccia chiara: anche se si è pensato che "non servisse per i nuovi tempi, per l’uomo diventato adulto, fiero della sua ragione, desideroso di esplorare in modo nuovo il futuro", la "luce della fede" è "capace di illuminare tutta l’esistenza" perché è "in grado di valorizzare la ricchezza delle relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere affidabili, di arricchire la vita comune". Appaiono tredici volte le espressioni "vita comune" e "bene comune" nel testo dell’enciclica "Lumen fidei", presentata stamattina in Vaticano dai cardinali Mark Ouellet e Gerhard Muller, prefetti della Congregazioni dei vescovi e della dottrina della fede, e dall’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione.
UN’ENCICLICA A QUATTRO MANI - Ottantadue pagine scritte a quattro mani. Nell’ultima c’è la firma autografa di Francesco, il pontefice regnante. Ma in controluce si legge anche quella di Benedetto XVI, il papa emerito, che proprio stamattina insieme al suo successore argentino ha benedetto la statua di San Michele Arcangelo davanti al Governatorato. Nella Lumen Fidei è lo stesso Bergoglio a scrivere senza remore che dopo le lettere sulla carità e sulla speranza, Ratzinger "aveva già quasi completato una prima stesura di Lettera enciclica sulla fede": "Gliene sono profondamente grato - afferma Francesco - e, nella fraternità di Cristo, assumo il suo prezioso lavoro, aggiungendo al testo alcuni ulteriori contributi".
Alcuni appaiono evidenti. Come la metafora usata nel primo capitolo: "In tanti ambiti della vita ci affidiamo ad altre persone che conoscono le cose meglio di noi. Abbiamo fiducia nell’architetto che costruisce la nostra casa, nel farmacista che ci offre il medicamento per la guarigione, nell’avvocato che ci difende in tribunale". Papa Francesco, che è solito usare immagini vicine al vissuto comune, sottolinea che "abbiamo anche bisogno di qualcuno che sia affidabile ed esperto nelle cose di Dio" e inquadra in questo modo la figura di Cristo come "colui che ci spiega Dio", attraverso "il suo modo di conoscere il Padre, di vivere totalmente nella relazione con lui".
SENZA FEDE SI STA UNITI PER PAURA E INTERESSI - Parte da lì, spiega il pontefice, la propagazione della fede che "si trasmette nella forma del contatto, come una fiamma che si accende dall’altra" tanto che "è impossibile credere da soli" perché non si tratta di "un’opzione individuale". Proprio sulla base dell’esperienza cristiana, si comprende, secondo il Papa, anche "l’architettura dei rapporti umani": "Senza un amore affidabile - si legge nell’enciclica - nulla potrebbe tenere veramente uniti gli uomini. L’unità tra loro sarebbe concepibile solo come fondata sull’utilità, sulla composizione degli interessi, sulla paura, ma non sulla bontà di vivere insieme, non sulla gioia che la semplice presenza dell’altro può suscitare". Proprio nell’amore, invece, "è possibile avere una visione comune", imparando a vedere la realtà con gli occhi dell’altro, in un atteggiamento che "non ci impoverisce, ma arricchisce il nostro sguardo".
NELLA SOCIETA’ MA SENZA ARROGANZA - Ed è in questo spirito che il Papa afferma che "la luce della fede si pone al servizio concreto della giustizia, del diritto e della pace". Nel quarto capitolo si legge infatti del rispetto per il creato e di come i credenti siano chiamati a trovare per il pianeta "modelli di sviluppo che non si basino solo sull’utilità e sul profitto". Si affronta il tema dei rapporti sociali, con un richiamo alla fraternità, inseguita in tutta la storia della fede che, ammette Francesco, non è stata priva di conflitti. E si fa appello alla ricerca di forme giuste di governo, "riconoscendo che l’autorità viene da Dio per essere al servizio del bene comune".
Una fede che si riflette sulla società, nell’ambito della quale però il credente non può mostrarsi "arrogante" perché la sicurezza "lungi dall’irrigidirci - scrive il Papa - rende possibile la testimonianza e il dialogo con tutti".
MATRIMONIO UOMO-DONNA GENERA FEDE - Una fede, poi, che deve maturare dalla famiglia. E in questo c’è un richiamo al matrimonio, che nasca "dal riconoscimento e dall’accettazione della bontà della differenza sessuale" e che trovi la forza di essere una promessa "per sempre" nell’ottica di un disegno più grande dei propri progetti, "che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona amata". Fondati su quest’amore, sottolinea il Papa, "uomo e donna possono promettersi l’amore mutuo con un gesto che coinvolge tutta la vita e che ricorda tanti tratti della fede".
"NON FACCIAMOCI RUBARE LA SPERANZA" - Uno spazio Bergoglio lo dedica anche ai giovani e al loro modo di vivere la fede con gioia, come manifestato nelle Giornate mondiali della gioventù. Di contro, però, citando l’esempio di san Francesco e madre Teresa di Calcutta come testimoni della carità, Bergoglio ricorda che Dio parla anche "all’uomo che soffre": non dona loro un ragionamento che spieghi tutto, ma "offre la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna, di una storia di bene che si unisce ad ogni storia di sofferenza per aprire in essa un varco di luce". E’ il preludio di un passaggio che cristallizza nel documento un’espressione molto ricorrente in papa Francesco: "Non facciamoci rubare la speranza, non permettiamo che sia vanificata con soluzioni e proposte immediate che ci bloccano nel cammino".
WOJTYLA E RONCALLI SARANNO SANTI - L’enciclica, che porta la data del 29 giugno, è stata divulgata stamattina, nel giorno in cui papa Francesco ha pure firmato i decreti per la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II che saranno proclamati santi insieme entro la fine dell’anno. Il pontefice ha approvato il miracolo attribuito all’intercessione del suo predecessore polacco e ha sottoscritto i voti favorevoli della sessione ordinaria della Congregazione delle cause dei santi sul fascicolo del "Papa buono". Un’espressione, quest’ultima, che conferma che la canonizzazione di Roncalli avverrà derogando dall’accertamento del miracolo con una decisione che solo il pontefice poteva prendere e che permette all’ideatore del Concilio di compiere l’ultimo passo verso la gloria degli altari proprio a cinquant’anni dalla morte. La data precisa sarà annunciata nel corso di un concistoro convocato da Bergoglio, ma è probabile che si converga sull’8 dicembre. Approvati oggi anche i decreti relativi a miracoli che aprono la via alla beatificazione del primo successore di Escrivà alla guida dell’Opus Dei, il vescovo Alvaro del Portillo, e di Madre Speranza, la spagnola suor Maria Giuseppa Alhama Valera, fondatrice delle Congregazioni delle Ancelle dell’Amore Misericordioso e dei Figli dell’Amore Misericordioso.
-
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- La “bozza Ratzinger” di una nuova enciclica (di Paolo Rodari - Ratzinger torna, due Papi in Vaticano)30 aprile 2013, di Federico La Sala
Ratzinger torna, due Papi in Vaticano
di Paolo Rodari (la Repubblica, 30 aprile 2013)
Mancano poche ore al ritorno di Benedetto XVI in Vaticano. Da quando il Papa emerito metterà piede nel suo nuovo alloggio, il monastero Mater Ecclesiae, inizierà entro le mura leonine l’inedita “coabitazione” col suo successore Papa Francesco.
S’incontreranno i due? Bergoglio, quando ne sentirà il bisogno, lascerà la residenza di Santa Marta per andare dall’altra parte dei giardini vaticani a trovare il suo predecessore? Difficile rispondere. Di certo c’è che una certa collaborazione fra i due è già iniziata, almeno sul piano teologico.
Infatti, come Ratzinger scrisse la sua prima enciclica, la “Deus caritas est”, nel Natale del 2005, rimodellando un testo sul quale stava lavorando il suo predecessore Giovanni Paolo II, così Papa Francesco potrebbe dare presto alle stampe - si dice entro il prossimo autunno - la sua prima lettera enciclica intervenendo su una bozza dedicata al tema della fede che Benedetto XVI gli ha consegnato durante il loro ultimo incontro avvenuto a Castel Gandolfo il 23 marzo. Se la pubblicazione avverrà, potrebbe essere l’inizio di una collaborazione, seppur discreta, anche su altri temi. Ratzinger, infatti, dal Mater Ecclesiae, sarà ben attrezzato per dare consigli anche teologici al suo successore.
La “bozza Ratzinger” di questa nuova enciclica, un testo di circa 30-40 cartelle, ha avuto una genesi fulminea. Lo scorso ottobre Benedetto XVI, aprendo un anno dedicato alla fede, ha chiesto all’ufficio dottrinale dell’ex Sant’Uffizio di lavorare su una prima bozza che avesse al centro il tema della fede alla luce dei suoi interventi in merito, non soltanto i testi papali ma anche i libri, su tutti il volume del 1968 “Introduzione al cristianesimo”. I teologi vaticani, dopo poche settimane, gli hanno inviato un testo che ha rimandato indietro chiedendo un ulteriore lavoro. La seconda bozza gli è stata consegnata circa un mese prima dell’annuncio della rinuncia al soglio di Pietro.
Ratzinger l’ha tenuta con sé, per poi consegnarla a Bergoglio dicendogli di decidere lui cosa farne. Dicono oltre il Tevere: «Il testo è completo. Dottrinalmente è ineccepibile e ben fatto». La fede è stato il tema principale del pontificato di Benedetto XVI. “Dove c’è Dio, là c’è futuro”, fu non a caso il titolo che egli volle dare alla sua terza visita in Germania, nel 2011. Il programma del pontificato aveva al centro il tentativo di riavvicinare gli uomini a Dio. Ma la sfida riguardava e riguarda anche la Chiesa, nella consapevolezza più volte esplicitata che la crisi profonda della Chiesa odierna «è una crisi di fede ».
È anzitutto la Chiesa ad aver perso la bussola, quasi a non conoscere più l’abc della fede. Di qui un anno dedicato al tema. E un’enciclica ora nelle mani di Bergoglio che, dopo un suo intervento, potrebbe renderla pubblica.
-
>“Ratzinger non era all’altezza. Vatileaks, il colpo finale”. Intervista al teologo Leonardo Boff (di Alessandro Oppes).1 marzo 2013, di Federico La Sala
 Il teologo Leonardo Boff
Il teologo Leonardo Boff
 “Ratzinger non era all’altezza. Vatileaks, il colpo finale”
“Ratzinger non era all’altezza. Vatileaks, il colpo finale” Come prefetto del Sant’Uffizio, scrisse una lettera in cui chiedeva ai vescovi di impedire che i preti pedofili venissero portati davanti ai tribunali
Come prefetto del Sant’Uffizio, scrisse una lettera in cui chiedeva ai vescovi di impedire che i preti pedofili venissero portati davanti ai tribunalidi Alessandro Oppes (il Fatto, 1.03.2013)
“Una grande pena. Pena e compassione”. Nel lungo ragionamento, a tratti molto duro, di Leonardo Boff sulla figura del Papa che da ieri sera non è più Papa, queste sono forse le parole di maggiore vicinanza e comprensione. Pena per l’implicita ammissione di un fallimento, compassione per la figura di un pontefice che ha dovuto gettare la spugna di fronte all’enormità di una missione costellata di ostacoli insormontabili, in un ambiente diventato ormai irrespirabile.
Dell’uomo che un tempo gli fu amico, il grande teologo brasiliano ricorda ancora che è “una persona estremamente gentile, estremamente cortese, estremamente timida, estremamente intelligente”. Così, senza tralasciare neppure un superlativo.
Nonostante tutto, pur se di mezzo, e dopo una frequentazione proficua durata cinque anni in Germania, ci fu quel famoso processo sommario: il Ratzinger che, una volta nominato cardinale di Curia e assurto alla guida del’’ex-Sant’Uffizio, nel 1984 convoca Boff in Vaticano e lo condanna al “silenzio ossequioso” per zittire la voce scomoda della Teologia della liberazione, di cui era rappresentante di punta.
“Da allora, non ci siamo più visti. Io non ho mai conservato rancore nè risentimento, perché ho capito la logica che determinava quella decisione, pur non essendo d’accordo. Il suo sospetto era che la nostra visione teologica fosse il cavallo di Troia attraverso il quale il marxismo si faceva strada nella Chiesa. Questa era la sua idea. Ma so che ancora oggi, quando parla di me, si esprime in termini persino affettuosi. Mi definisce come ‘il teologo pio’”
Leonardo Boff, oggi 75enne, risponde alle domande del Fatto Quotidiano al telefono dalla sua casa di Jardim Araras, una riserva ecologica alla periferia di Petropolis, l’antica città imperiale brasiliana che fu residenza dei Bragança, a poco più di un’ora di distanza da Rio de Janeiro.
Un gesto rivoluzionario, o semplicemente umano, quello di Benedetto XVI che abbandona la cattedra di Pietro?
Un chiaro gesto d’impotenza, in parte dovuto all’età, in parte alla gravità dei crimini nei quali l’istituzione ecclesiastica si è vista immersa nel corso di questi ultimi anni. Scandali sessuali, sete di denaro, pedofilia. Il vero Spirito Santo, di questi tempi, si chiama Vatileaks. Di fronte a questa situazione, il Papa è stato colto da una profonda depressione.
Una fuga dalle responsabilità?
No, è qualcos’altro: è un Papa che demitizza la figura del Papa, che si riconosce umano come tutti gli altri umani. C’è tutta una papolatria che è stata coltivata troppo a lungo, soprattutto per interessi interni alla gerarchia vaticana. Lui, con un gesto inedito e in questo senso da lodare, è stato capace di distinguere tra la persona del Papa, che può essere malata, o sentirsi per qualche motivo debole, e la funzione del Papa, che è quella di governare la Chiesa.
Non è rimasto sorpreso da questa decisione?
No, posso dire che me l’aspettavo. Joseph Ratzinger è uomo troppo sensibile e timido, incapace di maneggiare i conflitti. Ad un certo punto ha capito di avere a che fare con una sorta di governo parallelo gestito dal cardinale Tarcisio Bertone.
In sostanza, pensa che non sia stato all’altezza delle circostanze?
Non solo non è stato all’altezza delle sfide, ma ha anche commesso una serie di errori molto gravi. Prima con i musulmani, con quell’infelice discorso all’università di Ratisbona che provocò violente reazioni nel mondo islamico. Poi con gli ebrei, urtandone la sensibilità. Poi con i levebvriani, annullando la scomunica del vescovo Williamson, negatore dell’Olocausto. Ha fatto della Chiesa un’istituzione machista e reazionaria, che ha mantenuto un rapporto estremamente negativo con le donne, con gli omosessuali, che non ha saputo affrontare i temi della morale sessuale.
Si è molto polemizzato intorno ai silenzi e i ritardi del Papa sugli scandali di pedofilia.
L’origine della questione risale all’epoca in cui era ancora cardinale: come prefetto dell’ex Sant’Uffizio, scrisse una lettera in cui chiedeva ai vescovi di impedire che i preti pedofili venissero portati davanti ai tribunali. Poi, da Papa, quando cominciavano a emergere le prove del coinvolgimento non solo di sacerdoti ma anche di vescovi e cardinali in quelle pratiche, si è dovuto ricredere, ha cominciato a prendere decisioni per bloccare il fenomeno. Ma non sarà mai possibile dimenticare che si è reso complice di quei crimini.
Nella sua ultima intervista, il cardinale Carlo Maria Martini disse che la Chiesa è rimasta in ritardo di almeno duecento anni. Condivide questa valutazione?
Io andrei ancora più in là, parlando non di 200 ma almeno di 500 anni e anche più. Dall’epoca della Riforma la Chiesa ha un atteggiamento negativo nei confronti del mondo, chiamando la democrazia come delirio moderno. É rimasta afferrata al tempo medioevale. Questo Papa, ancor più che i suoi predecessori, ha recuperato quella vecchia tesi secondo cui fuori della Chiesa non c’è salvezza.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE ---- LA FINE DEL PONTIFICATO: IL PAPA EMERITO, L’ANELLO DEL PESCATORE (PIRATA) DISTRUTTO, E UNA BUONA OCCASIONE PER LA CHIESA.28 febbraio 2013, di Federico La Sala
MESSAGGIO DELL’EVANGELO ("DEUS CHARITAS EST": 1 Gv. 4.8), MESSAGGIO DEL POSSESSORE DELL’"ANELLO DEL PESCATORE" ("DEUS CARITAS EST": BENEDETTO XVI, 2006), E TEOLOGIA POLITICA DELL’"UOMO SUPREMO" ("DOMINUS IESUS", 2000):
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE ---- LA FINE DEL PONTIFICATO: L’ULTIMO DISCORSO (di Massimo Faggioli)28 febbraio 2013, di Federico La Sala
L’ultimo discorso
di Massimo Faggioli (Huffington Post Italia, 27 febbraio 2013)
L’ultimo discorso di papa Benedetto XVI, tenuto in piazza San Pietro all’ultima udienza generale di mercoledì 27 febbraio, non è forse il più importante del suo pontificato dal punto di vista teologico e politico, ma è di certo il più importante e il migliore tenuto da Joseph Ratzinger da vescovo.
In un certo senso, questo discorso potrebbe plasmare la sua eredità e percezione, e fare di Benedetto XVI un papa emerito molto più "popolare" di quanto non lo sia stato come papa sulla cattedra di Pietro in questi otto difficili anni. Nel discorso il papa non ha nascosto le difficoltà attraversate dal pontificato, e non ha nascosto - cosa rimarchevole per un papa - la sensazione di abbandono da parte di Dio, la stessa sensazione che tanti altri cristiani provano in molti momenti della loro vita.
Il discorso non è stato privo di accenti tipici dei discorsi di Giovanni XXIII, tesi a ridimensionare la "mistica papale" - quell’aura di sacralità creata nei secoli attorno al papato non solo come ufficio nella chiesa, ma anche attorno alla persona. Ma allo stesso tempo, il ridimensionamento della mistica papale ha un contrappasso, vale a dire il suo ruolo universale, e non solo per la chiesa o i cattolici: "il cuore di un Papa si allarga al mondo intero". Questo è uno dei costi maggiori e più difficili da sostenere per il papa e per il cattolicesimo contemporaneo, ma che fanno della chiesa cattolica un’antenna molto sensibile per comprendere il mondo globale.
Questo discorso rappresenta una chiave di lettura importante per comprendere il ruolo di questo pontificato nella chiesa contemporanea. Se per alcuni versi il pontificato di Benedetto XVI va letto in continuità culturale e teologica con quello di Giovanni Paolo II, questo discorso invece ne sottolinea le diversità: in primo luogo per la capacità di spersonalizzare il papato, o meglio, di viverlo in modo personale senza imprigionarlo dentro un atletismo mistico che non si confà a Joseph Ratzinger.
In una chiave tipica della "umiltà istituzionale" che è nella teologia del papato dal concilio Vaticano II in poi, Benedetto XVI ha enfatizzato la dimensione pastorale del ministero: "Ricevo anche moltissime lettere da persone semplici che mi scrivono semplicemente dal loro cuore e mi fanno sentire il loro affetto, che nasce dall’essere insieme con Cristo Gesù, nella Chiesa. Queste persone non mi scrivono come si scrive ad esempio ad un principe o ad un grande che non si conosce. Mi scrivono come fratelli e sorelle o come figli e figlie, con il senso di un legame familiare molto affettuoso. Qui si può toccare con mano che cosa sia Chiesa - non un’organizzazione, non un’associazione per fini religiosi o umanitari, ma un corpo vivo, una comunione di fratelli e sorelle nel Corpo di Gesù Cristo, che ci unisce tutti".
Morire in pubblico, come Giovanni Paolo II, o ammettere in pubblico la difficoltà, anche per papa Benedetto XVI, di rinunciare a qualsiasi "privacy" (termine che oggi forse entra per la prima volta nel vocabolario dei pontefici romani): "il papa appartiene a tutti, non appartiene più a se stesso". Sono due modi diversi, entrambi contro-culturali, di testimoniare il messaggio cristiano al mondo contemporaneo.
Assistiamo in questi giorni a un’eccezionale ridefinizione del ruolo del papa nella chiesa e nel mondo. Su quella straordinaria scena del sacro in Occidente che è la piazza di San Pietro in Roma, il papa si congeda dal pubblico, ma non dalla chiesa.
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA --- BILANCIO DI UN PONTIFICATO. Benedetto XVI: constatazione di fallimento? (di Jacques Noyer, vescovo emerito di Amiens)22 febbraio 2013, di Federico La Sala
Benedetto XVI: constatazione di fallimento?
di Jacques Noyer
in “www.temoignagechretien.fr” del 19 febbraio 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)
- Pur ammirando il gesto di rinuncia di Benedetto XVI, Jacques Noyer, vescovo emerito di Amiens, presenta un primo bilancio in chiaroscuro del pontificato che giunge al termine.
Certo, c’è il corpo che non risponde più, la fatica che paralizza, la vecchiaia che incombe... Mi sembra tuttavia che non sia irrispettoso nei confronti di Benedetto XVI ritenere che nella sua decisione abbia pesato anche la sensazione di fallimento personale da lui probabilmente provata.
Anche chi non gli è intimamente vicino, può immaginare che il suo gesto di rinuncia si spieghi, in parte almeno, con la consapevolezza dell’inefficacia della sua politica personale.
Ad esempio, sappiamo che fin dall’inizio del suo pontificato ha cercato di riconciliare la nebulosa tradizionalista il cui allontanamento gli era particolarmente doloroso. Ha moltiplicato le iniziative. Ha fatto concessioni. Ha offerto privilegi a chi tornava all’ovile. Ancora ultimamente ha rilanciato il dialogo che sembrava finito in un vicolo cieco. Ma senza risultati!
Questa impressione di essere entrato in un mercanteggiamento impossibile dev’essere stata difficile da vivere. Ha ceduto su alcune posizioni, e l’avversario se ne è sentito incoraggiato. Ha già dato molto, e deve dare ancora di più. Alla fine, dovrebbe concedere tutto e rinunciare al concilio. Come uscire da questa impasse?
Si è sentito in dovere di far luce sugli oscuri traffici delle finanze vaticane. Ha dato incarichi a uomini di fiducia per modificare le abitudini e ottenere la trasparenza necessaria. La resistenza degli uomini del segreto è stata così grande che non gli ha permesso di ottenere nulla. Gli intrighi di palazzo sono arrivati fin nei suoi appartamenti privati. Solo e impotente, non poteva evitare che le banche internazionali rifiutassero di lavorare col Vaticano su una base di fiducia e lo trattassero invece come un oscuro rifugio di truffatori. Giovanni Paolo II aveva rinunciato a riformare la curia.
Benedetto XVI, in questo tentativo, si è scontrato contro ostacoli insormontabili. Ha coraggiosamente voluto affrontare la piaga troppo a lungo nascosta della pedofilia. Ha creduto, facendo risalire tutto a Roma, di risolvere il problema all’interno della Chiesa come spetta ad una “società perfetta”. Ahimè, ha constatato ben presto che era proprio quel principio che faceva scandalo. È stato costretto a rinunciarvi e ha dovuto chiedere ai vescovi di consegnare i colpevoli alle autorità locali.
I suoi predecessori avevano perso la Stato Pontificio, avevano dovuto accettare la separazione della Chiesa dagli Stati laici, a lui è toccato rinunciare al mito della Società perfetta, cioè di una Chiesa che sfugge al potere delle nazioni dove è dislocata.
Si può anche immaginare l’umiliazione che avrà provato quando certe incaute battute da intellettuale hanno provocato sommovimenti tragici come le reazioni dei popoli musulmani alle dichiarazioni di Ratisbona: il professore universitario aveva dimenticato di essere papa! Ed eccolo costretto ad andare a pregare alla Moschea blu di Istanbul, sicuramente più lontano di quanto immaginasse.
Deve anche entrare nella dinamica del movimento ecumenico, nello sforzo di buone relazioni con l’ebraismo, nello spirito della preghiera di Assisi. Si sente che è prudente, esitante. Subisce gli avvenimenti, non è lui a dirigerli. Un passo che potrebbe apparire come una vittoria, lo vive come una sconfitta.
È più difficile immaginare ciò che ha provato nella difesa di una dottrina eterna gettata nel vortice della modernità. In una simile lotta, ogni successo è provvisorio e molti i fallimenti. Deve difendere il dogma contro le critiche dello spirito moderno. Deve difendere la morale naturale all’interno di un’evoluzione dei costumi senza precedenti. Deve difendere tradizioni antiche diventate obsolete agli occhi degli uomini d’oggi.
Un combattente come Giovanni Paolo II aveva il gusto della “battaglia” e non si dichiarava mai sconfitto. In simili circostanze, la finezza dell’intelligenza di Benedetto XVI diventa debolezza. Le obiezioni degli avversari colpiscono lui certamente più di altri militanti corazzati di certezze. La fede che lo abita non sopprime il peso della Ragione.
Dei confratelli vescovi mi dicevano quale sofferenza avevano letto sul suo volto quando gli avevano parlato delle difficoltà pastorali in cui certe regole del diritto canonico li costringevano. Con la testa tra le mani, soffriva di non poter dare risposte. Sta a voi, sul campo, diceva loro, trovare un cammino per cui l’osservanza della legge non impedisca l’annuncio del vangelo. I vescovi sono stati colpiti da un papa, debole quanto loro di fronte alle contraddizioni della loro pastorale. Chissà in quali insonnie si sarà prolungato questo bisogno di coerenza!
Questi fallimenti avrebbero potuto causare in anime meno sante lo scoraggiamento totale, una passività rassegnata. Benedetto XVI vi ha invece visto l’occasione di un sussulto di speranza: riconosce il suo fallimento. Sa di essere troppo malandato per ricominciare in un altro modo. Lascia il posto a qualcun altro. Se fosse stato certo delle battaglie condotte, avrebbe preparato un successore. Sente, al contrario, a mio avviso, nel segreto del suo cuore, che un papa nuovo dovrà procedere in modo diverso. Quando fu eletto papa, non gli è stata lasciata scelta: doveva continuare l’opera del suo predecessore e ha faticato a trovare un suo stile. Al contrario, lui, oggi, chiede che si tentino strade differenti.
Possiamo sperare che una figura nuova definisca una nuova strategia. Possiamo aspettarci un papa che abbia qualità e caratteristiche diverse da chi lo ha preceduto. Soprattutto possiamo augurarci un papa che faccia circolare la parola in quel grande corpo che è la Chiesa e che, a questo fine, faccia sì che le decisioni non siano più prese solo a livello centrale. Che dia fiducia al Popolo di Dio, invece di esserne il Guardiano. Che tenti il nuovo là dove l’antico è morto. Questa umiltà è certamente un atto di speranza: un altro farà meglio di me, proclama. Prego che non crolli sotto ciò che lui chiama i suoi difetti. La speranza non lo abbandonerà.
Nessuno pensa oggi di rimproverargli di aver fatto ciò che ha ritenuto giusto fare. Si può solo ammirare che abbia osato aprire la porta alle iniziative di uno sconosciuto che lo Spirito Santo e i cardinali di tutto il mondo stanno già preparandoci.
*Jacques Noyer è vescovo emerito di Amiens, ed ex parroco di Touquet-Paris-Plage. È anche stato professore di filosofia.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") --- SOVRANA CERTEZZA (di Marina Corradi).14 febbraio 2013, di Federico La Sala
- DIO E’ VALORE! Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, sventola il "Logo" del Grande Mercante: "Deus caritas est" (Benedetto XVI, 2006)!!! Il papa teologo, ha gettato via la "pietra" su cui posava l’intera Costruzione ... e anche la maschera.
 IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI OGGI (2006-2012) E CIO’ CHE OGNI BUON CATECHISTA INSEGNAVA IERI (2005). Una lezione di don Mauro Agreste - con alcune note
IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI OGGI (2006-2012) E CIO’ CHE OGNI BUON CATECHISTA INSEGNAVA IERI (2005). Una lezione di don Mauro Agreste - con alcune note
L’insegnamento di Pietro
Sovrana certezza
di Marina Corradi (Avvenire, 14 febbraio 2013)
«Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, che non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura». La prima parola di Benedetto XVI ieri mattina in Udienza, proprio la prima cosa detta alla folla, grande, che lo aspettava, è stata questa: il ricordare che la Chiesa è di Cristo, e che dunque anche nelle circostanze più avverse Cristo non la abbandona.
E noi, semplici fedeli storditi, lunedì, dalla notizia, noi interiormente turbati da un inimmaginabile congedo, abbiamo riconosciuto in quella prima parola la volontà paterna di dire, a quelli come noi, di non aver paura. In questi due giorni abbiamo sentito di tutto, sul gesto di Benedetto XVI, lodi e plausi, e contestazioni, ed evocazioni di oscuri retroscena. Abbiamo letto di desacralizzazione del Papato, di fondamenta che vacillano, e sentito dottamente discorrere della Chiesa come di una grande multinazionale, o una Ong - certo, dal "brand" spiritualmente elevato. E ci occorreva davvero che proprio Benedetto XVI, il maestro che abbiamo amato e continueremo a amare, ci ricordasse, ci confermasse in questa semplice antica certezza: la Chiesa è di Cristo, che non l’abbandona.
La Chiesa è di Cristo, è il suo corpo, e non è mai riducibile solo agli uomini, strutture, gerarchie che la compongono, con i loro peccati, i loro umani sforzi, le loro disunioni e persino il loro cercare un "pubblico". Colpe ed errori che pure, è tornato a ricordarci nell’omelia delle Ceneri il Papa, ne possono «deturpare» il volto. Questo aspetto non visibile, non sperimentabile con le nostre consuete misure, è tanto fondante quanto non compreso nemmeno dai più fini intellettuali, che parlano di Chiesa come di un fatto solo storico, sociologico, umano. E spesso anche fra noi, credenti, questa memoria ontologica facilmente sbiadisce; allora in giorni come questi ci smarriamo: e adesso?
È a questo sommesso tremare dei semplici che il Papa ieri ha teso la mano con una frase per nulla debole, e anzi colma di certezza sovrana: la Chiesa è di Cristo, che non l’abbandona. Poi, nell’Udienza il Papa ha affrontato il Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto, riassumendole in poche parole: "la" tentazione eterna, ha detto, è quella di usare Dio per noi stessi. Ecco, in quelle sole righe dell’evangelista Luca si sente già il respiro di un altro, radicale, desiderio, di uno sguardo altro dalla logica degli uomini, inesorabilmente sedotti del potere.
Di modo che chi si imbarca sul grande millenario naviglio di Pietro, se tiene viva la fede, si trova, ha detto il Papa, a fare scelte scomode o perfino, secondo il mondo, stolte; ad amare i deboli, e la vita dell’uomo fin dal suo più debole invisibile inizio. Ad amare per sempre, e a generare figli, quando il mondo attorno ripete che la vita è cosa da prendere e usare, come e finché si vuole.
Quell’altro sguardo, quell’altro respiro s’è visto bene ancora ieri sera, in San Pietro gremita di uomini e donne stretti attorno a Benedetto nel giorno delle Ceneri - in quel gesto così umile e conscio del nostro essere, solamente, creature. «Risuoni forte in noi l’invito alla conversione, a ritornare a Dio con tutto il cuore, accogliendo la sua grazia che ci fa uomini nuovi», è stato il filo teso nelle parole del Papa.
Di nuovo, parole affatto stanche, anzi straordinariamente audaci in tempi di pensiero debole, di rassegnati orizzonti. Tornare a Dio, è l’imperativo di quest’uomo il cui cuore sembra tutto fuorché piegato, o vecchio. Quaerere Deum, è la parola che ci lascia un grande Papa in un Anno della Fede indetto perché ciò che è vero torni a essere concreto, e vivo fra noi. Perché la Chiesa è di Cristo, e tutto il suo essere tenda a Cristo - Colui che ricapitolerà in sé tutte le cose, quelle della terra e quelle del cielo.
E il grande applauso a Benedetto XVI ieri sera in San Pietro testimonia la fede e la forza del popolo cristiano. Peccatori, certo; gente però che sa da dove viene, e verso Chi va.
Marina Corradi
- DIO E’ VALORE! Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, sventola il "Logo" del Grande Mercante: "Deus caritas est" (Benedetto XVI, 2006)!!! Il papa teologo, ha gettato via la "pietra" su cui posava l’intera Costruzione ... e anche la maschera.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA --- E IL TESTO DELLE SUE DIMISSIONI IN LATINO (di Luciano Canfora - Un esempio di latino moderno).12 febbraio 2013, di Federico La Sala
Un esempio di latino moderno
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 12 febbraio 2013)
Il testo originale del comunicato con cui Benedetto XVI ha annunciato le sue dimissioni è scritto, come è ovvio, in un latino costruito con prestiti ricavati da autori delle più diverse epoche. È una specie di mosaico che abbraccia quasi due millenni di latinità: dal ciceroniano «ingravescente aetate» al disinvolto «ultimis mensibus» che figura in scritti ottocenteschi (addirittura del calvinista Bachofen), fino al «portare pondus» che ricorre in Flavio Vegezio, Epitoma rei militaris, ma più frequentemente in autori quali Raimondo Lullo (Ars amativa boni), Tommaso da Kempis o anche nei sermoni di Bernardo di Chiaravalle.
Spicca come prelievo dal dotto e audace Rufino traduttore di Origene, l’espressione «incapacitatem meam». Per altro verso solide attestazioni di epoca classica, da Quintiliano a Plinio, sorreggono la frase più importante di tutto il testo e cioè: «declaro me ministerio renuntiare» («dichiaro di rinunciare al mio ruolo di Papa»).
Peccato però che, per una svista imputabile a qualche collaboratore turbato dalla gravità dell’annunzio, proprio nella frase cruciale sia stata inferta una ferita alla sintassi latina, visto che al dativo ministerio viene collegato l’intollerabile accusativo commissum («incombenza affidatami»). Avrebbe dovuto esserci, per necessaria concordanza, il dativo commisso.
Come consolarsi di questo lapsus? Pensando per esempio ai rari ma disturbanti errori di latino che macchiavano le Quaestiones callimacheae di un grande filologo come Giorgio Pasquali, rettificate però nella ristampa realizzata poi dal bravissimo Giovanni Pascucci, grammatico fiorentino. Ma non è impertinente comparare un filologo laico con un Pontefice regnante? L’errore - si sa - si insinua sempre. Come il periodo tedesco, così il periodo latino è «ein Bild» (un quadro), in cui ogni tassello ha un suo posto e la ferita inferta alle concordanze risulta tanto più dolorosa.
Analogo incidente è avvenuto addirittura nella frase di apertura, dove il Pontefice dice ai «fratelli carissimi» che li ha convocati «per comunicare una decisione di grande momento per la vita della Chiesa»: ma si legge pro ecclesiae vitae laddove avremmo desiderato pro ecclesiae vita.
Sia stato il turbamento o sia stata la fretta, resta il disagio per le imperfezioni di un testo destinato a passare alla storia. È bensì vero che il latino dei moderni riflette la ricchezza e la novità della lingua dei moderni, ma alcuni pilastri della sintassi non possono, neanche in omaggio al «nuovo che avanza», essere infranti.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA --- Errori e occasioni sprecate (di Marco Politi - Prove del fallimento di un papa)13 febbraio 2013, di Federico La Sala
Prove del fallimento di un papa
Errori e occasioni sprecate: dalla macata condanna dei tedeschi ad Auschwitz alla comunione per i divorziati
di Marco Politi (il Fatto, 13.02.2013)
E se fossero stati otto anni persi? Otto anni in cui tanti problemi già maturi ai tempi di Giovanni Paolo II sono stati semplicemente rimandati senza nemmeno essere avviati a soluzione. Dalla carenza di preti al ruolo delle donne, ad un nuovo approccio alla sessualità, alla rilancio dei rapporti ecumenici.
La cosa più sorprendente, il giorno dopo le dimissioni annunciate di Benedetto XVI, è la calma con cui il popolo cattolico le sta accogliendo. Certo c’è sorpresa e a tratti sconcerto, ma la gran massa ha digerito subito la novità e vuole semmai capire meglio dove papa Ratzinger ha sbagliato. Dove ha fallito. Perché a livello popolare si è capito da tempo che Benedetto XVI è stato “incapace” in termini di leadership e di governo dei problemi planetari della Chiesa cattolica.
D’altronde già l’anno scorso la sua popolarità era caduta al 39 per cento e quella della Chiesa nel 2013 (Eurispes) al 36. Segno di una grave disaffezione dei fedeli e dell’opinione pubblica nei confronti dell’istituzione ecclesiastica e del suo capo.
Ora, tra i difensori a oltranza del papato-idolo (dove tutto ciò che fa il pontefice è perfetto e a sbagliare sono sempre gli altri), si va diffondendo il mito della sua solitudine e di una Curia cattiva, che gli remava contro. Favole. Un papa è sempre solo, diceva Paolo VI. La questione è semmai quali collaboratori si sceglie e l’efficienza con cui realizza la sua strategia.
Le gaffe su gay e preservativi
Benedetto XVI troppe volte si è fermato a metà. Nel 2010 ha condannato con durezza gli abusi sessuali commessi dagli uomini di Chiesa e ha proclamato il dovere dei preti-criminali di recarsi davanti ai tribunali. Poi però non ha emanato un decreto per rendere obbligatorio che i vescovi denuncino i colpevoli. Né ha ordinato che si aprano gli archivi diocesani alla ricerca di denunce insabbiate, che corrispondono a migliaia di vittime inascoltate.
Lo stesso è accaduto con la trasparenza delle finanze vaticane. Nel 2010 il Papa costituisce un’alta autorità finanziaria (AIF), dotata di ampi poteri di ispezione non solo dello Ior ma di ogni movimento di denaro nella Santa Sede. Pochi mesi dopo il suo più stretto collaboratore il Segretario di Stato cardinale Bertone limita drasticamente le competenze dell’autorità finanziaria, incassando poi i rimbrotti della commissione finanziaria europea Moneyval.
Si può forse descrivere Bertone come un nemico accanito del pontefice? In realtà si possono trovare negli scritti di Benedetto XVI molti passi illuminanti sull’essere cristiani nel mondo d’oggi, ma la predicazione anche alta non basta. Serviva il governo concreto, serviva - e non c’è stata - la sensibilità geopolitica e il piglio del governante risolve le questioni aperte e non ne crea.
Troppi i passi falsi. A Regensburg nel 2006 Benedetto XVI non si rende conto che una frase sprezzante di un vecchio imperatore bizantino su Maometto offenderà milioni di musulmani.
Ad Auschwitz non si rende conto che non può attribuire solo ad una “banda di criminali” lo scivolamento della Germania nella barbarie nazista.
Volando in Africa, non si rende conto che affermare che il preservativo peggiora la diffusione dell’Aids è un affronto alla comunità scientifica e al buon senso di tante suore e missionari, che lo distribuiscono per frenare la pandemia.
Ancora poche settimane fa non si rende conto che stringere la mano all’udienza generale alla presidente del Parlamento ugandese, Rebecca Kadaga, che propugna la pena di morte per i gay, è un gesto impensabile mentre monta nelle strade di Roma l’odio anti-gay. Né la semplice lettura delle rassegne stampa gli impedisce di procedere all’annullamento della scomunica del vescovo lefebvriano Williamson, fanatico negatore dell’Olocausto. Glielo hanno tenuto nascosto? Non deve accadere per chi esercita un potere monarchico assoluto. Vuol dire che ha sbagliato nella scelta delle persone cui affida i dossier più delicati.
Le concessioni ai lefebvriani e il disamore dei cattolici
Gli ebrei sono rimasti amareggiati per la riedizione della preghiera del Venerdì Santo nella messa di Pio V, in cui si affaccia nuovamente il tema di una loro cecità rispetto alla venuta di Cristo.
I cattolici si sono disamorati per la sua decisione di reintrodurre a tutti i livelli la messa preconciliare. Ma più ancora la maggioranza dei cattolici è stata ferita dalle sue concessioni ai lefebvriani, permettendo che la retta interpretazione dei testi più importanti del Vaticano II diventassero oggetto di un negoziato con i nemici più fanatici del Concilio.
Quel Concilio che papa Ratzinger ha voluto leggere ossessivamente nell’ottica della “continuità” con la storia della Chiesa, quando i documenti conciliari più fecondi (sulla libertà religiosa, sulla fine dell’antisemitismo, sulla riforma liturgica, sull’ecumenismo, sui rapporti con l’Islam e le religioni orientali) rappresentano una svolta radicale con il passato.
Questioni irrisolte: corruzione e Ior
Iniziando il suo pontificato, Benedetto XVI ha dichiarato di non avere un programma di governo, ma di proporsi solo la sequela della parola di Dio. Non è una nota di merito. Un pontefice, che guida oltre un miliardo di fedeli, deve avere un programma di azione.
L’hanno avuto papi diversissimi come Paolo VI e Pio XII, Wojtyla e Giovanni XXIII. Non averlo ha significato lasciare marcire molte questioni. Il tema della comunione negata ai divorziati risposati papa Ratzinger si proponeva di “studiarlo” nel 2005, appena eletto, e otto anni dopo non aveva ancora una risposta.
Il tema della collegialità, cioè di un governo della Chiesa universale a cui partecipano i vescovi, lo aveva ben chiaro, quando da cardinale poche settimane prima dell’elezione disse che la Chiesa non può più essere governata in modo “monarchico”. Per otto anni ha deciso invece le strategia fondamentali del suo pontificato (verso i lefebvriani, i dissidenti anglicani o sulle questioni ecumeniche) in maniera solitaria e autoritaria.
La sua ripetizione ossessiva dei “principi non negoziabili” ha provocato uno scisma sotterraneo, silenzioso ma profondo, all’interno del Popolo di Dio. L’incapacità di reggere con mano ferma una Curia spaccata e dilaniata da forti conflitti interni, l’incapacità di andare a fondo alle denunce di corruzione di monsignor Viganò o di sostenere il presidente dello Ior Gotti Tedeschi nella richiesta di fare certificare da un’agenzia esterna i bilanci della banca vaticana, sono stati il colpo finale per l’autorità di Benedetto XVI. Il problema non è il maggiordomo infedele, il problema è che nessuno nel Vaticano di Ratzinger ha voluto discutere dei fatti maleolenti emersi dalle carte.
Non è un caso che lunedì una folla non sia precipitata in piazza San Pietro al grido di “non farlo... rimani! ”.
Chi ha il potere assoluto alla fine ne risponde senza mediazioni. Doveva essere un pontificato di transizione. Si è trasformato in una stagnazione. L’abdicazione per molti è arrivata come un sollievo.
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA --- DANTE CORRE FORTISSIMO: IL PARADISO NECESSARIO. Intervista a Fabrice Hadjadj (di Lorenzo Fazzini)8 febbraio 2013, di Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA .."DEUS CARITAS EST"("CHARITAS", SENZA "H") --- L’indissolubile intreccio tra fede e carità. Credere nella carità suscita carità (di Benedetto XVI)4 febbraio 2013, di Federico La Sala
Del "Deus charitas est" (1 Gv., 4.8) o del "Deus caritas est" (Bendedetto XVI, 2006)?!:
 "Di quale Dio parliamo quando parliamo di Dio, e di quale Dio parlano quando parlano di Dio? La domanda è cruciale. Infatti non è per niente chiaro, non è sempre lo stesso, e sovente non è un Dio innocuo" (Raniero La Valle, "Se questo è un Dio", pag. 9)
"Di quale Dio parliamo quando parliamo di Dio, e di quale Dio parlano quando parlano di Dio? La domanda è cruciale. Infatti non è per niente chiaro, non è sempre lo stesso, e sovente non è un Dio innocuo" (Raniero La Valle, "Se questo è un Dio", pag. 9)
MESSAGGIO PER LA QUARESIMA
Credere nella carità suscita carità
di Benedetto XVI (Avvenire, 1 febbraio 2013)
Cari fratelli e sorelle,la celebrazione della Quaresima, nel contesto dell’Anno della fede, ci offre una preziosa occasione per meditare sul rapporto tra fede e carità: tra il credere in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, e l’amore, che è frutto dell’azione dello Spirito Santo e ci guida in un cammino di dedizione verso Dio e verso gli altri.
1. La fede come risposta all’amore di Dio.
Già nella mia prima Enciclica ho offerto qualche elemento per cogliere lo stretto legame tra queste due virtù teologali, la fede e la carità. Partendo dalla fondamentale affermazione dell’apostolo Giovanni: «Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi» (1 Gv 4,16), ricordavo che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva... Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4,10), l’amore adesso non è più solo un ”comandamento”, ma è la risposta al dono dell’amore, col quale Dio ci viene incontro» (Deus caritas est, 1). La fede costituisce quella personale adesione - che include tutte le nostre facoltà - alla rivelazione dell’amore gratuito e «appassionato» che Dio ha per noi e che si manifesta pienamente in Gesù Cristo.
L’incontro con Dio Amore che chiama in causa non solo il cuore, ma anche l’intelletto: «Il riconoscimento del Dio vivente è una via verso l’amore, e il sì della nostra volontà alla sua unisce intelletto, volontà e sentimento nell’atto totalizzante dell’amore. Questo però è un processo che rimane continuamente in cammino: l’amore non è mai “concluso” e completato» (ibid., 17). Da qui deriva per tutti i cristiani e, in particolare, per gli «operatori della carità», la necessità della fede, di quell’«incontro con Dio in Cristo che susciti in loro l’amore e apra il loro animo all’altro, così che per loro l’amore del prossimo non sia più un comandamento imposto per così dire dall’esterno, ma una conseguenza derivante dalla loro fede che diventa operante nell’amore» (ibid., 31a). Il cristiano è una persona conquistata dall’amore di Cristo e perciò, mosso da questo amore - «caritas Christi urget nos» (2 Cor 5,14) -, è aperto in modo profondo e concreto all’amore per il prossimo (cfr ibid., 33). Tale atteggiamento nasce anzitutto dalla coscienza di essere amati, perdonati, addirittura serviti dal Signore, che si china a lavare i piedi degli Apostoli e offre Se stesso sulla croce per attirare l’umanità nell’amore di Dio.
«La fede ci mostra il Dio che ha dato il suo Figlio per noi e suscita così in noi la vittoriosa certezza che è proprio vero: Dio è amore! ... La fede, che prende coscienza dell’amore di Dio rivelatosi nel cuore trafitto di Gesù sulla croce, suscita a sua volta l’amore. Esso è la luce - in fondo l’unica - che rischiara sempre di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire» (ibid., 39). Tutto ciò ci fa capire come il principale atteggiamento distintivo dei cristiani sia proprio «l’amore fondato sulla fede e da essa plasmato» (ibid., 7).
2. La carità come vita nella fede
Tutta la vita cristiana è un rispondere all’amore di Dio. La prima risposta è appunto la fede come accoglienza piena di stupore e gratitudine di un’inaudita iniziativa divina che ci precede e ci sollecita. E il «sì» della fede segna l’inizio di una luminosa storia di amicizia con il Signore, che riempie e dà senso pieno a tutta la nostra esistenza. Dio però non si accontenta che noi accogliamo il suo amore gratuito. Egli non si limita ad amarci, ma vuole attiraci a Sé, trasformarci in modo così profondo da portarci a dire con san Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me (cfr Gal 2,20). Quando noi lasciamo spazio all’amore di Dio, siamo resi simili a Lui, partecipi della sua stessa carità. Aprirci al suo amore significa lasciare che Egli viva in noi e ci porti ad amare con Lui, in Lui e come Lui; solo allora la nostra fede diventa veramente «operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6) ed Egli prende dimora in noi (cfr 1 Gv 4,12).
La fede è conoscere la verità e aderirvi (cfr 1 Tm 2,4); la carità è «camminare» nella verità (cfr Ef 4,15). Con la fede si entra nell’amicizia con il Signore; con la carità si vive e si coltiva questa amicizia (cfr Gv 15,14s). La fede ci fa accogliere il comandamento del Signore e Maestro; la carità ci dona la beatitudine di metterlo in pratica (cfr Gv 13,13-17). Nella fede siamo generati come figli di Dio (cfr Gv 1,12s); la carità ci fa perseverare concretamente nella figliolanza divina portando il frutto dello Spirito Santo (cfr Gal 5,22). La fede ci fa riconoscere i doni che il Dio buono e generoso ci affida; la carità li fa fruttificare (cfr Mt 25,14-30).
3. L’indissolubile intreccio tra fede e carità
Alla luce di quanto detto, risulta chiaro che non possiamo mai separare o, addirittura, opporre fede e carità. Queste due virtù teologali sono intimamente unite ed è fuorviante vedere tra di esse un contrasto o una «dialettica». Da un lato, infatti, è limitante l’atteggiamento di chi mette in modo così forte l’accento sulla priorità e la decisività della fede da sottovalutare e quasi disprezzare le concrete opere della carità e ridurre questa a generico umanitarismo. Dall’altro, però, è altrettanto limitante sostenere un’esagerata supremazia della carità e della sua operosità, pensando che le opere sostituiscano la fede. Per una sana vita spirituale è necessario rifuggire sia dal fideismo che dall’attivismo moralista.
L’esistenza cristiana consiste in un continuo salire il monte dell’incontro con Dio per poi ridiscendere, portando l’amore e la forza che ne derivano, in modo da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio. Nella Sacra Scrittura vediamo come lo zelo degli Apostoli per l’annuncio del Vangelo che suscita la fede è strettamente legato alla premura caritatevole riguardo al servizio verso i poveri (cfr At 6,1-4). Nella Chiesa, contemplazione e azione, simboleggiate in certo qual modo dalle figure evangeliche delle sorelle Maria e Marta, devono coesistere e integrarsi (cfr Lc 10,38-42). La priorità spetta sempre al rapporto con Dio e la vera condivisione evangelica deve radicarsi nella fede (cfr Catechesi all’Udienza generale del 25 aprile 2012). Talvolta si tende, infatti, a circoscrivere il termine «carità» alla solidarietà o al semplice aiuto umanitario.
E’ importante, invece, ricordare che massima opera di carità è proprio l’evangelizzazione, ossia il «servizio della Parola». Non v’è azione più benefica, e quindi caritatevole, verso il prossimo che spezzare il pane della Parola di Dio, renderlo partecipe della Buona Notizia del Vangelo, introdurlo nel rapporto con Dio: l’evangelizzazione è la più alta e integrale promozione della persona umana. Come scrive il Servo di Dio Papa Paolo VI nell’Enciclica Populorum progressio, è l’annuncio di Cristo il primo e principale fattore di sviluppo (cfr n. 16). E’ la verità originaria dell’amore di Dio per noi, vissuta e annunciata, che apre la nostra esistenza ad accogliere questo amore e rende possibile lo sviluppo integrale dell’umanità e di ogni uomo (cfr Enc. Caritas in veritate, 8).
In sostanza, tutto parte dall’Amore e tende all’Amore. L’amore gratuito di Dio ci è reso noto mediante l’annuncio del Vangelo. Se lo accogliamo con fede, riceviamo quel primo ed indispensabile contatto col divino capace di farci «innamorare dell’Amore», per poi dimorare e crescere in questo Amore e comunicarlo con gioia agli altri. A proposito del rapporto tra fede e opere di carità, un’espressione della Lettera di san Paolo agli Efesini riassume forse nel modo migliore la loro correlazione: «Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo» (2, 8-10).
Si percepisce qui che tutta l’iniziativa salvifica viene da Dio, dalla sua Grazia, dal suo perdono accolto nella fede; ma questa iniziativa, lungi dal limitare la nostra libertà e la nostra responsabilità, piuttosto le rende autentiche e le orienta verso le opere della carità. Queste non sono frutto principalmente dello sforzo umano, da cui trarre vanto, ma nascono dalla stessa fede, sgorgano dalla Grazia che Dio offre in abbondanza. Una fede senza opere è come un albero senza frutti: queste due virtù si implicano reciprocamente.
La Quaresima ci invita proprio, con le tradizionali indicazioni per la vita cristiana, ad alimentare la fede attraverso un ascolto più attento e prolungato della Parola di Dio e la partecipazione ai Sacramenti, e, nello stesso tempo, a crescere nella carità, nell’amore verso Dio e verso il prossimo, anche attraverso le indicazioni concrete del digiuno, della penitenza e dell’elemosina.
4. Priorità della fede, primato della carità
Come ogni dono di Dio, fede e carità riconducono all’azione dell’unico e medesimo Spirito Santo (cfr 1 Cor 13), quello Spirito che in noi grida «Abbà! Padre» (Gal 4,6), e che ci fa dire: «Gesù è il Signore!» (1 Cor 12,3) e «Maranatha!» (1 Cor 16,22; Ap 22,20).
La fede, dono e risposta, ci fa conoscere la verità di Cristo come Amore incarnato e crocifisso, piena e perfetta adesione alla volontà del Padre e infinita misericordia divina verso il prossimo; la fede radica nel cuore e nella mente la ferma convinzione che proprio questo Amore è l’unica realtà vittoriosa sul male e sulla morte. La fede ci invita a guardare al futuro con la virtù della speranza, nell’attesa fiduciosa che la vittoria dell’amore di Cristo giunga alla sua pienezza. Da parte sua, la carità ci fa entrare nell’amore di Dio manifestato in Cristo, ci fa aderire in modo personale ed esistenziale al donarsi totale e senza riserve di Gesù al Padre e ai fratelli. Infondendo in noi la carità, lo Spirito Santo ci rende partecipi della dedizione propria di Gesù: filiale verso Dio e fraterna verso ogni uomo (cfr Rm 5,5).
Il rapporto che esiste tra queste due virtù è analogo a quello tra due Sacramenti fondamentali della Chiesa: il Battesimo e l’Eucaristia. Il Battesimo (sacramentum fidei) precede l’Eucaristia (sacramentum caritatis), ma è orientato ad essa, che costituisce la pienezza del cammino cristiano. In modo analogo, la fede precede la carità, ma si rivela genuina solo se è coronata da essa. Tutto parte dall’umile accoglienza della fede («il sapersi amati da Dio»), ma deve giungere alla verità della carità («il saper amare Dio e il prossimo»), che rimane per sempre, come compimento di tutte le virtù (cfr 1 Cor 13,13).
Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima, in cui ci prepariamo a celebrare l’evento della Croce e della Risurrezione, nel quale l’Amore di Dio ha redento il mondo e illuminato la storia, auguro a tutti voi di vivere questo tempo prezioso ravvivando la fede in Gesù Cristo, per entrare nel suo stesso circuito di amore verso il Padre e verso ogni fratello e sorella che incontriamo nella nostra vita. Per questo elevo la mia preghiera a Dio, mentre invoco su ciascuno e su ogni comunità la Benedizione del Signore!
-
> SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.31 gennaio 2013, di Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE --- GIORNATA MONDIALE DELLA COMUNICAZIONE: I "SOCIAL NETWORK", LA NUOVA AGORA’, E LA VECCHIA ASTUZIA DELLA RAGIONE E DELLA FEDE CATTOLICA.25 gennaio 2013, di Federico La Sala
 WEB, CHIESA, E VILLAGGIO GLOBALE. COME NEL CIELO DELLA RETE DIGITALE COSI’ NELLA TERRA DELLA RETE DELLE RELAZIONI UMANE: QUALE "VANGELO"?! QUELLO DELLA "CHARITAS" EVANGELICA O QUELLO DELLA "CARITAS" RATZINGERIANA"?!
WEB, CHIESA, E VILLAGGIO GLOBALE. COME NEL CIELO DELLA RETE DIGITALE COSI’ NELLA TERRA DELLA RETE DELLE RELAZIONI UMANE: QUALE "VANGELO"?! QUELLO DELLA "CHARITAS" EVANGELICA O QUELLO DELLA "CARITAS" RATZINGERIANA"?!
 LA REALTA’ DIGITALE, LA CHIESA, E LA GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI. Il messaggio di Benedetto XVI e il commento di Chiara Giaccardi - con note
LA REALTA’ DIGITALE, LA CHIESA, E LA GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI. Il messaggio di Benedetto XVI e il commento di Chiara Giaccardi - con note
-
> LA SCONVOLGENTE LIBERAZIONE. "Dio sempre dalla parte dell’uomo"(di Ermes Ronchi).24 gennaio 2013, di Federico La SalaIL CATTOLICESIMO COME TRADIMENTO STRUTTURALE DEL MESSAGGIO EVANGELICO, DEL CRISTIANESIMO. UN’OBBEDIENZA CIECA DI LUNGA DURATA: TUTTI AGGIOGATI AL DIO-VALORE, AL DIO-MAMMONA ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)!
 LA SCONVOLGENTE LIBERAZIONE. "Dio sempre dalla parte dell’uomo". Una nota di Ermes Ronchi - con appunti
LA SCONVOLGENTE LIBERAZIONE. "Dio sempre dalla parte dell’uomo". Una nota di Ermes Ronchi - con appunti
-
> DE CARITATE MINISTRANDA: SI SCRIVE CARITÀ, SI LEGGE ACCENTRAMENTO: IL MOTU PROPRIO DEL PAPA CHIUDE IL CERCHIO.10 dicembre 2012, di Federico La Sala
SI SCRIVE CARITÀ, SI LEGGE ACCENTRAMENTO: IL MOTU PROPRIO DEL PAPA CHIUDE IL CERCHIO *
36960. CITTÀ DEL VATICANO-ADISTA. Attenzione da dove vengono e attenzione a dove vanno, i soldi, perché tutto si può dire ma non che pecunia non olet, né che ogni spesa, per quanto presuntamente a fin di bene, sia una spesa ben fatta. Saranno considerazioni banali, ma non è mai male ripeterle e soprattutto non è mai vano disporre di strumenti giuridici per vigilare che non siano commessi abusi. Ovvio che valga anche per le opere di carità, tanto che Benedetto XVI ha sentito il bisogno di mettere intorno ad esse dei paletti alquanto elettrificati e guardiani armati di responsabilità con il motu proprio De caritate ministranda, datato 21 novembre e reso pubblico qualche giorno dopo, il 2 dicembre.
Siccome al servizio della carità la Chiesa è chiamata anche a livello comunitario, dalle piccole comunità locali alle Chiese particolari, fino alla Chiesa universale; e poiché, rileva il papa citando la sua enciclica Deus caritas est, «il Codice di Diritto Canonico, nei canoni riguardanti il ministero episcopale, non tratta espressamente della carità come di uno specifico ambito dell’attività episcopale», è giunto il momento di «colmare» un «lacuna normativa in modo da esprimere adeguatamente, nell’ordinamento canonico, l’essenzialità del servizio della Carità nella Chiesa ed il suo rapporto costitutivo con il ministero episcopale, tratteggiando i profili giuridici che tale servizio comporta nella Chiesa, soprattutto se esercitato in maniera organizzata e col sostegno esplicito dei pastori».
Perciò i 15 articoli del motu proprio stabiliscono che tutte le organizzazioni caritative sono innanzitutto «tenute a seguire nella propria attività i principi cattolici e non possono accettare impegni che in qualche misura possano condizionare l’osservanza dei suddetti principi»; «i principi ispiratori e le finalità dell’iniziativa, le modalità di gestione dei fondi, il profilo dei propri operatori, nonché i rapporti e le informazioni da presentare all’autorità ecclesiastica competente» dovranno essere espressi già nei loro statuti; si può ricorrere alla «denominazione di “cattolico” solo con il consenso scritto dell’autorità competente», ovvero del «vescovo diocesano del luogo dove l’ente abbia la sua sede principale». Il quale deve «vigilare affinché nell’attività e nella gestione di questi organismi siano sempre osservate le norme del diritto universale e particolare della Chiesa», curare che «le loro attività mantengano vivo lo spirito evangelico» e che gli operatori scelti dalle entità caritative siano «persone che condividano, o almeno rispettino, l’identità cattolica di queste opere».
Il vescovo, ma anche il parroco per competenza su un’attività parrocchiale, «dovranno impedire che attraverso le strutture parrocchiali o diocesane vengano pubblicizzate iniziative che, pur presentandosi con finalità di carità, propongano scelte o metodi contrari all’insegnamento della Chiesa». Ed inoltre - aggiunge il motu proprio - il vescovo diocesano «deve evitare» che gli organismi di carità siano «finanziati» o «accettino contributi» da «enti o istituzioni che perseguono fini in contrasto con la dottrina della Chiesa». In tal caso interverrà «proibendo l’uso del nome “cattolico” ed adottando i provvedimenti pertinenti ove si profilassero responsabilità personali».
Quando le attività caritative fossero poi «di ambito internazionale, sia consultato preventivamente il competente dicastero della Santa Sede», ovvero il Pontificio Consiglio Cor Unum, che «ha il compito di promuovere l’applicazione di questa normativa e di vigilare affinché sia applicata a tutti i livelli».
Blindata sotto Cor Unum è già finita la Caritas Internationalis, quando nel maggio scorso sono stati approvati i suoi nuovi statuti (v. Adista Notizie n. 19/12), secondo i quali «qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale, emanato da Caritas Internationalis, deve sempre essere sottoposto alla preventiva approvazione del Pontificio Consiglio» e la nomina delle cariche deve avere «l’approvazione preventiva» del papa. Spuntata l’arma dell’autonomia voluta dal Concilio Vaticano II alla benemerita e più autorevole organizzazione caritativa, non rimaneva che provvedere al controllo stretto delle sue emanazioni nazionali e diocesane, troppo vicine ai poveri e perciò a rischio di attività sensibili alla lotta alle strutture socio-economiche ingiuste.
In particolare negli Stati Uniti, De caritate ministranda avrà anche una conseguenza diretta su tutti gli altri organismi caritativi che, avvalendosi del lavoro di propri dipendenti, si trovano nel dovere di rispettare la riforma sanitaria di Obama, in base alla quale i “datori di lavoro”, ovviamente al di là di qualsiasi credo cui appartengano, devono pagare ai dipendenti anche l’assistenza per l’aborto. Quelli che non si opporranno a tale dettato legislativo, decisamente contrario alla dottrina cattolica, verranno depennati - con la conseguenza di vedersi chiusi anche i rubinetti degli aiuti economici ecclesiali - dall’elenco di enti cattolici? (eletta cucuzza)
* Adista Notizie n. 45 del 15/12/2012
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE ---- TWEET, TWEET, TWEET. Con l’hashtag Pontifex l’omelia diventa un tweet (di Alessandro Oppes)4 dicembre 2012, di Federico La Sala
Con l’hashtag Pontifex l’omelia diventa un tweet
di Alessandro Oppes (il Fatto, 4.12.2012)
Un nuovo user irrompe su Twitter. Si presenta buon ultimo ma, come gli garantisce la massima evangelica, sa di avere tutte le carte in regola per arrivare primo. Chi più di Joseph Ratzinger, con un bacino potenziale di centinaia di milioni di fedeli-inter-nauti, può infatti scalzare dalla vetta Barack Obama, attuale leader della rete di microblogging con 24 milioni di followers? A 85 anni, il Papa si getta nella mischia del social network di moda e, nel giorno d’esordio, ha incassato più di 200 mila followers.. E poco importa che, in Rete, ci sia già qualcuno pronto ad avvisarlo: “Non sai in che pasticcio ti stai mettendo”.
È evidente che, al solo annuncio della notizia, diffusa con solennità dalla Sala Stampa vaticana, non potevano che cominciare a circolare scherzi e battute. Volgarità, in certi casi, ma spesso una banale revisione del linguaggio ecclesiastico. Frasi tipo “ama il follower tuo come te stesso”.
Oppure un Giovanni XXIII aggiornato: “Quando tornate a casa, leggete un tweet ai vostri bambini, e ditegli che è il tweet del Papa”. Inevitabili anche le incursioni calcistiche: “Ben detto, pontifex. Dare il Pallone d’Oro a Messi è peccato”. Inconvenienti che, evidentemente, sono stati messi in conto dai collaboratori di Banedetto XVI.
Niente di cui preoccuparsi, se si pensa ai potenziali benefici di un’operazione di “marketing” della fede di cui il Papa era da tempo il più convinto sostenitore. “L’essenzialità dei messaggi brevi, spesso non più lunghi di un versetto della Bibbia - aveva detto Ratzinger all’ultima giornata mondiale delle comunicazioni sociali - permette anche di formulare pensieri profondi”. E allora, ecco che parte la scommessa.
EVANGELIZZARE in 140 caratteri. Cinguettare le Sacre Scritture. Un account dal nome @pontifex (tutte le possibili alternative sono state scartate, perché già occupate) e, in una fase iniziale, tradotto in otto lingue: inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco, polacco, arabo e portoghese. Il profilo è già on line, ma il primo tweet arriverà solo il 12 dicembre.
Per rivolgere domande al Papa su “questioni relative alla vita di fede”, si dovrà utilizzare l’hashtag #askpontifex. A rispondere, sarà uno staff di suoi collaboratori anche se, assicurano in Vaticano, sempre sotto la supervisione di Benedetto XVI. Ovviamente, chiunque può diventare follower del Papa. Ma non aspettatevi che lui vi chieda di diventare vostro seguace. Sarebbe solo una pia illusione.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE ---- TWITTER COME MEGAFONO DI "MEGALOMANIA". Aspettando @pontifex. Chiesa e nuovi media (di Teresa Numerico).4 dicembre 2012, di Federico La Sala
Aspettando @pontifex. Chiesa e nuovi media
di Teresa Numerico (l’Unità, 4 dicembre 2012)
Anche Benedetto XVI cede al fascino dei social network. dal 12 dicembre prossimo, il giorno della festa della Madonna di Guadalupe, sarà possibile leggere i tweet approvati dal papa. Il debutto del profilo in sette lingue è avvenuto ieri. @pontifex ha ottenuto in poche ore migliaia di follower. Solo la versione inglese aveva alle cinque del pomeriggio più di centoventimila seguaci. Tuttavia sappiamo che il Papa non si occuperà di persona di scrivere i suoi cinguettii, perché non è particolarmente abituato alle nuove tecnologie, scrive i suoi testi a mano e non usa direttamente gli strumenti elettronici.
La scelta di usare Twitter si pone comunque come un chiaro segnale di apertura nei confronti delle possibilità offerte dai media sociali per il magistero della Chiesa con lo scopo di ottenere l’attenzione di fedeli e interlocutori.
Nel presentare l’iniziativa i rappresentanti vaticani hanno dichiarato che la presenza del Papa su Twitter è una concreta espressione della convinzione che la Chiesa debba essere presente nell’arena digitale. Il profilo papale su Twitter è solo la punta dell’iceberg della riflessione sull’importanza che il vertice della Chiesa cattolica annette alla cultura dei nuovi media.
Sarà possibile anche porre direttamente domande al Pontefice, utilizzando l’hashtag #askpontifex. Il profilo potrà fornire le risposte alle domande che riterrà più opportuno accogliere, sebbene resti chiaro che non saranno prese di posizione ex cathedra. Greg Burke, il consulente per i media del Pontefice, ha spiegato che non si tratta di mandare Benedetto XVI in giro con l’iPad o il Blackberry, né di mettergli le parole in bocca. Il Papa dirà solo quello che vorrà. Probabilmente, però, il primo tweet lo scriverà di persona.
La Chiesa del resto si è sempre sforzata di essere all’avanguardia nell’uso dei mezzi di comunicazione nei secoli, e questa è una delle caratteristiche che ne ha garantito la longevità. Dagli amanuensi che copiavano i manoscritti da conservare, alla svolta della controriforma con il suo braccio comunicatore affidato ai gesuiti, passando per il primo messaggio radiofonico di Pio XI nel 1931, e ancora l’esperienza di comunicazione del Concilio Vaticano secondo, la Chiesa non ha mai abbandonato l’impegno a sperimentare i mezzi di comunicazione più adatti al proprio messaggio. Del resto, uno dei maggiori contributi alla teoria sui media si deve a un pensatore canadese convertito al cattolicesimo come Marshall McLuhan.
Per tornare al presente, molte altre personalità pubbliche, religiose e non, utilizzano i social media per comunicare con i propri interlocutori. Ha da poco fatto il giro del mondo la foto postata da Obama mentre abbraccia calorosamente Michelle dopo la rielezione, nel caso ci fosse ancora bisogno di riconoscere la potenza mediatica di Twitter, che si conferma il social network più amato dalle celebrità. Ma come mai? Forse perché si tratta di uno strumento che consente di comunicare in modo asincrono e di gestire soprattutto la relazione uno a molti in modo piuttosto efficace. In questo senso non stupisce che il profilo del Pontefice abbia scelto di seguire solo se stesso nelle sue sette varianti linguistiche e di non avere interlocutori, ma solo ascoltatori.
È una scelta precisa: adoperare i social network come un medium di massa e non come uno strumento di interazione. La Santa Sede vuole usare Twitter come un megafono per diffondere la fede e divulgare il proprio messaggio, ma non (o almeno non direttamente) come uno strumento di ascolto di quello che altre personalità religiose e politiche, o anche persone comuni hanno da dire. È una precisa posizione su come essere presenti sui media sociali, non proprio all’avanguardia, pur essendo efficace.
Resta però difficile sottrarsi fino in fondo al carattere interattivo e il profilo @pontifex ci consente di valutare a colpo d’occhio quanti sono i follower nelle varie lingue offrendo un sondaggio naturale sulla reale presenza della religione cattolica nelle diverse comunità linguistiche. Inoltre la scelta delle prime sette lingue, la maggior parte delle quali concentrate in Europa e in America, con l’eccezione dell’arabo, e l’assenza del cinese ci permettono di riconoscere qual è la comunità linguistica alla quale il Vaticano ritiene di doversi rivolgere per sostenere e diffondere il proprio messaggio.
-
-
> IL SOGNO DI BENEDETTO XVI: SPEGNERE IL "LUMEN GENTIUM" E INSTAURARE IL POTERE DEL "DOMINUS IESUS"21 novembre 2012, di Federico La Sala
IL SOGNO DI UNA "COSA" DI BENEDETTO XVI: UNA CHIESA "PER MOLTI", NON "PER TUTTI".
-
>FILOLOGIA E TEOLOGIA: LA LEZIONE DI GIOVENALE (IV SATIRA). IL PESCE VIVO ("ICHTHUS"), IL PESCE MORTO ("ICTUS"), E IL MESSAGGIO EVANGELICO.15 novembre 2012, di Federico La Sala
 FILOLOGIA E TEOLOGIA: IL PESCE VIVO ("ICHTHUS"), IL PESCE MORTO ("ICTUS"), E IL MESSAGGIO EVANGELICO.
FILOLOGIA E TEOLOGIA: IL PESCE VIVO ("ICHTHUS"), IL PESCE MORTO ("ICTUS"), E IL MESSAGGIO EVANGELICO.
 UN MESSAGGIO CIFRATO PER BENEDETTO XVI. AL PONTEFICE MASSIMO E ALLA SUA EMPIA PRETESA DI AVERE UN POTERE PARI A DIO, IL GIORNALE DEI VESCOVI RICORDA LA LEZIONE DI GIOVENALE. Due articoli di Ilaria Ramelli sulla IV Satira.
UN MESSAGGIO CIFRATO PER BENEDETTO XVI. AL PONTEFICE MASSIMO E ALLA SUA EMPIA PRETESA DI AVERE UN POTERE PARI A DIO, IL GIORNALE DEI VESCOVI RICORDA LA LEZIONE DI GIOVENALE. Due articoli di Ilaria Ramelli sulla IV Satira.
-
> MACHIAVELLISMO VATICANO: PAROLA TRUCCATA, MENTE ASTUTA E "COMANDAMENTO NUOVO".5 novembre 2012, di Federico La Sala
-
> MACHIAVELLISMO VATICANO --- MACHIAVELLI CONTRO OGNI TIRANNIA E CONTRO OGNI POPULISMO - ANCHE IN VATICANO (1513-2013)!5 novembre 2012, di Federico La Sala
-
-
> L’IMPERATORE-PAPA COSTANTINO E’ ... NUDO!!! La lezione di democrazia e di eu-angélo di Hans CHRISTIAN Andersen, da rileggere e da rimeditare!!!22 ottobre 2012, di Federico La Sala
 IL BAMBINO GESU’ AL SUO PAPA’ GIUSEPPE: L’IMPERATORE-PAPA COSTANTINO E’ ... NUDO!!! La lezione di democrazia e di eu-angélo di Hans CHRISTIAN Andersen, da rileggere e da rimeditare!!!
IL BAMBINO GESU’ AL SUO PAPA’ GIUSEPPE: L’IMPERATORE-PAPA COSTANTINO E’ ... NUDO!!! La lezione di democrazia e di eu-angélo di Hans CHRISTIAN Andersen, da rileggere e da rimeditare!!!
 LA "SACRA FAMIGLIA" DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA E’ ZOPPA E CIECA: IL FIGLIO HA PRESO IL POSTO DEL PADRE "GIUSEPPE" E DELLO STESSO "PADRE NOSTRO" ... E CONTINUA A "GIRARE" IL SUO FILM PRE-ISTORICO PREFERITO, "IL PADRINO"!!!
LA "SACRA FAMIGLIA" DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA E’ ZOPPA E CIECA: IL FIGLIO HA PRESO IL POSTO DEL PADRE "GIUSEPPE" E DELLO STESSO "PADRE NOSTRO" ... E CONTINUA A "GIRARE" IL SUO FILM PRE-ISTORICO PREFERITO, "IL PADRINO"!!!
-
> MEMORIA DI DOM HELDER CAMARA. SEGUIRE IL FILO DEL "PATTO DELLE CATACOMBE", PER NON PERDERSI.20 ottobre 2012, di Federico La Sala
-
> L’ARCA-PRESEPE DEL MESSAGGIO EVANGELICO E LA “MANGIATOIA” DELLA “FATTORIA DEGLI ANIMALI”. Una nota su "L’infanzia di Gesù" (di Federico La Sala10 ottobre 2012, di Federico La Sala
L’ARCA-PRESEPE DEL MESSAGGIO EVANGELICO E LA “MANGIATOIA” DELLA “FATTORIA DEGLI ANIMALI”.
Una nota su “L’infanzia di Gesù” di J. Ratzinger - Benedetto XVI
di Federico La Sala
- "Di quale Dio parliamo quando parliamo di Dio, e di quale Dio parlano quando parlano di Dio? La domanda è cruciale. Infatti non è per niente chiaro, non è sempre lo stesso, e sovente non è un Dio innocuo" (Raniero La Valle, "Se questo è un Dio", pag. 9)
E si continuano a dormire “sonni beati”! Dopo la dichiarazione “Dominus Iesus” circa l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa (2000), dopo l’enciclica “Deus caritas est” (2006), che proclama la grande “novità” che “Dio è valore”, e la connessa decisione di sottoporre a “copyright tutti gli scritti, i discorsi e le allocuzioni del Papa”, Benedetto XVI, dopo aver tolto la "h" dalla "Charitas" (Amore pieno di grazia) e precisato anche che "Nazaret" si scrive "senza acca" e, infine, che «il calice fu versato per molti», non «per tutti», ha reso pubblico un altro racconto ediphicante sulla vita del suo “Padrone Gesù” (“Dominus Iesus”)!
“Per Natale completata la trilogia”, annuncia trionfante l’Osservatore romano e fornisce un’anteprima “del terzo libro di Benedetto XVI su Gesù presentato alla Fiera internazionale del libro di Francoforte”: “L’infanzia di Gesù”. “Da pagina 38 del manoscritto”, con il titolo “Quel bimbo stretto in fasce”, questo il testo che il giornale del Vaticano riprende:
“Maria avvolse il bimbo in fasce. Senza alcun sentimentalismo, possiamo immaginare con quale amore Maria sarà andata incontro alla sua ora, avrà preparato la nascita del suo Figlio. La tradizione delle icone, in base alla teologia dei Padri, ha interpretato mangiatoia e fasce anche teologicamente. Il bimbo strettamente avvolto nelle fasce appare come un rimando anticipato all’ora della sua morte: Egli è fin dall’inizio l’Immolato, come vedremo ancora più dettagliatamente riflettendo sulla parola circa il primogenito. Così la mangiatoia veniva raffigurata come una sorta di altare. Agostino ha interpretato il significato della mangiatoia con un pensiero che, in un primo momento, appare quasi sconveniente, ma, esaminato più attentamente, contiene invece una profonda verità. La mangiatoia è il luogo in cui gli animali trovano il loro nutrimento. Ora, però, giace nella mangiatoia Colui che ha indicato se stesso come il vero pane disceso dal cielo - come il vero nutrimento di cui l’uomo ha bisogno per il suo essere persona umana. È il nutrimento che dona all’uomo la vita vera, quella eterna. In questo modo, la mangiatoia diventa un rimando alla mensa di Dio a cui l’uomo è invitato, per ricevere il pane di Dio. Nella povertà della nascita di Gesù si delinea la grande realtà, in cui si attua in modo misterioso la redenzione degli uomini”.
Che a cinquanta anni dall’inizio del Concilio ecumenico Vaticano II non si sappia più né Chi è, né come ne dove sia nato Colui che è stato ed è la Luce delle Genti (“Lumen Gentium”), è più che normale e ‘sacrosanto’ che arrivi un papa teologo e racconti la solita storiella tradizionale del “Signore Gesù” nato ancora e sempre in una “mangiatoia”, “una sorta di altare” per l’Immolato, per il sacrificio del primogenito e che, “prima di ascendere al cielo, affidò ai suoi discepoli il mandato di annunciare il Vangelo al mondo intero e di battezzare tutte le nazioni”(“Dominus Iesus” - Introduzione) e abbia il suo grande successo alla fiera e al mercato di tutto il mondo! E’ un segno dei tempi: la “buona-carestia” avanza e grandi sono gli affari che si possono fare, vendendo a “caro-prezzo” (“caritas”) la grazia (”charis”) di Dio: “l’amministrazione della charity” rende molto, sia in affari sia in termini di domesticamento di liberi esseri umani in “animali”!
Per il papa teologo, infatti, il tempo passa invano: siamo ancora e sempre nella orwelliana “fattoria degli animali” e suo è il comando. Egli è il “grande fratello” e il “Santo padre”, il “Padre nostro”, che guida il suo popolo nel cammino della Storia! Ora, finalmente, la carità è nella verità (“Caritas in veritate”, 2009): “La Luce del mondo”, il libro di Ratzinger - Benedetto XVI (2010) ha scalato le vette delel classifiche: ha avuto uno straordinario successo di vendite e di guadagno con i diritti di autore. Questa è la ‘bella notizia’ della "mangiatoia", tutto il resto appartiene al passato: l’arca di Noè, l’arca dell’alleanza di Mosè (con i due cherubini e la Legge scritta), l’arca-presepe del messaggio evangelico e di Francesco di Assisi (con i due cherubini - Giuseppe e Maria - e la Legge vivente, Gesù). “In principio era il Logos” è’ solo “archeologia”! Oggi, su Piazza San Pietro, sventola il “Logo” del “Dominus Iesus”: “Deus caritas est”!!! Il Terzo Millennio prima di Cristo è già iniziato e il sogno di Ratzinger - Benedetto XVI come quello di Costantino annuncia la sua vittoria: “Forza Signore Gesù”!!!
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") --- E QUEL BIMBO STRETTO IN FASCE... La mangiatoia è il luogo in cui gli animali trovano il loro nutrimento (J. Ratzinger - Benedetto XVI, L’infanzia di Gesù)..9 ottobre 2012, di Federico La Sala
Anteprima del terzo libro di Benedetto XVI su Gesù presentato alla Fiera internazionale del libro di Francoforte *
Per Natale completata la trilogia
Sarà la Fiera internazionale del libro a Francoforte, dal 10 al 14 ottobre, la vetrina attraverso la quale l’editore Rizzoli presenterà per la prima volta il nuovo libro di Joseph Ratzinger - Benedetto XVI dedicato ai racconti evangelici dell’infanzia di Gesù.
In Italia il libro L’infanzia di Gesù uscirà prima di Natale in coedizione con la Libreria Editrice Vaticana, ma in apertura della Buchmesse sono già in corso di definizione trattative con editori di trentadue Paesi per le traduzioni, dall’originale tedesco, in venti lingue tra le quali il francese, l’inglese, lo spagnolo, il polacco e il portoghese.
Come spiegato dallo stesso Benedetto XVI nella premessa al libro (che anticipiamo integralmente qui accanto) anche questa terza parte della trilogia dedicata dal Papa a Gesù di Nazaret parte dal racconto evangelico per giungere all’uomo contemporaneo. Come scrisse anche nella introduzione al secondo volume (Dall’ingresso a gerusalemme fino alla risurrezione) l’autore ha cercato di "sviluppare uno sguardo sul Gesù dei Vangeli e un ascolto di Lui che potesse diventare un incontro e tuttavia, nell’ascolto in comunione con i discepoli di Gesù di tutti i tempi, giungere anche alla certezza della figura veramente storica di Gesù". E specificava il suo intento: "spero che mi sia stato dato di avvicnarmi alla figura del nostro Signore in un modo che possa essere utile a tutti i lettori che vogliono incontrare Gesù e credergli". Proprio per questo Benedetto XVI si riprometteva, per completezza, di affrontare anche il capitolo dedicato all’infanzia di Gesù. Oggi mantiene la sua promessa.
Come una piccola sala d’ingresso
Nella premessa il Papa spiega come sia entrato in dialogo con i testi
Finalmente posso consegnare nelle mani del lettore il piccolo libro da lungo tempo promesso sui racconti dell’infanzia di Gesù. Non si tratta di un terzo volume, ma di una specie di piccola "sala d’ingresso" ai due precedenti volumi sulla figura e sul messaggio di Gesù di Nazaret. Qui ho ora cercato di interpretare, in dialogo con esegeti del passato e del presente, ciò che Matteo e Luca raccontano all’inizio dei loro Vangeli sull’infanzia di Gesù.
Un’interpretazione giusta, secondo la mia convinzione, richiede due passi. Da una parte, bisogna domandarsi che cosa intendevano dire con il loro testo i rispettivi autori, nel loro momento storico - è la componente storica dell’esegesi.
Ma non basta lasciare il testo nel passato, archiviandolo così tra le cose accadute tempo fa. La seconda domanda del giusto esegeta deve essere: È vero ciò che è stato detto? Riguarda me? E se mi riguarda, in che modo lo fa? Di fronte a un testo come quello biblico, il cui ultimo e più profondo autore, secondo la nostra fede, è Dio stesso, la domanda circa il rapporto del passato col presente fa immancabilmente parte della nostra interpretazione. Con ciò la serietà della ricerca storica non viene diminuita, ma aumentata.
Mi sono dato premura di entrare in questo senso in dialogo con i testi. Con ciò sono ben consapevole che questo colloquio nell’intreccio tra passato, presente e futuro non potrà mai essere compiuto e che ogni interpretazione resta indietro rispetto alla grandezza del testo biblico. Spero che il piccolo libro, nonostante i suoi limiti, possa aiutare molte persone nel loro cammino verso e con Gesù.
Castel Gandolfo, nella solennità dell’Assunzione di Maria in Cielo 15 agosto 2012
BENEDETTO XVI
Quando è nato Gesù
Gesù è nato in un’epoca determinabile con precisione. All’inizio dell’attività pubblica di Gesù, Luca offre ancora una volta una datazione dettagliata ed accurata di quel momento storico: è il quindicesimo anno dell’impero di Tiberio Cesare; vengono inoltre menzionati il governatore romano di quell’anno e i tetrarchi della Galilea, dell’Iturea e della Traconìtide, come anche dell’Abilene, e poi i capi dei sacerdoti (cfr. Luca, 3, 1 ss). Gesù non è nato e comparso in pubblico nell’imprecisato "una volta" del mito. Egli appartiene ad un tempo esattamente databile e ad un ambiente geografico esattamente indicato: l’universale e il concreto si toccano a vicenda. In Lui, il Logos, la Ragione creatrice di tutte le cose, è entrato nel mondo. Il Logos eterno si è fatto uomo, e di questo fa parte il contesto di luogo e tempo. La fede è legata a questa realtà concreta, anche se poi, in virtù della Risurrezione, lo spazio temporale e geografico viene superato e il "precedere in Galilea" (Matteo, 28, 7) da parte del Signore introduce nella vastità aperta dell’intera umanità (cfr. Matteo, 28, 16ss).
Da pagina 36 del manoscritto
Quel bimbo stretto in fasce
Maria avvolse il bimbo in fasce. Senza alcun sentimentalismo, possiamo immaginare con quale amore Maria sarà andata incontro alla sua ora, avrà preparato la nascita del suo Figlio. La tradizione delle icone, in base alla teologia dei Padri, ha interpretato mangiatoia e fasce anche teologicamente. Il bimbo strettamente avvolto nelle fasce appare come un rimando anticipato all’ora della sua morte: Egli è fin dall’inizio l’Immolato, come vedremo ancora più dettagliatamente riflettendo sulla parola circa il primogenito.
Così la mangiatoia veniva raffigurata come una sorta di altare. Agostino ha interpretato il significato della mangiatoia con un pensiero che, in un primo momento, appare quasi sconveniente, ma, esaminato più attentamente, contiene invece una profonda verità.
La mangiatoia è il luogo in cui gli animali trovano il loro nutrimento. Ora, però, giace nella mangiatoia Colui che ha indicato se stesso come il vero pane disceso dal cielo - come il vero nutrimento di cui l’uomo ha bisogno per il suo essere persona umana. È il nutrimento che dona all’uomo la vita vera, quella eterna. In questo modo, la mangiatoia diventa un rimando alla mensa di Dio a cui l’uomo è invitato, per ricevere il pane di Dio. Nella povertà della nascita di Gesù si delinea la grande realtà, in cui si attua in modo misterioso la redenzione degli uomini.
Da pagina 38 del manoscritto
*
-
> Il papa deve concedere la grazia al suo ex maggiordomo, Paolo Gabriele (di Gianluigi Nuzzi)8 ottobre 2012, di Federico La Sala
Il papa deve concedere la grazia al suo ex maggiordomo, Paolo Gabriele
di Gianluigi Nuzzi
in “LeMonde.fr” del 8 ottobre 2012
(traduzione: www.finesettimana.org)
Condannato a 18 mesi di reclusione, Paolo Gabriele, il maggiordomo di Benedetto XVI, sarà graziato dal papa? La misericordia del Vangelo e della Chiesa prevedono il perdono. Chiedo solennemente al Santo padre di accordare la grazia al suo ex collaboratore, punito per aver sottratto dei documenti di cui ha fatto pervenire delle fotocopie al giornalista che io sono. Paolo Gabriele non ha violato alcun segreto militare o diplomatico come nel caso Wikileaks. Il suo gesto è un gesto di denuncia. Ha messo sotto gli occhi di tutti le realtà nascoste del Vaticano che nuocciono alla stessa Chiesa.
La grazia, se sarà accordata, proverà che in questo caso, la Chiesa non è un’istituzione oscura e conservatrice ma che, al contrario, è capace di perdonare colui che, a torto o a ragione, ha rischiato il proprio avvenire per il suo bene. Chi ha fatto del torto alla Chiesa? Paolo Gabriele che, abusando della fiducia del papa, ha rivelato i giochi di potere in seno alla Curia o i protagonisti di tali complotti? È mio dovere offrire alcuni elementi di riflessione perché tutti possano sapere ciò che è accaduto e soprattutto quali sono state le vere ragioni - appena accennate durante il processo - che spiegano il gesto dell’ex maggiordomo.
Nei mesi durante i quali ho frequentato il collaboratore del papa, ho affrontato a più riprese il tema della sua responsabilità. Mi è sempre sembrato sereno e convinto di fare ciò che era, secondo lui, indispensabile e giusto. Ha spesso insistito sul fatto che il santo padre era totalmente estraneo alle congiure, ai conflitti di potere, agli intrighi finanziari che i documenti che ho pubblicato nel mio libro mostrano. Il papa, infatti, non ha alcun ruolo in questi oscuri affari. Sembra, al contrario, esserne indirettamente la vittima.
Perché allora non reagisce? Perché non caccia questi mercanti dal tempio? Secondo Paolo Gabriele, il papa è tenuto all’oscuro di ciò che dovrebbe riguardarlo. “Talvolta, ha raccontato Paolo Gabriele nel corso di una delle udienze, mentre eravamo a tavola, Benedetto XVI poneva delle domande a proposito di avvenimenti di cui avrebbe dovuto essere informato”
Questa testimonianza pone nuovamente una questione lancinante: Joseph Ratzinger, teologo, studioso, è un “capo di Stato” informato o vive in una sorta di solitudine? Quante informazioni riceve che gli permetterebbero di avere una visione completa dei problemi che agitano il Vaticano? E, di contro, quante informazioni parziali o tronche gli sono presentate per cercare di influenzarlo?
Beneficiando di un punto di osservazione privilegiato, Paolo Gabriele, che è stato per sei anni una delle persone più vicine al santo padre, dubitava fortemente che Benedetto XVI fosse stato sempre tenuto al corrente di ciò che succedeva tra le mura del Vaticano. Questa realtà che emerge dai documenti che ha sottratto ha aggiunto amarezza al suo dolore. I complotti, i regolamenti di conti sono in evidente contraddizione con i principi di trasparenza fermamente voluti da Benedetto XVI stesso.
Durante i nostri incontri, ha confessato la propria profonda perplessità, il proprio disagio. Ha insistito sul proprio amore per il papa, la propria venerazione per la sua semplicità. Secondo lui, Benedetto XVI è un uomo puro in mezzo ai lupi. Il maggiordomo vedeva crescere la distanza siderale tra il papa e le espressioni più dure e più vili del potere, tra il pastore della Chiesa, che opera per la trasparenza nelle relazioni tra gli Stati, e ciò che si trama alle sue spalle: nomine, flussi finanziari, ecc. La denuncia di Paolo Gabriele si unisce a quella che il cardinale Ratzinger stesso formulava negli anni 70 quando affermava che “la Chiesa sta diventando per molti fedeli l’ostacolo principale alla fede. Riescono a vedere in essa solo l’ambizione umana del potere, il piccolo teatro di uomini, che, con il pretesto di amministrare il cristianesimo ufficiale, sembrano piuttosto ostacolare il vero spirito del cristianesimo”.
A poco a poco, Paolo Gabriele è diventato il confidente di coloro, che, tra i vescovi e i cardinali, erano, come lui, lacerati tra la loro fede, la loro ammirazione sincera per il papa e le manovre di corridoio di cui erano testimoni. Si rivolgevano a lui, pensando così di avere una via di accesso a Benedetto XVI. Fu per lui occasione di scoprire nuove ingiustizie.
Due esempi. La promozione-punizione di monsignor Carlo Maria Viganò, l’economo della Curia, promosso nunzio apostolico a Washington un anno dopo aver informato il papa della corruzione e delle operazioni opache nell’attribuzione di appalti pubblici e di forniture nel più piccolo stato del mondo. Dai documenti sottratti da Paolo Gabriele e che io ho pubblicato emerge che il presepe e l’albero di Natale installati ogni anno in piazza San Pietro costavano... 250.000 euro! Questa denuncia valse a Monsignor Viganò un terribile scontro con il cardinal Tarcisio Bertone, primo collaboratore di Benedetto XVI. Il Vaticano ha sempre replicato che le accuse di Viganò erano false. Paolo Gabriele ha, al contrario, ritenuto Monsignor Viganò vittima della propria volontà di trasparenza. Ha cercato di aiutarlo per quanto gli era possibile.
Secondo esempio: il siluramento di Ettore Gotti Tedeschi, presidente dell’Istituto per le opere di religione, detto anche “la banca del papa”. Gotti Tedeschi è stato allontanato dopo che il consiglio di amministrazione della banca ha voluto rendere meno costrittive le regole anti-riciclaggio. Stimato dal papa, il banchiere è entrato anche lui in conflitto con Bertone. In una memoria confidenziale, trasmessa al papa, confida il timore di essere ucciso. Questi due casi, sui quali deve essere ancora fatta luce, spiegano da soli la frustrazione di un uomo solo di fronte agli intrighi, consapevole della fragilità del sovrano pontefice nella lotta secolare tra il bene e il male.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" .... GIULIO CESARE, IL PONTEFICE ATEO (di Luciano Canfora)25 settembre 2012, di Federico La Sala
Giulio Cesare, il pontefice ateo
Seguace di Epicuro, fu eletto alla massima carica religiosa
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 25.09.2012)
Nell’anno 63 a.C. Giulio Cesare, non ancora quarantenne, grazie ad una campagna elettorale costosissima che rischiò di portarlo definitivamente alla rovina, riuscì a farsi eleggere pontefice massimo, la più alta carica religiosa dello Stato romano. Lo scontro elettorale era stato durissimo; il suo principale antagonista Quinto Lutazio Catulo aveva messo in atto la più pervasiva corruzione elettorale fondata sulla capillare compravendita del voto. Cesare rispose con la stessa arma. Il «mercato politico» - come ancora oggi elegantemente lo si chiama - raggiunse in quell’occasione una delle sue vette. Cesare dovette indebitarsi a tal punto per far fronte ai costi di una tale oscena campagna elettorale da lasciarsi andare, parlando con la madre, alla celebre uscita: «Oggi mi vedrai tornare o pontefice massimo o esule». È Plutarco, al solito egregiamente informato su tutto quell’aspetto del reale che la storia «alta» trascura, a darci la notizia e a chiosarla con una interessante considerazione: con tale vittoria inattesa, e contro un avversario così forte e così autorevole, Cesare «intimidì gli ottimati, i quali capirono che avrebbe potuto indurre il popolo a qualunque audacia» (Vita di Cesare, 7).
Subito dopo esplode la congiura di Catilina. Cesare, che è pretore designato (entrerà in carica nel gennaio 62), è lambito dalla congiura. Ed in Senato, di fronte alla pressione fortissima di chi (come Cicerone e Catone) propugna l’esecuzione capitale dei congiurati, ormai scoperti e arrestati, Cesare sceglie di motivare, con argomenti tratti dalla filosofia di Epicuro, la proposta di lasciarli in vita. Con l’argomento che, se l’anima è mortale, la pena di morte è più lieve di una lunga detenzione! Sappiamo quanto si sia speculato da parte dei contemporanei, e poi degli studiosi moderni, intorno alla implicazione o meno di Cesare nella congiura. Cicerone - e non lui soltanto - era convinto che Cesare fosse compromesso: ma non ritenne di affermarlo apertamente, se non quando il dittatore era morto. Certo, la vittoria elettorale che consentì a Cesare di assumere il pontificato massimo venne al momento opportuno e rivestì lo stesso Cesare di una nuova sacralità protettiva, quanto mai giovevole in quel momento.
Essere implicati in un’iniziativa eversiva segreta si può in molti modi, che vanno dalla diretta partecipazione alla semplice, passiva consapevolezza del progetto. Cesare non era così imprudente da porsi in una posizione tale da divenire ricattabile, una volta fallito il piano, da compagni imprudenti o sfortunati. Cercò però di salvarli parlando in Senato nel modo in cui Sallustio, suo seguace, lo fa parlare, scomparsi ormai tutti i protagonisti della vicenda.
Decimo Silano aveva proposto la pena capitale e la proposta incontrava largo consenso. Cesare interviene per capovolgere una situazione difficilissima e si sforza di presentare la pena di morte come troppo lieve, con l’argomento che - nella sventura - «la morte non è un supplizio, è un riposo agli affanni», in quanto - prosegue in perfetto stile epicureo - «dopo la morte non c’è posto né per il dolore né per il piacere» (Sallustio, Congiura di Catilina, 51). Fa una notevole impressione il pontefice massimo che impartisce agli altri senatori una breve ed efficace (e strumentale) lezione di filosofia epicurea. Era noto che Cesare avesse, come tantissimi nelle classi colte romane, subìto l’influsso o sentito il fascino di quel lucido pensiero anticonsolatorio.
Replicando a Cesare in quel dibattito memorabile, che si concluse con la decisione illegale di procedere all’esecuzione capitale immediata, e senza processo, dei congiurati, Catone ironizzò: Cesare - disse - pontefice massimo, pretore designato, «ci ha amabilmente intrattenuto (bene et composite disseruit) sulla vita e sulla morte»; «se non erro - soggiunse - ha sostenuto teorie false, ha dichiarato infatti di non credere a quello che si narra degli inferi, che cioè i malvagi andranno a finire, dopo la morte, in contrade diverse da quelle destinate ai buoni: contrade tetre, incolte, sinistre, spaventevoli». Questa lezione di corretta credenza religiosa, impartita al pontefice massimo appena eletto, è una delle più sottili perfidie dell’oratoria politica di tutti i tempi.
Naturalmente il problema da porsi è come mai nella società politica romana fosse possibile e conciliabile con il mos maiorum e con la stabilità delle istituzioni avere un «papa ateo».
-
> A 50 ANNI DAL VATICANO II, UNA SITUAZIONE CUPA. LA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA HA ROTTO I PONTI CON IL MESSAGGIO EVANGELICO.19 settembre 2012, di Federico La Sala
 LA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA HA ROTTO I PONTI CON IL MESSAGGIO EVANGELICO. A 50 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, bisogna prendere atto che il terribile è già accaduto: il "Lumen Gentium" è stato spento e, sulla cattedra di Pietro, siede il Vicario del Signore e Padrone Gesù ("Dominus Iesus": J. Ratzinger, 2000).
LA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA HA ROTTO I PONTI CON IL MESSAGGIO EVANGELICO. A 50 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, bisogna prendere atto che il terribile è già accaduto: il "Lumen Gentium" è stato spento e, sulla cattedra di Pietro, siede il Vicario del Signore e Padrone Gesù ("Dominus Iesus": J. Ratzinger, 2000). A 50 ANNI DAL VATICANO II, UNA SITUAZIONE CUPA. Un’analisi di Vito Mancuso - con una nota
A 50 ANNI DAL VATICANO II, UNA SITUAZIONE CUPA. Un’analisi di Vito Mancuso - con una nota Nell’ultima intervista Martini ha dichiarato: «Vedo nella Chiesa di oggi così tanta cenere sopra la brace che spesso mi assale un senso di impotenza», parole che potrebbero essere sottoscritte dalla gran parte dei vescovi e dei periti teologici che cinquant’anni fa arrivavano a Roma per il Vaticano Il. L’ironia vuole che proprio uno di essi sia oggi il pontefice regnante, tra i principali responsabili di questa cupa situazione
Nell’ultima intervista Martini ha dichiarato: «Vedo nella Chiesa di oggi così tanta cenere sopra la brace che spesso mi assale un senso di impotenza», parole che potrebbero essere sottoscritte dalla gran parte dei vescovi e dei periti teologici che cinquant’anni fa arrivavano a Roma per il Vaticano Il. L’ironia vuole che proprio uno di essi sia oggi il pontefice regnante, tra i principali responsabili di questa cupa situazione -
> SE UN PAPA TEOLOGO --- E LA CHIESA "PER MOLTI", NON "PER TUTTI"!!! Per il Convegno "Chiesa di tutti, Chiesa dei poveri", cinque note a margine (di Federico La Sala)13 settembre 2012
 LA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA HA ROTTO I PONTI CON IL MESSAGGIO EVANGELICO. A 50 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, bisogna prendere atto che il terribile è già accaduto: il "Lumen Gentium" è stato spento e, sulla cattedra di Pietro, siede il Vicario del Signore e Padrone Gesù ("Dominus Iesus": J. Ratzinger, 2000). Egli regna e governa in nome del suo Dio, Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
LA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA HA ROTTO I PONTI CON IL MESSAGGIO EVANGELICO. A 50 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, bisogna prendere atto che il terribile è già accaduto: il "Lumen Gentium" è stato spento e, sulla cattedra di Pietro, siede il Vicario del Signore e Padrone Gesù ("Dominus Iesus": J. Ratzinger, 2000). Egli regna e governa in nome del suo Dio, Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).-
> SE UN PAPA TEOLOGO --- E LA CHIESA "PER TUTTI", non "per molti"!!! FAR VIVERE IL CONCILIO VATICANO ii. Affollata assemblea di gruppi ecclesiali, riviste, associazioni a 50 anni dall’inizio del Concilio (di Roberto Monteforte)16 settembre 2012, di Federico La Sala
Affollata assemblea di gruppi ecclesiali, riviste, associazioni a 50 anni dall’inizio del Concilio *
di Roberto Monteforte (l’Unità, 16 settembre 2012)
Far vivere il Concilio Vaticano II. Dargli applicazione e con gioia, guardando con speranza al futuro. Perché la sua piena ricezione è ancora lontana.
Di questo si è discusso ieri a Roma nell’affollatissima assemblea tenutasi al teatro dell’Istituto Massimo di Roma. «Chiesa di tutti, Chiesa dei poveri» è il titolo dell’appuntamento autoconvocato e autofinanziato a 50 anni dall’inizio del Concilio cui hanno aderito oltre 104 sigle di associazioni, gruppi ecclesiali, movimenti, riviste e organizzazioni tutte attente all’esigenza che non si disperda o si depotenzi l’insegnamento del Concilio Vaticano II. Sono stati oltre settecento i partecipanti giunti da tutta Italia. Segno di quanto forte ed estesa sia la domanda per una Chiesa che sappia dialogare con fiducia e speranza con il mondo contemporaneo avendo il coraggio di cambiare se stessa.
L’incontro si è aperto con un ricordo del cardinale Carlo Maria Martini e al suo coraggio profetico. Teologi, storici, studiosi e uomini di Chiesa hanno approfondito i nodi posti dal Concilio alla Chiesa a partire dalla sua ermeneutica. Alla polemica su rottura o continuità con la tradizione della Chiesa.
«È una disputa da abbandonare perché non coglie il nodo rappresentato dal Concilio. Perché il cambiamento era già in corso nella Chiesa. Perché la dottrina cambia sempre e cambiamo i significati. Perché se la Chiesa è sempre la stessa, la Tradizione vivente è in continua evoluzione per rendere “presente” e continuamente aggiornato nella nuova condizione storica ciò che è stato tramandato» lo afferma il teologo padre Carlo Molari. «La pluralità delle dottrine presenti nella Chiesa ed anche le rotture sono importanti per il suo sviluppo». C’è ancora bisogno che la Chiesa sappia «raccordarsi con la modernità».
Lo storico Giovanni Turbanti ha inquadrato il contesto storico, sociale, politico ed economico che ha portato alla sua convocazione. La biblista Rosanna Virgili sottolinea la «festosità liberatoria dell’annuncio cristiano e l’apporto fondamentale dato dalle donne. «Dio parla alle donne - afferma - che sono depositarie di una fede che non esclude. Perché non ci sono più lontani quando si può comunicare e si è abbattuta l’inimicizia fatta di leggi che distinguevano e discriminavano creando inimicizia».
Mentre Cettina Militello ha affrontato il nodo «delle prospettive future nella speranza di un vero aggiornamento». «Bisogna passare dall’ermeneutica conciliare all’attuazione del Concilio. All’attuazione di quanto faticosamente elaborato dai padri conciliari» ha affermato. Sottolinea l’importanza dell’«aggiornamento» della Chiesa. Invita a riflettere sulla speranza di un «vero rinnovamento» della Chiesa, di una sua autentica profezia rispetto alla mutazione culturale in atto. Ne indica gli ambiti: «il piano della Liturgia, dell’autocoscienza di chiesa, dell’acquisizione sempre maggiore della parola di Dio, del dialogo Chiesa con il mondo». Va pure perseguita l’istanza ecumenica, e interreligiosa, l’istanza «dialogica». Sottolinea i limiti della partecipazione attiva, della sinodalità, dell’ ascolto e del dialogo, necessari per attuare quella trasformazione strutturale della Chiesa voluta dai padri conciliari, per il suo ritorno a uno stile evangelico di compartecipazione e effettiva comunione.
Interviene da «testimone» l’allora giovanissimo abate benedettino della Basilica di San paolo, Giovanni Battista Franzoni. Parla della scelta per i «poveri» e del coraggio di Paolo VI. Porta la sua testimonianza il teologo valdese Paolo Ricca. Soprattutto recuperando appieno il ruolo del «Popolo di Dio», dei laici nella Chiesa, successori dei «discepoli». Lo sottolinea Raniero La Valle che conclude i lavori. «Perché - fa notare - non c’è solo la successione apostolica da Pietro sino ai nostri vescovi e al Papa. C’è anche una successione laicale, non meno importante dell’altra che è giunta sino a noi». Senza questa «non vi sarebbe il Popolo di Dio e neanche la Chiesa degli apostoli».
Sottolinea come la forza del Concilio Vaticano II sia stata il fare l’ermeneutica di tutti i concili precedenti. Per questo «non lo si può accantonare ». Sta anche in questo la ragione e la forza dell’assemblea convocata ieri.
La Valle annuncia l’impegno a raccogliere quella domanda che interpella ancora. Chiede una nuova politica, una nuova giustizia, una nuova economia. Che chiede una Chiesa dei poveri e con i poveri. Richiama i compiti nuovi che il Concilio affida e riconosce ai laici. «Sulla riforma della chiesa e delle sue strutture il Concilio è rimasto ai nastri partenza. La Chiesa anticonciliare ha bloccato la collegialità e ha rafforzato i vincoli di dipendenza gerarchica» ma una Chiesa nuova è possibile. Vi è una storia da trasmettere. Un impegno che, assicura La Valle, non si fermerà con questa assemblea. Vi sarà un sito per mettere in rete riflessioni e iniziative e per partecipare alle iniziative delle singole Chiese e a quelle internazionali che culmineranno nel 2015 all’anniversario delle conclusioni del Concilio. Vi sarà un «coordinamento leggero» per far incontrare sforzi diversi e rendere possibile quel «Il Concilio è nelle vostre mani» soprattutto le mani dei poveri invocato dallo stesso Raniero La Valle.
* Titolo redazionale
* Fonte: Incontri di "Fine Settimanana"
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA ... "DEUS CARITAS EST" ---- A 50 ANNI DAL VATICANO II, E’ EMERGENZA TEOLOGICO-POLITICA TOTALE.10 settembre 2012, di Federico La Sala.A 50 ANNI DAL VATICANO II, EMERGENZA TEOLOGICO-POLITICA TOTALE. UN AUT-AUT EPOCALE: RETTIFICARE I NOMI E BONIFICARE LA CHIESA DALLO SPIRITO DI "MAMMONA ("CARITAS") E DI "MAMMASANTISSIMA" O PORTARE AL SUICIDIO LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA?! Che la "Luce delle Genti", il "Lumen Gentium", La illumini ...
 AL VICARIO DEL SIGNORE, IL PADRONE GESU’ ("DOMINUS IESUS"), UN GIURAMENTO DI OBBEDIENZA CIECA E ASSOLUTA. UNICA RILEVANTE ECCEZIONE: CARLO MARIA MARTINI. A partire dal funerale, cominciata l’operazione "anestesia". Una nota di Vito Mancuso - con appunti
AL VICARIO DEL SIGNORE, IL PADRONE GESU’ ("DOMINUS IESUS"), UN GIURAMENTO DI OBBEDIENZA CIECA E ASSOLUTA. UNICA RILEVANTE ECCEZIONE: CARLO MARIA MARTINI. A partire dal funerale, cominciata l’operazione "anestesia". Una nota di Vito Mancuso - con appunti
-
> NEL GIORNO DELLE ESEQUIE DEL CARD. CARLO M. MARTINI. Passi che il Papa non vada a Milano per testimoniare che è Pastore di tutta la Chiesa, ma che ignori il Pastore di una chiesa che è nel cuore dei più può far parte di giochi diplomatici ma non è un bell’esempio di collegialità (di Alberto Simoni op)3 settembre 2012, di Federico La Sala
Nel giorno delle esequie del Card. C. M. Martini
di Alberto Simoni op (Koinonia-forum, n. 314 del 3 settembre 2012)
Cari amici,
una chiesa che dice (senza esserlo) e una chiesa che è (senza dirlo): ecco il quadro che abbiamo sotto gli occhi in questi giorni di rivelazione in morte del card. C.M.Martini, che sembra fare da cartina di tornasole di quella che Galli della Loggia - parlando di correnti della chiesa (Corriere della Sera, 2 settembre) - chiama “Una federazione di popoli diversi”.
In questo momento di grazia, non ci sono solo riti e celebrazioni da sbrigare, ma segni dei tempi da cogliere e frammenti da raccogliere, perché niente si perda. È quanto mi permetto di fare ancora una volta con i vari messaggi che in queste ore ci mettono in comunione e ci fanno pensare.
Parlando all’Angelus del 2 settembre della Legge di Dio che “è la sua Parola che guida l’uomo nel cammino della vita”, Benedetto XVI dice tra l’altro: “Ed ecco il problema: quando il popolo si stabilisce nella terra, ed è depositario della Legge, è tentato di riporre la sua sicurezza e la sua gioia in qualcosa che non è più la Parola del Signore: nei beni, nel potere, in altre ‘divinità’ che in realtà sono vane, sono idoli. Certo, la Legge di Dio rimane, ma non è più la cosa più importante, la regola della vita; diventa piuttosto un rivestimento, una copertura, mentre la vita segue altre strade, altre regole, interessi spesso egoistici individuali e di gruppo”. Ma forse questo coraggioso guardarsi allo specchio non basta, se finisce lì.
Sarebbe bastato invece che avesse semplicemente detto che qualcuno nella chiesa ha cercato per tutta la vita di risvegliare la coscienza e la memoria di questo Popolo di Dio e di farlo uscire dalla sua falsa sicurezza. E questo qualcuno è stato il card. C.M.Martini, che però il Papa si è guardato bene dal ricordare e dal proporre come servo della Parola e come guida alla chiesa di Dio, lasciando quella chiesa che lo ascolta nella illusione di essere al sicuro nel proprio ovile e suscitando invece disillusione in quella chiesa della diaspora che, insieme a tutte le donne e gli uomini di questo mondo, è alla ricerca di un pastore e di un ovile dove si possa entrare ed uscire.
Passi che il Papa non vada a Milano per testimoniare che è Pastore di tutta la Chiesa, ma che ignori il Pastore di una chiesa che è nel cuore dei più può far parte di giochi diplomatici ma non è un bell’esempio di collegialità: perché continuare a nascondere sotto il moggio le lampade che lo Spirito accende tra il Popolo di Dio? Ma se anche tutto ciò fa tristezza, non può impedire che gridino le pietre. E forse dal card. Martini c’è da imparare a far convivere, senza confonderle, “ragioni di Stato” con istanze evangeliche...
-
> NEL GIORNO DELLE ESEQUIE DEL CARD. CARLO M. MARTINI. ---- (Il disegno di Ratzinger e) il segreto di Martini. Da una parte l’amore dei fedeli dall’altra la freddezza del Papa4 settembre 2012, di Federico La Sala
Da una parte l’amore dei fedeli dall’altra la freddezza del Papa
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 4 settembre 2012)
Il segreto di Martini sta nei volti di quanti alla vigilia dei funerali si sono seduti nei banchi del duomo di Milano semplicemente per pensare a lui. Il segreto sta nel silenzio del Papa all’Angelus domenicale, quando avrebbe dovuto scegliere se indicarlo o no come esempio. E non lo ha fatto. Il segreto sta nei buddisti e nei musulmani e nei non-credenti, che hanno partecipato alla messa. E nei rabbini ebrei che sono andati in fila a fare le condoglianze in arcivescovado.
Non è questione dell’impatto mediatico di questi giorni. Carlo Maria Martini viveva nel cuore di una massa enorme di cattolici, che aspettavano l’apparire dei suoi libri e delle sue frasi illuminanti, sparse con misura sulle pagine del Corriere della Sera in una rubrica di colloquio con i lettori che - apprendiamo dallo stesso direttore Ferruccio Bortoli - “spiacque a Roma”, cioè al Vaticano. I fedeli amavano Martini perché dava voce ai loro dubbi, alla loro ansia di trovare risposte a problemi difficili, perché dava forma teologica a scelte di coscienza che sentono giuste e in sintonia col loro essere cristiani. I cattolici del quotidiano, quelli delle parrocchie, del volontariato, dell’associazionismo, amavano - anzi amano - Martini, perché la sua cultura teneva insieme la parola della Bibbia e i nodi esistenziali con cui credenti e diversamente credenti devono misurarsi. Ha colpito come una folgore, ieri nel duomo, l’applauso scrosciante indirizzato al cardinale Tettamanzi perché ha detto la semplice parola “Noi ti amiamo”. Un contrasto fortissimo con il compatto silenzio riservato al messaggio papale letto dal cardinale Comastri e all’omelia del cardinale Scola.
Perché Ratzinger ha dedicato a Martini parole molto belle, di affettuosa stima, ne ha lodato l’impegno generoso, la “grande apertura d’animo”, la carità, l’incontro e il “dialogo con tutti”. Ma nella scelta precisa delle parole affiorava l’ergersi di una barriera fredda, che non permette la condivisione dell’esperienza di Martini: il distacco profondo da tutto quello che Martini ha detto e scritto negli ultimi anni. A partire dal grido finale “La Chiesa è indietro di 200 anni”, lanciato dal cardinale poche settimane prima della sua morte.
In tutti i discorsi cesellati, ascoltati durante i funerali, il crinale è stato uno solo: Carlo Maria Martini è un indicatore del futuro o no? Soltanto il cardinale Tettamanzi ha espresso ciò che la folla sentiva di pancia, di cuore e di testa: “Ti abbiamo amato per il tuo sguardo capace di vedere lontano...”. E la vox populi ha reagito con l’ovazione.
Il segreto di Martini sta in tutte quelle donne cattoliche, giovani e anziane, impegnate in famiglia o immerse nella vita professionale, che sentivano la sua disponibilità ad aprire le porte dell’istituzione ecclesiastica ad una partecipazione reale, determinante, del mondo femminile nel cammino della comunità dei fedeli. Quelle donne che ieri in duomo osservavano che di femminile c’era solo il canto delle soliste e due suore e tre laiche nel corteo delle offerte, sommerse da una nuvola di tonache maschili.
Il segreto di Martini sta in quei giovani - vicini o lontani dall’istituzione ecclesiastica - che ne amavano l’assenza di teatralità, lo stile controllato di chi non vuole strappare punti alla hit parade dei consensi, ma propone cose su cui riflettere, rimuginare, da cui lasciarsi interrogare. La sua capacità di attrazione riluce anche nella volgarità dei suoi avversari come il ciellino Antonio Socci, felice di proclamare che le massime del cardinale era “terribilmente banali” e ansioso di accusarlo di avere “accarezzato il Potere, quello della mentalità dominante...” e di essere stato “ospite assiduo dei salotti mediatici”.
La folla, che si è recata a vedere la sua bara nei giorni scorsi e ieri straripava in piazza Duomo, amava soprattutto il suo coraggio di parlare, di dire apertamente che ci sono problemi che la Chiesa deve affrontare e risolvere. L’Italia cattolica si sta desertificando. Sono morti cattolici non intimiditi come Lazzati, Scoppola, Alberigo. Ora che si è spenta anche la voce autorevole di Martini la scena è popolata da persone che parlano per piccoli accenni, che temono di apparire dissenzienti, che hanno paura di essere bollati come critici fuori dal coro.
Avranno nostalgia di Martini i credenti e i diversamente credenti, interessati a riflettere su quanto di “infinito” c’è nell’uomo, ma avidi di un confronto vero, non fra chi sa tutto e chi deve essere ammaestrato. Sentiranno bisogno delle sue ultime riflessioni quanti - di nascosto, e ce ne sono tanti tra preti e vescovi - condividono il suo giudizio su una Chiesa che “non si scuote”, che sembra avere paura invece di coraggio. Se il cardinale Scola ha evocato un cattolicesimo, in cui esistano “diversità di sensibilità e letture diverse delle urgenze del tempo”, in cui ci sia spazio per la pluriformità nell’unità, manca ancora molto perché questa visione diventi realtà praticata nella Chiesa di Roma.
Martini non lascia successori. Nel collegio cardinalizio non ci sono voci, come la sua, pronte a proporre un concilio o un vertice di capi cristiani insieme al pontefice. Ma poiché la sua visione di riforme si contrappone alla Chiesa in trincea dell’era ratzingeriana, il porporato sarà ben presente in spirito e scritti al futuro conclave.
-
-
> RATZINGERISMO E BERLUSCONISMO: IL SONNO MORTIFERO DELLA CHIESA E DELL’ITALIA. "Dio è al di là delle frontiere che vengono erette". Così come l’Italia è al di là di tutti i partiti.3 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA --- SPEGNE IL "LUMEN GENTIUM" E INSTAURA IL POTERE DEL "DOMINUS IESUS", IL "CARLO MAGNO" DEL SACRO ROMANO IMPERO.30 agosto 2012, di Federico La Sala
LUMEN GENTIUM (21 novembre 1964) *
"1. Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria missione universale. Le presenti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena unità in Cristo".
*
PER IL TESTO COMPLETO, VEDI: LUMEN GENTIUM COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA 21 novembre 1964.
 CAPITOLO I. IL MISTERO DELLA CHIESA. La Chiesa è sacramento in Cristo
CAPITOLO I. IL MISTERO DELLA CHIESA. La Chiesa è sacramento in Cristo
DOMINUS IESUS (6 Agosto 2000) *
"INTRODUZIONE
 1. Il Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, affidò ai suoi discepoli il mandato di annunciare il Vangelo al mondo intero e di battezzare tutte le nazioni: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato» (Mc 16,15-16); «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,18-20; cf. anche Lc 24,46-48; Gv 17,18; 20,21; At 1,8)".
1. Il Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, affidò ai suoi discepoli il mandato di annunciare il Vangelo al mondo intero e di battezzare tutte le nazioni: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato» (Mc 16,15-16); «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,18-20; cf. anche Lc 24,46-48; Gv 17,18; 20,21; At 1,8)".* PER IL TESTO COMPLETO, VEDI: DICHIARAZIONE "DOMINUS IESUS"
 CIRCA L’UNICITÀ E L’UNIVERSALITÀ SALVIFICA
DI GESÙ CRISTO E DELLA CHIESA
CIRCA L’UNICITÀ E L’UNIVERSALITÀ SALVIFICA
DI GESÙ CRISTO E DELLA CHIESA Joseph Card. Ratzinger
Joseph Card. Ratzinger
 Prefetto
Prefetto Tarcisio Bertone, S.D.B.
Tarcisio Bertone, S.D.B.
 Arcivescovo emerito di Vercelli
Arcivescovo emerito di Vercelli
 Segretario
Segretario -
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- IL REGNO DEL DIO DI BENEDETTO XVI: RICCHEZZA "PER NOI" E CARESTIA "PER MOLTI" E "PER TUTTI".27 agosto 2012, di Federico La Sala
-
> SE DIO SI E’ FATTO PAROLA, IO NON POSSO GIOCARE CON LE PAROLE. IL CATECHISTA NON USA MAI PAROLE EQUIVOCHE (di don Mauro Agreste - Unione catechisti).23 agosto 2012, di Federico La Sala
I CARISMI
di don Mauro Agreste *
1) OGGI PARLIAMO DEI CARISMI Oggi parliamo dei carismi ed è importante averne una conoscenza un pochino più strutturata, perché come catechisti nelle vostre comunità parrocchiali, ma anche nei gruppi di preghiera, è bene che abbiate una conoscenza il più possibile ampia su questo tema. Tutto sommato è stato lasciato per molti versi ad alcuni gruppi ecclesiali, oppure a degli alti studi universitari nell’Università Pontificia. Il tema dello spirito dei carismi è un tema che fa parte della vita della Chiesa; se ne tratta nel Concilio e nella Lumen Gentium. Al n°12 dice che la Chiesa costituita dal popolo di Dio è per così dire, il luogo in cui si esercitano i carismi, ognuno per la sua propria specificità. Però la maggior parte delle persone, quando sentono dire la parola carisma non è che abbiano molto chiaro in mente di che cosa si tratti, è vero?
2) PAROLA USATA E ABUSATA DA MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA Per di più questa parola è stata usata e abusata da giornalisti, da mezzi di comunicazione di massa non per indicare il significato preciso della parola carisma, quanto invece per indicare la capacità che ha una persona di attirare l’attenzione degli altri in qualunque campo, con la sua propria capacità di emergere sugli altri. Quindi in senso generico la parola carisma o personaggio carismatico all’interno della Chiesa e di alcuni gruppi ecclesiali vieni intuita in un certo modo. All’infuori della Chiesa il personaggio carismatico è un personaggio che ha delle chances in più, ha un savoir faire diverso in tutti i campi, sportivo, politico, ecc. ecc. da emergere e attirare l’attenzione, quasi catalizzando l’attenzione degli altri.
3) CARISMA HA LA STESSA RADICE DELLA PAROLA CARITÀ Ma che cos’è dunque il carisma e da che cosa nasce? Intanto la parola carisma deriva dal greco e come voi potete benissimo accorgervi contiene dentro di sé una radice, charis, che è la stessa radice della parola carità. Ora la parola carità, anche se abbiamo una vaga intuizione, è una parola che ha significati molto complessi e molto profondi, per cui almeno nel nostro linguaggio teologico, non è facile definire la carità semplicemente come un atteggiamento. La carità è prima di tutto una caratteristica di Dio stesso, una caratteristica essenziale, tant’è vero che gli antichi dicevano: Deus est charitas da cui gli antichissimi inni, ubi charitas et amor Deus ibi est, dov’è carità e amore lì c’è Dio. Dunque carità ha in sé questa radice charis, che significa qualche cosa di forte, di caldo, di vivo, di avvolgente. Viene cantato nel Veni Creator, si parla dello Spirito Santo e si dice che lo Spirito Santo è ignis, fuoco, fuoco di carità, fuoco di amore.
4) CARITÀ E AMORE VENGONO SPESSO USATI COME SINONIMI Carità e amore vengono spesso usati come sinonimi per una semplice ragione, sono entrambi concetti estremamente profondi. Se tu dici amore, è sufficiente dire amore per capire tutto ciò che significa la parola amore? No, cioè lo usiamo convenzionalmente però noi sappiamo che l’amore autentico per esprimerlo, per significarlo è molto difficile. Ricordate questa mattina il brano del Vangelo che è stato letto: nessuno ha un amore più grande se non colui che muore per i propri amici. Quindi vedete l’amore coinvolge fino alla donazione della vita. L’amore esige per esempio il concetto, che deve essere chiaro, della capacità di donarsi. Amore e donazione totale coincidono; però quando io dico amore non dico solo donazione totale, dico anche gioia, dico anche situazione di protezione. Una persona che ama è una persona che ne sta proteggendo un’altra; una persona che si sente amata è una persona che si sente protetta. Il concetto di guida: chi ama guida; chi è amato si sente guidato non gettato allo sbaraglio. Voi potete immaginare quale grande significato c’è nella parola amore; viene considerata sinonimo di carità, però entrambe hanno una specificità; che l’amore e la carità sono due realtà vive, coincidono con Dio.
5) PARLARE DI CARITÀ SIGNIFICA PARLARE DI GRAZIA Quindi parlare di carità, significa parlare di grazia, che charis è una traslitterazione, è la radice della parola greca che significa grazia. Che cos’è la grazia? Non è la gentilezza nei movimenti, la grazia è lo Spirito Santo in azione, lo Spirito Santo mentre agisce, lo Spirito Santo che sta agendo. Vieni Padre donaci la tua santa grazia, donaci cioè lo Spirito Santo che agisce dentro di noi. Ricordatevi che anche se avete il concetto chiaro nella mente, quelli che sono davanti a voi fraintendono facilmente, soprattutto queste cose complesse. Quindi dovete avere sempre l’idea di parlare a un bambino di 5 anni e state tranquilli che le persone davanti a voi non si sentiranno umiliate e non vi disprezzeranno se voi parlerete il più semplice possibile.
6) CHIEDI CHE LO SPIRITO SANTO VENGA AD AGIRE DENTRO DI TE Allora, donaci la santa grazia, certo che vuol dire donaci la capacità e la disponibilità a seguire i suggerimenti dello Spirito, però tu chiedi proprio che lo Spirito Santo venga ad agire dentro di te, però non senza di te. Quando invochiamo la grazia di Dio su di noi, invochiamo lo Spirito Santo che venga ad animarci dall’interno, come il lievito che fa lievitare tutta la pasta; il lievito non fa sparire la pasta, la fa solo lievitare; certo se non c’è la pasta puoi mettere anche un chilo di lievito che tanto non lievita niente. Allora quando si dice grazia si dice Spirito Santo in azione. Cosa vuol dire charis? Grazia. Cosa vuol dire grazia? Spirito Santo in azione. Lo Spirito Santo aleggiava sopra le acque informi, quindi lo Spirito Santo era già in azione appena Dio ha fatto esistere qualche cosa, ancora non c’era la luce, ma già lo Spirito Santo era in azione. Lo Spirito Santo agisce continuamente. L’ultimo versetto dell’Apocalisse dice: lo Spirito Santo e la sposa gridano Maranthà, vieni Signore Gesù. Quindi attenzione bene, tutta la Bibbia è contenuta da questa azione di Spirito Santo, dunque, tutta la storia degli uomini è contenuta in questi due punti fondamentali: lo Spirito Santo che aleggia e lo Spirito Santo che anima dicendo vieni. Gli uomini non si accorgono dell’azione dello Spirito Santo.
7) NUTRIRE UNA PARTICOLARE ADORAZIONE DELLO SPIRITO SANTO Allora i catechisti hanno questo compito fondamentale, fra tutti gli altri, di nutrire una particolare adorazione dello Spirito Santo. Dico giusto quando dico adorazione, per una semplice ragione, quale? Perché lo Spirito Santo è Dio. Quindi il catechista che non adora lo Spirito Santo non so che razza di catechista voglia essere. Lo Spirito Santo è la grazia che agisce dentro di noi. Il catechista che si mette al servizio della Chiesa, come fa a mettersi al servizio dicendo l’amore per Gesù se non è lo Spirito Santo a comunicarglielo?
8) PARLARE DI SPIRITO SANTO E DIO COME DUE PERSONE SEPARATE Domanda: questo fatto di parlare di Spirito Santo e Dio come due persone separate, non rischia di confonderci? E quando parliamo del Padre separato dal Figlio, non si rischia di creare dei problemi? Nelle dispense degli anni passati c’è quel disegno molto bello che si riferisce allo schema intuitivo su Dio e le sue tre persone. Dio è Padre, è Figlio e Spirito Santo, un solo Dio, però il Padre non è il Figlio, non è lo Spirito Santo e lo Spirito Santo non è il Padre. È chiaro che la nostra mente è così limitata che noi non riusciamo a capire, possiamo solo contemplare.
9) FACCIAMO PARTE DELLA TRINITÀ Di più ancora. Facciamo parte di questa Trinità, con il Battesimo siamo entrati dentro la Trinità, perché siamo con Gesù una cosa sola. Siamo entrati nella Trinità, però non siamo Dio, siamo esseri umani, però facciamo parte della Trinità. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo; quindi la volontà di Dio è che siamo immersi ( bactizzomai verbo greco che significa essere immersi ) in tutto Dio Padre, in tutto Dio Figlio e in tutto Dio Spirito Santo. Questo vuol dire che dentro di noi c’è tutto Dio Padre, tutto Dio Figlio, tutto Dio Spirito Santo e come lo spieghi questo? Quando tu vai a fare la comunione prendi un’ostia grande così, tu sai che lì dentro c’è il Dio Eterno e Infinito, Signore della storia e dei secoli. Sotto un velo di pane c’è il mistero di tutto ciò che esiste. Possiamo intuire. Come dice l’inno Pange Lingua. Visus tactus gustus in te fallitur, la vista il tatto il sapore falliscono, perché tutto quello che i sensi constatano è fallace, non i sensi ma la fede conosce questa verità. Allora con la fede tu accetti, il mistero lo contempli, però non lo capisci. Perché capire dal latino càpere vuol dire prendere e tenere stretto, contemplare invece significa guardare, ma non da soli, sostenuti. Tu puoi guardare il mistero di Dio da solo, lo puoi contemplare cioè tu puoi entrare nel tempio insieme a qualcuno, contemplare entrare nel tempio insieme a qualcuno. Tu non possiedi il tempio è il tempio che possiede te.
10) IL CATECHISTA DEVE PARLARE UN ITALIANO SEMPLICE E COMPRENSIBILE Attenzione, perché usiamo la lingua, ma non la conosciamo e un catechista non può permettersi questo. Un catechista deve parlare un italiano semplice e comprensibile a quelli che ha di fronte però deve conoscere dieci o venti volte di più di quello che sta dicendo agli altri, se no che cosa sta comunicando? Certamente ai bambini non puoi dire le specificità dei termini che vi sto spiegando, però su tu non conosci il significato delle parole, tu insegnerai delle cose sbagliate e noi non possiamo permetterci di fare questo, se no non stiamo divulgando il Vangelo di Gesù Cristo, ma il Vangelo secondo noi. Quindi ricordatevi, è un servizio fatto a Dio quello anche di essere precisi nel linguaggio che si usa. Siate precisi cercando di conoscere il più possibile il significato delle parole che usate, anche le più comuni. E chiedete allo Spirito Santo che vi dia una struttura logica del pensiero: soggetto, predicato, complemento. Diversamente il vostro discorso non sarà compreso da chi vi ascolta; piuttosto articolate frasi e concetti brevi non un discorso lungo e strutturato. Fate discorsi brevi, frasi brevi, ma che siano chiare.
11) LA CONIUGAZIONE DEI VERBI DEVE ESSERE PRECISA State anche attenti alla coniugazione dei verbi, che deve essere precisa, perché un verbo al condizionale ha un significato diverso da un verbo all’indicativo; perché un verbo all’indicativo indica una realtà, un obbligo imprescindibile, un verbo al condizionale indica una possibilità cioè una dualità di realtà; i congiuntivi sono verbi di consequenzialità; se io nella mente non ho l’idea della consequenzialità delle cose, non userò il congiuntivo, userò l’indicativo e renderò tutto obbligante. Ricordatevi che abbiamo a che fare con le parole, che noi abbiamo la parola di Dio nella mano e siamo i catechisti, non ci possiamo permettere di giocare con le parole, perché da come io uso le parole, favorisco o freno il passaggio del concetto di Dio. Senza diventare fanatici, senza esagerare, però o prendiamo sul serio il nostro servizio reso a Dio. Quindi tutto quello che dipende da me io cerco di farlo al meglio che posso, oppure facciamo come fanno tanti che improvvisano tutto, vanno avanti e non si rendono conto che stanno giocando con Dio. Se sul Vangelo c’è scritto: in principium erat verbum et verbum erat aput deum et verbum erat deum, allora questo ci fa capire che in principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio.
12) SE DIO SI E’ FATTO PAROLA, IO NON POSSO GIOCARE CON LE PAROLE Se Dio si è fatto la parola che noi possiamo intuire e capire, io posso giocare con le parole? No. Non dico questo perché dobbiamo spaventarci, sentirci colpevolizzati, però sentiamo la necessità di pensare le parole che usiamo e pensare le frasi che usiamo, perché se io devo parlare a dei bambini, dovrò rendere estremamente semplice un discorso difficilissimo. Però usando delle parole che siano giuste, che cerchino di generare meno equivoci possibili, adatte al vocabolario che è in possesso a un bambino di 7-10-12-15 anni, senza mai cedere ad accettare una connotazione di linguaggio che non sia più che dignitosa ed elegante.
13) IL CATECHISTA NON USA MAI PAROLE EQUIVOCHE Se ci sono dei modi di dire che esprimono il concetto di essere arrabbiati in un certo modo, il catechista non li usa mai, neanche quando sta da solo. Se ci sono parole equivoche il catechista si deve abituare non solo a non usarle lui, ma a sentirne ribrezzo quando le sente pronunciare da altri, perché il catechista sta usando con la propria lingua un mezzo di evangelizzazione. Dunque l’apostolo san Giacomo dice nella sua lettera al cap. 4 che chi domina la lingua domina tutto il resto del corpo. Ora un catechista che non domina la lingua come può produrre negli altri un cambiamento di vita, se le parole che escono da lui sono sporcate da una incapacità di dominare la lingua? Naturalmente quando dico capacità di dominare la lingua non mi riferisco solamente a un linguaggio volgare e pesante, mi riferisco anche a un modo di gestire il linguaggio. Una persona che non è capace a non criticare, una persona dalla cui bocca esce sempre una parola di critica, di giudizio, di condanna, di curiosità, di pettegolezzo ecc. può giustamente essere catechista? Non può. Un catechista che non sente fondamentale dentro di sé l’imperativo di sapere quello che sta dicendo, come lo sta dicendo e non si domanda se le parole che sta usando le capisce prima lui, come fa a spiegarle agli altri?
14) IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE AMARE E AMORE Quante volte abbiamo esaminato il significato delle parole amare e amore. Se un catechista non sa che cosa vuol dire amare, sapete con che cosa lo confonde? Con il romanesco volemose bene. Ma amare non è quello, quello non è amare, quello lì è solo cercare di stare tranquilli, senza prendersi tanti problemi, vero? Invece amare è tutta un’altra cosa. Stamattina abbiamo sentito: dare la vita per i propri amici. Vedete che è estremamente differente. Allora non deve essere così per voi, perché voi avete sentito veramente una chiamata del Signore, se no non sareste qui al sabato mattina. Però per non perdere tempo né io, né voi e neanche Dio, cerchiamo proprio di capire l’importanza di tutto questo. Quando nelle scuole ci facevano fare l’analisi logica, l’analisi del periodo erano molto importanti; se abbiamo dimenticato tutto questo la prima cosa che dobbiamo fare è chiedere allo Spirito Santo che venga a rispolverare dentro di noi le cose che avevamo studiato allora, che le faccia emergere. Vedrete che lo Spirito Santo vi aiuterà; poi dopo cominciate con l’analizzare il linguaggio che usate, le strutture logiche che usate, se sono chiare. Ricordatevi che le persone che avete di fronte non sono dentro la vostra mente, dunque loro non sanno esattamente dove voi volete arrivare. Una grande carità che potete fare nei confronti del vostro prossimo, un grande servizio è quello di fare un passettino piccolo alla volta. Non date mai niente per scontato, anche se doveste ripetere cento volte in cento incontri, serve per aiutare quella persona a entrare nel difficile concetto che voi volete dire.
15) DOBBIAMO IMPARARE A PERDONARE Per es.: dobbiamo imparare a perdonare. Che vuol dire perdono? È una parola composta. Dividete a metà la parola, per e dono; quella che capite subito è dono, cosa vuol dire dono? È un regalo, non meritato, perché un dono meritato si chiama premio. Capite perché bisogna essere precisi? Perché se io non dico questo allora il perdono mi diventa un diritto, invece non è un diritto, è un dono, un regalo non meritato; quindi se il regalo non è meritato mi viene fatto perché io sono buono o è buono chi mi fa il regalo? Chi mi fa il regalo. L’altra parola da capire è per che deriva dal greco iper, che vuol dire il più grande; quindi se iper vuol dire il più e donum, regalo, mettendo insieme avete l’insegnamento che dovete fare sul concetto di perdono. Poi ci potete parlare per sei mesi ai bambini del perdono, però se sapete cosa vuol dire voi insegnate realmente ciò che insegna la Chiesa, non ciò che insegna il mondo: vogliamoci bene perché il Signore è buono e ci perdona, tanto perdona tutto e tutti. No! Il catechista non può fare queste cose, non si può confondere il perdono con un sentimento di piacevolezza e di arrendevolezza, non è così. Allora siamo partiti dal tema dei carismi, la prossima volta ricordatemi che dobbiamo continuare sul significato della parola carisma. Abbiamo appena analizzato la radice charis che vuol dire grazia e che significa Spirito santo in azione.
-
>IL CATECHISTA NON USA MAI PAROLE EQUIVOCHE --- "ANTIQUUM MINISTERIUM". LETTERA APOSTOLICA CHE ISTITUISCE IL MINISTERO DI CATECHISTA (di papa Francesco):11 maggio 2021, di Federico La Sala
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO» DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
"ANTIQUUM MINISTERIUM" CON LA QUALE SI ISTITUISCE IL MINISTERO DI CATECHISTA *
1. Il ministero di Catechista nella Chiesa è molto antico. È pensiero comune tra i teologi che i primi esempi si ritrovino già negli scritti del Nuovo Testamento. Il servizio dell’insegnamento trova la sua prima forma germinale nei “maestri” a cui l’Apostolo fa menzione scrivendo alla comunità di Corinto: «Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime» (1 Cor 12,28-31).
Lo stesso Luca apre il suo Vangelo attestando: «Ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1,3-4). L’evangelista sembra essere ben consapevole che con i suoi scritti sta fornendo una forma specifica di insegnamento che permette di dare solidità e forza a quanti hanno già ricevuto il Battesimo. L’apostolo Paolo ritorna di nuovo sull’argomento quando raccomanda ai Galati: «Chi viene istruito nella Parola, condivida tutti i suoi beni con chi lo istruisce» (Gal 6,6). Come si nota, il testo aggiunge una peculiarità fondamentale: la comunione di vita come caratteristica della fecondità della vera catechesi ricevuta.
2. Fin dai suoi inizi la comunità cristiana ha sperimentato una diffusa forma di ministerialità che si è resa concreta nel servizio di uomini e donne i quali, obbedienti all’azione dello Spirito Santo, hanno dedicato la loro vita per l’edificazione della Chiesa. I carismi che lo Spirito non ha mai cessato di effondere sui battezzati, trovarono in alcuni momenti una forma visibile e tangibile di servizio diretto alla comunità cristiana nelle sue molteplici espressioni, tanto da essere riconosciuto come una diaconia indispensabile per la comunità. L’apostolo Paolo se ne fa interprete autorevole quando attesta: «Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole» (1 Cor 12,4-11).
All’interno della grande tradizione carismatica del Nuovo Testamento, dunque, è possibile riconoscere la fattiva presenza di battezzati che hanno esercitato il ministero di trasmettere in forma più organica, permanente e legato alle diverse circostanze della vita, l’insegnamento degli apostoli e degli evangelisti (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 8). La Chiesa ha voluto riconoscere questo servizio come espressione concreta del carisma personale che ha favorito non poco l’esercizio della sua missione evangelizzatrice. Lo sguardo alla vita delle prime comunità cristiane che si sono impegnate nella diffusione e sviluppo del Vangelo, sollecita anche oggi la Chiesa a comprendere quali possano essere le nuove espressioni con cui continuare a rimanere fedeli alla Parola del Signore per far giungere il suo Vangelo a ogni creatura.
3. L’intera storia dell’evangelizzazione di questi due millenni mostra con grande evidenza quanto sia stata efficace la missione dei catechisti. Vescovi, sacerdoti e diaconi, insieme a tanti uomini e donne di vita consacrata, hanno dedicato la loro vita all’istruzione catechistica perché la fede fosse un valido sostegno per l’esistenza personale di ogni essere umano. Alcuni inoltre hanno raccolto intorno a sé altri fratelli e sorelle che nella condivisione dello stesso carisma hanno costituito degli Ordini religiosi a totale servizio della catechesi.
Non si può dimenticare, l’innumerevole moltitudine di laici e laiche che hanno preso parte direttamente alla diffusione del Vangelo attraverso l’insegnamento catechistico. Uomini e donne animati da una grande fede e autentici testimoni di santità che, in alcuni casi, sono stati anche fondatori di Chiese, giungendo perfino a donare la loro vita. Anche ai nostri giorni, tanti catechisti capaci e tenaci sono a capo di comunità in diverse regioni e svolgono una missione insostituibile nella trasmissione e nell’approfondimento della fede. La lunga schiera di beati, santi e martiri catechisti ha segnato la missione della Chiesa che merita di essere conosciuta perché costituisce una feconda sorgente non solo per la catechesi, ma per l’intera storia della spiritualità cristiana.
4. A partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la Chiesa ha sentito con rinnovata coscienza l’importanza dell’impegno del laicato nell’opera di evangelizzazione. I Padri conciliari hanno ribadito più volte quanto sia necessario per la “plantatio Ecclesiae” e lo sviluppo della comunità cristiana il coinvolgimento diretto dei fedeli laici nelle varie forme in cui può esprimersi il loro carisma. «Degna di lode è anche quella schiera, tanto benemerita dell’opera missionaria tra i pagani, che è costituita dai catechisti, sia uomini che donne. Essi, animati da spirito apostolico e facendo grandi sacrifici, danno un contributo singolare ed insostituibile alla propagazione della fede e della Chiesa...Nel nostro tempo poi, in cui il clero è insufficiente per l’evangelizzazione di tante moltitudini e per l’esercizio del ministero pastorale, il compito del Catechista è della massima importanza» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 17).
Insieme al ricco insegnamento conciliare è necessario far riferimento al costante interesse dei Sommi Pontefici, del Sinodo dei Vescovi, delle Conferenze Episcopali e dei singoli Pastori che nel corso di questi decenni hanno impresso un notevole rinnovamento alla catechesi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, l’Esortazione apostolica Catechesi tradendae, il Direttorio catechistico generale, il Direttorio generale per la catechesi, il recente Direttorio per la catechesi, unitamente a tanti Catechismi nazionali, regionali e diocesani sono un’espressione del valore centrale dell’opera catechistica che mette in primo piano l’istruzione e la formazione permanente dei credenti.
5. Senza nulla togliere alla missione propria del Vescovo di essere il primo Catechista nella sua Diocesi insieme al presbiterio che con lui condivide la stessa cura pastorale, e alla responsabilità peculiare dei genitori riguardo la formazione cristiana dei loro figli (cfr CIC can. 774 §2; CCEO can. 618), è necessario riconoscere la presenza di laici e laiche che in forza del proprio battesimo si sentono chiamati a collaborare nel servizio della catechesi (cfr CIC can. 225; CCEO cann. 401 e 406). Questa presenza si rende ancora più urgente ai nostri giorni per la rinnovata consapevolezza dell’evangelizzazione nel mondo contemporaneo (cfr Esort. Ap. Evangelii gaudium, 163-168), e per l’imporsi di una cultura globalizzata (cfr Lett. enc. Fratelli tutti, 100.138), che richiede un incontro autentico con le giovani generazioni, senza dimenticare l’esigenza di metodologie e strumenti creativi che rendano l’annuncio del Vangelo coerente con la trasformazione missionaria che la Chiesa ha intrapreso. Fedeltà al passato e responsabilità per il presente sono le condizioni indispensabili perché la Chiesa possa svolgere la sua missione nel mondo.
Risvegliare l’entusiasmo personale di ogni battezzato e ravvivare la consapevolezza di essere chiamato a svolgere la propria missione nella comunità, richiede l’ascolto alla voce dello Spirito che non fa mai mancare la sua presenza feconda (cfr CIC can. 774 §1; CCEO can. 617). Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono di conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana. È compito dei Pastori sostenere questo percorso e arricchire la vita della comunità cristiana con il riconoscimento di ministeri laicali capaci di contribuire alla trasformazione della società attraverso la «penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico» (Evangelii gaudium, 102).
6. L’apostolato laicale possiede una indiscussa valenza secolare. Essa chiede di «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole secondo Dio» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen Gentium, 31). La loro vita quotidiana è intessuta di rapporti e relazioni familiari e sociali che permette di verificare quanto «sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo» (Lumen Gentium, 33). È bene ricordare, comunque, che oltre a questo apostolato «i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l’apostolato della Gerarchia a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l’apostolo Paolo nell’evangelizzazione, faticando molto per il Signore» (Lumen Gentium, 33).
La funzione peculiare svolta dal Catechista, comunque, si specifica all’interno di altri servizi presenti nella comunità cristiana. Il Catechista, infatti, è chiamato in primo luogo a esprimere la sua competenza nel servizio pastorale della trasmissione della fede che si sviluppa nelle sue diverse tappe: dal primo annuncio che introduce al kerygma, all’istruzione che rende consapevoli della vita nuova in Cristo e prepara in particolare ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, fino alla formazione permanente che consente ad ogni battezzato di essere sempre pronto «a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza» (1 Pt 3,15). Il Catechista è nello stesso tempo testimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo che istruisce a nome della Chiesa. Un’identità che solo mediante la preghiera, lo studio e la partecipazione diretta alla vita della comunità può svilupparsi con coerenza e responsabilità (cfr Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Direttorio per la Catechesi, 113).
7. Con lungimiranza, San Paolo VI emanò la Lettera apostolica Ministeria quaedam con l’intento non solo di adattare al cambiato momento storico il ministero del Lettore e dell’Accolito (cfr Lett. ap. Spiritus Domini), ma anche di sollecitare le Conferenze Episcopali perché si facessero promotrici per altri ministeri tra cui quello di Catechista: “Oltre questi uffici comuni della Chiesa Latina, nulla impedisce che le Conferenze Episcopali ne chiedano altri alla Sede Apostolica, se ne giudicheranno, per particolari motivi, la istituzione necessaria o molto utile nella propria regione. Di questo genere sono, ad esempio, gli uffici di Ostiario, di Esorcista e di Catechista”. Lo stesso invito pressante ritornò nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi quando, chiedendo di saper leggere le esigenze attuali della comunità cristiana in fedele continuità con le origini, esortava a trovare nuove forme ministeriali per una rinnovata pastorale: «Tali ministeri, nuovi in apparenza ma molto legati ad esperienze vissute dalla Chiesa nel corso della sua esistenza, - per esempio quelli di Catechista... sono preziosi per la «plantatio», la vita e la crescita della Chiesa e per una capacità di irradiazione intorno a se stessa e verso coloro che sono lontani» (San Paolo VI, Esort. Ap. Evangelii nuntiandi, 73).
Non si può negare, dunque, che «è cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della fede» (Evangelii gaudium, 102). Ne consegue che ricevere un ministero laicale come quello di Catechista imprime un’accentuazione maggiore all’impegno missionario tipico di ciascun battezzato che si deve svolgere comunque in forma pienamente secolare senza cadere in alcuna espressione di clericalizzazione.
8. Questo ministero possiede una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Vescovo e si evidenzia con il Rito di istituzione. Esso, infatti, è un servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate dall’Ordinario del luogo, ma svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero. È bene che al ministero istituito di Catechista siano chiamati uomini e donne di profonda fede e maturità umana, che abbiano un’attiva partecipazione alla vita della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza, generosità e vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teologica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della verità della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di catechesi (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 14; CIC can. 231 §1; CCEO can. 409 §1). È richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, disponibili a esercitare il ministero dove fosse necessario, e animati da vero entusiasmo apostolico.
Pertanto, dopo aver ponderato ogni aspetto, in forza dell’autorità apostolica
istituisco
il ministero laicale di Catechista
La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti provvederà entro breve tempo a pubblicare il Rito di Istituzione del ministero laicale di Catechista.
9. Invito, dunque, le Conferenze Episcopali a rendere fattivo il ministero di Catechista, stabilendo l’iter formativo necessario e i criteri normativi per potervi accedere, trovando le forme più coerenti per il servizio che costoro saranno chiamati a svolgere conformemente a quanto espresso da questa Lettera apostolica.
10. I Sinodi delle Chiese Orientali o le Assemblee dei Gerarchi potranno recepire quanto qui stabilito per le rispettive Chiese sui juris, in base al proprio diritto particolare.
11. I Pastori non cessino di fare propria l’esortazione dei Padri conciliari quando ricordavano: «Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune» (Lumen Gentium, 30). Il discernimento dei doni che lo Spirito Santo non fa mai mancare alla sua Chiesa sia per loro il sostegno dovuto per rendere fattivo il ministero di Catechista per la crescita della propria comunità.
Quanto stabilito con questa Lettera apostolica in forma di “Motu proprio”, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore nello stesso giorno, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 10 maggio dell’anno 2021, Memoria liturgica di San Giovanni d’Avila, presbitero e dottore della Chiesa, nono del mio pontificato.
Francesco
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- UN CHIARIMENTO DI GIOVANNI PAOLO II SULLA "PORTA DELLA FEDE" DI RATZINGER-BENEDETTO XVI14 agosto 2012, di Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" --- "DIO E’ VALORE": LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA.12 agosto 2012, di Federico La Sala
 Nuovo ordine mondiale: "Dio è valore" ("Deus caritas est"). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
Nuovo ordine mondiale: "Dio è valore" ("Deus caritas est"). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
 CATTOLICESIMO (E CRISTIANESIMO) OGGI, 2012: LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
CATTOLICESIMO (E CRISTIANESIMO) OGGI, 2012: LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- IL PAPA SBAGLIA ANCHE SUL “PRO MULTIS”. Per una moltitudine. Sulla traduzione delle parole eucaristiche, un libro scritto da Francesco Pieri.27 luglio 2012, di Federico La Sala
SUL “PRO MULTIS” IL PAPA SBAGLIA». IL TEOLOGO SCRIVE, L’EDITORE CATTOLICO PUBBLICA, I VESCOVI LEGGONO
di Adista Notizie n. 29 del 28/07/2012
36800. BOLOGNA-ADISTA. Un libro pubblicato da una casa editrice cattolica che critica apertamente una decisione del papa è di per sé già una notizia. Lo è ancora di più se quel libro ha la prefazione di un noto teologo. Ma se, come in questo caso, il libro è stato addirittura inviato in copia saggio a tutti i vescovi italiani, la notizia allora è davvero sorprendente. Ma assolutamente vera.
Il caso è quello di un saggio già apparso in una versione più breve su Il Regno Attualità (10/2012), per essere poi pubblicato in volume, dopo essere stato riveduto ed ampliato. Si tratta di Per una moltitudine. Sulla traduzione delle parole eucaristiche, un libro scritto da Francesco Pieri, docente di Greco biblico e Patrologia alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, presentato da Severino Dianich, già presidente dell’Associazione Teologica Italiana, e pubblicato dalla casa editrice Dehoniana Libri (che appartiene alla galassia editoriale dei religiosi dehoniani ma non va confusa con Edb, le Edizioni Dehoniane di Bologna).
Nel libro (Dehoniana Libri, 2012, pp. 48, 4,50), Pieri sostiene l’inopportunità della traduzione «il calice del mio sangue versato per molti» (invece che «per tutti»), voluta da Benedetto XVI attraverso la Pontificia Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (la quale a sua volta ne ha informato i presidenti delle diverse Conferenze episcopali nazionali in una lettera datata 17 ottobre 2006). La formula in latino, presente nel Missale Romanum, unico per tutte le nazioni e su cui si basano le traduzioni autorizzate nelle lingue nazionali, è: «Accipite et bibite ex eo omnes: / hic est enim calix sanguinis mei / novi et aeterni testamenti: / qui pro vobis et pro multis effundetur / in remissionem peccatorum. / Hoc facite in meam commemorationem».
L’espressione pro multis dopo il Concilio fu tradotta in italiano con la formula “per tutti” e nella maggior parte delle altre lingue in modo analogo: in tedesco für alle, in inglese for all, in spagnolo por todos los hombres, in francese pour la multitude. Dietro le questioni linguistiche, quella, di enorme rilevanza teologica e pastorale, dell’universalità del messaggio e della testimonianza di Gesù. Per questa ragione, nel corso degli anni più recenti, molte sono state le resistenze delle Conferenze episcopali nazionali a recepire la decisione del Vaticano. E diversi vescovi e consigli presbiterali hanno contestato apertamente l’ordine di Roma. Evitando di conformarvisi.
Anche in Italia, nonostante un episcopato molto moderato ed allineato ai vertici ecclesiastici, la Cei stenta ad adeguarsi e, come ha recentemente raccontato Sandro Magister sull’Espresso, nel novembre del 2010, nel corso della loro Assemblea Generale, soltanto 11 dei 187 vescovi presenti votarono in favore della formula «per molti».
Inoltre, come spiega Pieri nel suo libro, la decisione di Ratzinger lascia perplessi anche nel metodo, oltre che nel merito. Il Concilio ha riconosciuto alle «autorità ecclesiastiche territoriali» la competenza circa la traduzione e l’adattamento dei testi liturgici, che la Santa Sede ha poi il compito di approvare e promuovere, dopo aver fatto eventuali osservazioni e correzioni. Questo papa ha invece scelto il percorso inverso, come del resto ha fatto su molte altre questioni (e Wojtyla prima di lui), quello che va dal centro alla periferia, minando così quella «reciprocità tra primato della sede romana e collegialità dei vescovi posti a capo delle Chiese» che pure era un assunto del Vaticano II.
Nel merito, l’autore rileva inoltre come non esista un testo biblico nel quale sia presente la formula «pro vobis et pro multis»: per questo, scrive, «le due espressioni sono da considerarsi come sostanzialmente equivalenti, nei rispettivi contesti, e non è esegeticamente corretto contrapporle».
Del resto, rileva ancora Pieri, è evidente che l’espressione «per molti» suona diversamente alle nostre orecchie rispetto all’intenzione di Marco e Matteo: «“Molti” si oppone in italiano sia a “pochi” che a “tutti”»; quindi in diverse frasi la parola “molti” può di fatto equivalere sia a “non pochi”, sia a “non tutti”. L’autore cita a supporto della sua tesi il biblista Albert Vanhoye, il quale spiega che «la parola ebraica rabbim significa soltanto che c’è di fatto “un grande numero”, senza specificare se esso corrisponda o meno alla totalità».
E allora, come tradurre efficacemente? Una soluzione secondo Pieri c’è, ed avrebbe il pregio di salvare “capra” (cioè una maggiore fedeltà nella traduzione), e “cavoli” (ossia cercare di non tradire il senso profondo delle parole di Gesù): «Essa è rappresentata dalla felicissima traduzione del Messale francese “pour la multitude”, che potrebbe senza molte difficoltà essere tradotta in italiano e probabilmente anche nelle altre lingue romanze con la formula “per la moltitudine” o “per una moltitudine”. Con il vantaggio evidente che, proprio come rabbim, “moltitudine” si oppone a “pochi”, ma non si oppone a “tutti”, e lascia aperta l’interpretazione in tal senso. Accogliere tale traduzione nella liturgia della Chiesa italiana offrirebbe un reale aiuto a una corretta comprensione del testo e insieme un esempio d’intelligente ricezione delle disposizioni vaticane, in grado di fungere da modello anche ad altre Chiese particolari». (valerio gigante)
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- MENZOGNA E ABUSO DI POTERE. La bomba americana (Jérôme Anciberro - "temoignag-echretien")7 luglio 2012, di Federico La Sala
La bomba americana
di Jérôme Anciberro
 in “www.temoignagechretien.fr” del 6 luglio 2012 (traduzione: www.finesettimana.org)
in “www.temoignagechretien.fr” del 6 luglio 2012 (traduzione: www.finesettimana.org)Il Vaticano e la principale organizzazione di religiose cattoliche americana hanno iniziato un braccio di ferro, il cui esito potrebbe avere gravi conseguenze sulla vita religiosa. Tra i temi che Mons. Müller, il nuovo prefetto della Congregazione per la dottrina della fede (CGF) si troverà a trattare prioritariamente, quello della Leadership Conference of Women Religious (Conferenza delle religiose americane, LCWR), non è stata oggetto di grande attenzione da parte della stampa europea.
È l’esatto contrario di quanto avvenuto oltre Atlantico, dove i principali media, da CBS al New York Times, hanno ampiamente informato su un avvenimento che minaccia di far esplodere una gran parte della vita religiosa cattolica americana.
accuse infondate e un processo non trasparente
La LCWR, che conta circa 1500 membri che rappresentano circa l’80% delle 55 000 religiose cattoliche americane, si trova oggi in una situazione pericolosa derivante da un doppio controllo romano, condotto, da un lato, da parte della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (CIVCSVA) su tutti gli istituti religiosi femminili americani non di clausura e, dall’altro lato, dalla CDF, che ha fatto una “valutazione” dottrinale specifica della LCWR.
Dire che questa valutazione è stata accolta male, è poco: in un comunicato del 1° giugno, l’ufficio esecutivo della LCWR dichiarava che era stata avviata sulla base “di accuse infondate e di un processo imperfetto, non trasparente”. Il rapporto della CDF, precisa la LCWR, sarebbe stato inoltre “causa di sandalo e di dolore in tutte la comunità ecclesiale” e avrebbe accentuato “la polarizzazione” tra cattolici di sensibilità diverse.
Effettivamente, e contrariamente a molte azioni condotte dalla CDF, il grande pubblico americano - cattolico e non solo - ha reagito in maniera forte alla messa in discussione della LCWR. Il 12 giugno, le responsabili della LCWR hanno incontrato a Roma il cardinal Levada, prefetto della CDF a cui ora è succeduto Mons. Müller. In base ai comunicati dell’una e dell’altra parte, i dialoghi sono stati completi e diretti, ma difficili.
In un’intervista concessa al National Catholic Reporter, il cardinal Levada non ha esitato a parlare di un “dialogo tra sordi”, non escludendo una “decertificazione” canonica se le suore non si sottomettessero alle richieste del Vaticano (riscrittura degli statuti della LCWR, controllo prioritario degli interventi pubblici...).
dottrina cattolica
La LCWR è conosciuta per le sue posizioni aperte, sia in ambito sociale che nel suo rapporto con l’evoluzione dei costumi. La CDF le rimprovera di lasciare la parola, durante le sue assemblee annuali, a persone che intervengono esprimendo idee in contrasto con la dottrina cattolica, in particolare sulle questioni di morale sessuale (contraccezione, omosessualità), ma anche sulla questione dei ministeri.
La cosa non è nuova: nel 1979, la presidente della LCWR aveva già chiesto, in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II negli Stati Uniti, che le donne fossero considerate idonee a tutti i ministeri nella Chiesa.
Ogni anno, la LCWR assegna un premio ad una religiosa, il cui impegno riflette quello della LCWR in maniera particolarmente marcata. L’ultima “neo-laureata”, Carol Keehan, Figlia della Carità e presidente della Catholic Health Association (associazione cattolica per la salute), a cui sono associati circa 650 ospedali americani, si è risolutamente impegnata a favore della riforma dell’assicurazione sanitaria sostenuta da Barack Obama, mettendosi così in posizione diversa rispetto a quella dell’episcopato americano.
La LCWR è l’associazione ampiamente maggioritaria delle religiose americane, ma non è l’unica. Certe congregazioni sono affiliate al Council of Mayor Superiors of Women Religious (CMSWR), nata da una scissione della LCWR risalente agli anni ’90. Secondo vari studi, l’età media alla CMSWR, più tradizionale, sarebbe molto più bassa rispetto a quella constatata alla LCWR.
È quindi sulla base di un rinnovamento generazionale ed ideologico a rovescio - in quanto le più giovani sono le più legate ad una visione gerarchica e molto inquadrata della vita religiosa - che si svolge questo braccio di ferro, di cui si conoscerà l’esito solo in agosto, durante la riunione generale annuale della LCWR che dovrebbe allora far conoscere la sua risposta alle richieste del Vaticano
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- Dopo sette anni di pontificato, e i numerosi casi di incomprensione tra il papa e il mondo, i "paradossi di un fine pontificato" (di Stéphanie Le Bars - “Le Monde”)19 giugno 2012, di Federico La Sala
- CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Benedetto XVI, il papa teologo, ha gettato via la "pietra" ("charitas") su cui posava l’intera Costruzione...
 IL PAPATO DI BENEDETTO XVI: SETTE ANNI DI OFFESE ALLA CHIESA E ALL’ITALIA. Una nota su un incontro del 2005 e sugli eventi successivi, fino ad oggi
IL PAPATO DI BENEDETTO XVI: SETTE ANNI DI OFFESE ALLA CHIESA E ALL’ITALIA. Una nota su un incontro del 2005 e sugli eventi successivi, fino ad oggi
Paradossi di una fine di pontificato
di Stéphanie Le Bars
in “Le Monde” del 16 giugno 2012 (traduzione: www.finesettimana.org)
Furti, macchinazioni, complotti, tradimenti, minacce: il Vaticano ha forse fatto in queste ultime settimane un salto indietro di secoli? Sembra perfino che la morte si aggiri nei vicoli lastricati di Roma, se si deve credere all’ex presidente della banca del Vaticano: congedato in fretta dal suo incarico, il 23 maggio, Ettore Gotti Tedeschi ha assicurato poco dopo di “temere per la sua vita”. Nemmeno un anno, o quasi, di pontificato di Benedetto XVI, è stato risparmiato da scandali e rivelazioni che hanno dato una coloritura “noir” ai metodi di governo di alcuni gerarchi della “Chiesa universale”. Iniziato nel 2005 come regno di transizione di un papa anziano e poco intraprendente, questo pontificato sconfina, per certi aspetti, nel tragico.
Dopo gli scandali di pedofilia e i numerosi casi di incomprensione tra il papa e il mondo, ora i Vatileaks, queste pubblicazioni di lettere confidenziali sulla stampa, delineano dei contorni di una fine regno paradossale. Benedetto XVI sembra come superato dalla vastità dei cantieri che lui stesso ha dovuto aprire, suo malgrado. E non è certo che l’energia e il tempo che gli restano gli bastino per rimettere ordine nella curia, per ristabilire la fiducia e restaurare un’immagine appannata.
Eppure Benedetto XVI sapeva che cosa doveva aspettarsi. Poco prima della sua elezione, il cardinale Ratzinger aveva fatto una diagnosi terribile. “Spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da tutte le parti. E anche nel tuo campo di grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il volto così sporchi della tua Chiesa ci sgomentano. Ma siamo noi stessi a sporcarli!”, aveva affermato durante la Via Crucis nel 2005. Ahimè! La politica di “trasparenza e di purificazione”, rivendicata da allora dal papa in materia finanziaria o sul problema della morale del clero, si scontra con le resistenze all’interno della curia e negli episcopati. Certo, affinché che “la barca” trovasse acque meno torbide, sarebbe stato necessario un papa politico, esperto nell’amministrazione degli uomini e in grado di sventare gli intrighi vaticani, un’arte italiana nella quale eccellono i membri della curia. Benedetto XVI è l’esatto contrario. Prima di tutto teologo, ha fatto una scelta diversa. Con una costanza che suscita l’ammirazione dei suoi sostenitori ma spiega in parte le disavventure del pontificato, l’ottuagenario ha preferito dedicare le sue forze alla restaurazione di una fede cattolica che considera in pericolo.
Costantemente, quindi, il papa invita i credenti a ritrovare “la lettura della parola di Dio”, a ritornare “al sacro”, a difendere posizioni “non negoziabili” in materia di morale, a mostrarsi fedeli alla “tradizione della Chiesa”, al punto da fare promesse agli integralisti contrari alla modernità... Questa strategia è adatta al “nocciolo duro” dei credenti. Ma non per una gestione politica e umana della Chiesa, tale da renderla più efficiente e seducente.
Così, dopo sette anni di pontificato, le riforme in materia di trasparenza e di governance, che il suo predecessore Giovanni Paolo II non aveva saputo né voluto intraprendere, restano incompiute. Dovendo affrontare scandali ricorrenti nel funzionamento dell’Istituto delle Opere di Religione (IOR), il Vaticano è stato spinto dagli organismi europei a mettere la sua banca in regola con le norme internazionali di lotta al riciclaggio di denaro sporco, per avere la possibilità di essere inserito nella “white list” dei paesi virtuosi. Le recenti fughe di documenti e la destituzione a sorpresa di Gotti Tedeschi fanno pensare che non tutti condividano l’opinione del papa e/o i metodi impiegati.
Lo scandalo Vatileaks ha messo in luce ciò che molti osservatori avevano già notato: una polarizzazione sulla persona del cardinal Bertone, numero due del Vaticano e fedele a Benedetto XVI, alimentata dall’importanza crescente dei suoi amici italiani negli affari della curia e nelle poste in gioco della successione. Se dovesse essere fatto oggi un conclave, gli italiani sarebbero presenti con 30 elettori su 125.
Questa situazione rende difficile per il Vaticano l’uscita dal suo italocentrismo, nel momento in cui la mondializzazione e le sfide che si presentano alla Chiesa (scristianizzazione da un lato, corruzione dall’altro, concorrenza, altrove, con il protestantesimo o con l’islam...) esigerebbero uno sguardo plurale, collegiale e nuovo sulle situazioni dell’istituzione. Ma la Chiesa resta segnata da un centralismo mortifero; il papa e le persone a lui vicine si muovono in un universo da “ancien régime”, in cui vige una “benevolenza fraterna”, dove i cattivi soggetti vengono spostati senza essere mai, o quasi mai, sanzionati. Al contempo, una parte dei fedeli e del clero hanno fatto proprie le esigenze di trasparenza, di individualismo, di democrazia, di concertazione delle società moderne e del loro funzionamento attraverso le reti.
Non avendo tenuto conto di queste nuove realtà, certe decisioni prese a Roma vengono contestate in Germania, negli Stati Uniti o in Giappone. Ci sono credenti fanno enormi sforzi per restare “cattolici”, ma il “cattolicesimo romano” verticale e onnipotente non sta più loro bene. Perfino dei preti arrivano a definirsi ufficialmente “disobbedienti”. Nel momento in cui occorrerà fare un bilancio, la “Chiesa universale” che sarà lasciata in eredità da Benedetto XVI al suo successore potrebbe rivelarsi addirittura più fragile e frammentata che non profondamente “purificata” e rinnovata.
- CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Benedetto XVI, il papa teologo, ha gettato via la "pietra" ("charitas") su cui posava l’intera Costruzione...
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE... "DEUS CARITAS EST" ---- La crisi del Vaticano II: pesa la collegialità mancata (di Alberto Melloni)17 giugno 2012, di Federico La Sala
- VATICANO: CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Benedetto XVI, il papa teologo, ha gettato via la "pietra" ("charitas") su cui posava l’intera Costruzione.
 OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI PAPA RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006).
OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI PAPA RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006).
La crisi del Vaticano II: pesa la collegialità mancata
di Alberto Melloni (Corriere della Sera - La Lettura, 17 giugno 2012)
Il Vaticano II non ha tratto grandi benefici dalla stagione nella quale andava di moda. Le sue intuizioni più profonde sono spesso state banalizzate, le sue esigenze più imperative disattese. Adesso il vento dei vezzi ha girato e quelli che si vergognavano di non capirlo, o che osavano dare alle proprie pigrizie spirituali il venerando nome di Tradizione, fanno sogni impossibili. Questa galassia, alla quale Benedetto XVI ha regalato molti gesti di indulgenza, anziché accontentarsi e ringraziare, si è montata la testa.
Alcuni di loro, come padre Gherardini, supplicano da tempo un declassamento del Vaticano II a concilio adogmatico: così da liberarsi di quelle decisioni che hanno ridisegnato il volto ecumenico, interreligioso e eucaristico della Chiesa. E trovano talora sostegno inatteso in una storiografia che sente ormai di aver le prove che il Concilio si è svolto dopo la metà del secolo XX, quasi di sicuro all’inizio degli anni Sessanta, e che, testi alla mano, può dimostrare che in esso affiorano convinzioni religiose di chiara impronta cristiana...
Altri si sono ormai convinti che con poco - un altro decano o un altro segretario di Stato o un’altra infornata o addirittura un altro Papa - si potrebbe davvero seppellire il Concilio e saltare a un punto imprecisato del tempo, all’indietro o se mai in avanti, come se davvero l’esperienza fondamentale del cristianesimo fosse cruda materia, pensabile fuori da una storia. Ma al di là delle mode il Vaticano II rimane al centro della vita cristiana e della Chiesa cattolica, nelle sue decisioni cruciali sulla liturgia, la rivelazione, il ministero, la pneumatologia, la libertà, l’alleanza di Israele, l’alterità, la povertà.
Certo, ci sono decisioni che gli furono sottratte, e che si rischia talora di leggere come lacune. Paolo VI, com’è noto, ritenne che c’erano temi talmente delicati e complessi che il Papa li avrebbe risolti meglio da solo che non con un’assemblea: la guerra nell’era della deterrenza nucleare, il celibato ecclesiastico, la riforma della Curia romana, la contraccezione, la pratica della collegialità episcopale. Nodi che hanno isolato, tormentato, e alla fine schiacciato papa Montini. Giovanni Paolo II li ha letteralmente «sorvolati» col suo stile di non-governo. E sono rimasti lontani dall’agenda di Benedetto XVI.
A partire da quello più «latino» e più istituzionale di tutti che è la forma del governo ecclesiale. I1 Vaticano II, infatti, indicò la via della collegialità - che non è una specie di «democrazia», ma la conseguenza di un modo di vedere la Chiesa universale e le Chiese particolari in un dinamismo di comunione che nasce dal sacramento episcopale e non da una concessione del Papa o da un diritto dal basso.
Quella indicazione non è stata ubbidita: né nelle riforme della curia, né in quella del Codice di diritto canonico e neppure quando una enciclica wojtyliana - Ut unum sint - pose la questione della fisionomia del ministero petrino.
Ma se il Vaticano II non ha voluto costringere, non è stato per debolezza e nemmeno perché ignorava che la nostra storia sarebbe stata rapida: è stato il suo stesso modo d’essere e la convinzione che a esso toccasse iniziare, dare responsabilità. Che con quell’inizio e responsabilità ci si misuri malvolentieri non è colpa del Concilio, ma di chi esita.
- VATICANO: CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Benedetto XVI, il papa teologo, ha gettato via la "pietra" ("charitas") su cui posava l’intera Costruzione.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA ---- Il Vaticano e la teologia delle sorelle (di Massimo Faggioli)7 giugno 2012, di Federico La Sala
Il Vaticano e la teologia delle sorelle
di Massimo Faggioli (Europa, 6 giugno 2012)
Durante e nonostante lo scandalo delle divisioni interne alla Curia romana ormai noto come “VatiLeaks”, proseguono i richiami del magistero della Chiesa rivolti contro teologhe e teologi cattolici. Due giorni fa è toccato a suor Margaret A. Farley, docente alla Divinity School della Yale University, ricevere da Roma una notifica (datata 30 marzo 2012) riguardo il suo recente libro, Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics. Le critiche riguardano la trattazione di questioni come la masturbazione, gli atti omosessuali, le unioni omosessuali e il matrimonio.
In questi ambiti suor Farley presenta dei casi in cui, sulla base di una morale esperienziale e non dottrinale, si difende la moralità di pratiche rigettate dalla morale sessuale ufficiale della Chiesa. La notifica viene non dai vescovi americani, ma dalla Congregazione per la dottrina della fede che attualmente è guidata da un cardinale americano, William Levada. Il libro viene accusato di insegnare in materia morale principi significativamente differenti da quelli insegnati dal papa e dei vescovi, e quindi di provocare confusione tra i fedeli. Il libro di conseguenza «non può essere usato come valida espressione della dottrina cattolica».
Nella sua risposta, Farley ha «ringraziato la Congregazione» per l’attenzione ricevuta e non ha smentito il fatto che il libro contenga opinioni che non sono in accordo con l’insegnamento ufficiale della Chiesa, ma ha anche puntualizzato che il libro è inteso ad offrire non una dottrina cattolica alternativa, ma «un’interpretazione contemporanea di significati tradizionali che sono rilevanti per il corpo umano, la differenza di genere e la sessualità».
Come accade di consueto, i teologi americani si sono schierati in difesa del libro sotto accusa, che al momento della pubblicazione nel 2006 venne accolto da recensioni molto positive. Una delle teologhe moraliste più importanti, Lisa Cahill del Boston College, ha affermato che una delle questioni-chiave del libro è la violenza contro le donne e le sue conseguenze per la teologia morale cattolica - una questione che non viene menzionata nel giudizio della Congregazione, che invece accorda grande importanza alla moralità della masturbazione.
Anche l’ordine religioso a cui appartiene suor Farley, quello delle “Sisters of Mercy of the Americas”, ha espresso il suo sostegno all’autrice del libro, docente a Yale dal 1971, pluripremiata e celebre a livello mondiale non come esperta di morale sessuale bensì di bioetica ed etica medica.
Agli occhi dei cattolici americani, infatti, è chiaro lo schema di azione della gerarchia verso la teologia americana e in particolare contro le teologhe. Risale al 2010 l’inizio delle tensioni tra i vescovi americani e le religiose circa la riforma sanitaria dell’amministrazione Obama, che le religiose hanno appoggiato per il tentativo di estendere la copertura sanitaria a quasi tutti quelli attualmente senza accesso alle cure mediche.
È dell’autunno 2011, poi, lo scontro tra la conferenza episcopale americana e la docente di teologia di Fordham University, Elizabeth Johnson circa il suo libro, Quest for the Living God. Nel maggio 2012 si è infine avuta notizia dell’indagine aperta dai vescovi americani sulle Girl Scouts (che negli Stati Uniti sono separate dai Boy Scouts of America e politicamente molto più liberal e socialmente più impegnate) per i legami che le Girl Scouts hanno con organizzazioni che promuovono la contraccezione e la salute sessuale delle donne.
È una spaccatura grave e crescente quella tra il Vaticano e i vescovi da una parte, e la teologia americana dall’altra: si tenta di ironizzare apprezzando il fatto che immediatamente, qualche ora dopo la pubblicazione di queste “condanne” vaticane, i libri presi di mira scalano le classifiche di vendita. Nel caso di Farley, i proventi andranno al suo ordine religioso, anch’esso nel mirino del Vaticano per i provvedimenti annunciati due mesi fa contro la Lcwr, la più grande federazione degli ordini religiosi femminili degli Stati Uniti.
-
> E’ ORA CHE TORNI A CASA --- Benedetto XVI ha già detto che non si dimetterà mai per paura. Ma le tensioni possono logorarlo ulteriormente (di MArco Politi - Il Papa debole ha deluso la vecchia guardia) .29 maggio 2012, di Federico La Sala
Il Papa debole ha deluso la vecchia guardia
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 29 maggio 2012)
In un groviglio di veleni, tradimenti e scontri sotterranei si avvia al tramonto il pontificato di Benedetto XVI. Perché di questo si tratta. Per la prima volta ci si chiede davvero in Vaticano se è stato giusto eleggerlo. Mai era accaduto che in piazza San Pietro risuonasse il grido “vergogna, vergogna”, lanciato domenica dai dimostranti per Emanuela Orlandi. Mai la tiara papale era stata disegnata, in una vignetta, quale gabbia di lugubri corvi. Mai si era visto in tempi moderni un traditore annidato nel suo appartamento. Non si era mai sentito a Roma, al centro dell’impero cattolico, che uno dei più sfrenati fautori di Ratzinger lo bollasse come “professore tra le nuvole” e ne chiedesse le dimissioni. Segno che Giuliano Ferrara fiuta il vento.
Il Papa impolitico, come lo definì il sociologo cattolico Franco Garelli, assiste impotente alla rivolta di una parte della Curia contro il suo Segretario di Stato ed è costretto a incassare ogni giorno un’ondata mediatica negativa, che finisce per lambire il suo ruolo di pontefice.
La divisione di funzioni che Benedetto XVI sembrava vagheggiare all’inizio del suo pontificato - riservando a sé la missione di predicare e ispirare teologicamente i fedeli e lasciando al suo stretto collaboratore Bertone il compito di gestire la macchina curiale - è entrata irrimediabilmente in crisi. Perché un’organizzazione di oltre un miliardo di aderenti come la Chiesa cattolica ha comunque bisogno di un leader dotato di polso geopolitico: e non è nel temperamento di Ratzinger. Di qui le crisi a catena. Con l’Islam, con l’Ebraismo, con il mondo della scienza a proposito dell’Aids e del preservativo, con il mondo cattolico a causa dei ripetuti cedimenti al movimento anti-conciliare di Lefebvfre. Di qui la stasi generale sul fronte dell’ecumenismo.
Assieme alla conclamata sfiducia di Ratzinger nelle riforme strutturali, questa assenza di leadership sta portando alla generale inerzia della Chiesa dinanzi al fenomeno planetario della mancanza di parroci nelle parrocchie e al crollo delle vocazioni negli ordini religiosi femminili. L’accumularsi dei problemi irrisolti rende i problemi sempre più incancreniti. E la situazione è aggravata dal fatto che accanto al pontefice non funziona nessun organo collegiale, nessuna camera di compensazione di analisi, idee, proposte: fosse almeno il collegio cardinalizio.
La deriva odierna (che preoccupa gli ambienti del cattolicesimo italiano e mondiale più fedeli all’istituzione) e l’immagine di caos vaticano che si sta diffondendo sono prodotti di questa assenza di leadership. Mentre il Papa via via rinunciava al contatto diretto e sistematico con i nunzi e i vescovi (a causa della stanchezza li vede solo collettivamente), il Segretario di Stato diventava sempre più accentratore e intollerante verso posizioni diverse dalle sue. Fino al punto da esigere che i cardinali debbano passare attraverso di lui, se vogliono parlare con il pontefice. Il nocciolo dei conflitti sotterranei, deflagrati nella diffusione di documenti segreti all’esterno, si ritrova nell’intreccio tra soldi e potere e sempre lì riappare la figura del cardinale Bertone . Nello scontro con il cardinale Tettamanzi per la presidenza dell’Istituto Toniolo. Nella cacciata di mons. Viganò. Nei conflitti con il cardinale Nicora per la trasparenza dello Ior. Nello scontro sotterraneo con Gotti Tedeschi per le manovre avventurose intorno al San Raffaele.
Un’assenza di leadership si svela paradossalmente anche nella caccia agli autori di Vatileaks, scatenata in queste settimane. Né il Papa né il suo Segretario di Stato sembrano rendersi conto che anche la repressione deve ubbidire a un disegno di governo. La gendarmeria perquisisce e arresta, la commissione cardinalizia interroga: ma con quale obiettivo? Per colpire la piccola manovalanza? Per bloccare le domande scomode che nascono dai documenti stessi? I dissidenti clandestini (che sono ben altro che folcloristici corvi...) hanno portato alla luce del “marcio”. Lo dicono e lo ripetono.
L’impressione, che si sta diffondendo, è che l’azione repressiva nei loro confronti serva per mettere un coperchio e non per ripulire le stanze vaticane dalla sporcizia affaristico-finanziaria, come vorrebbe idealmente Benedetto XVI quando delinea il ritratto puro dei “servitori della Chiesa”. Non sarà la testa di Paolo Gabriele a risollevare le sorti del pontificato. Anzi, i futuri processi sono destinati a disseminare altre rivelazioni esplosive. E ancor più devastanti sarebbero “interrogatori” di prelati e cardinali.
Gotti Tedeschi sta già meditando di chiedere una commissione d’inchiesta sul suo operato per sbugiardare il rozzo comunicato sul suo licenziamento. Un’indagine sulla corruzione negli appalti la potrebbero esigere anche i fautori di mons. Viganò.
E se un guerrigliero del fax “imputato” chiederà domani un giurì d’onore per stabilire chi ha ragione tra Dino Boffo ex direttore dell’Avvenire e Giovanni Maria Vian, direttore dell’Osservatore Romano (accusato da Boffo in una lettera al segretario papale di aver orchestrato ai suoi danni la campagna diffamatoria di Feltri) ?
A ogni passo si aprirà un abisso. Chi osserva le mosse di questa dura lotta per rovesciare il Segretario di Stato, nota che Bertone non fronteggia un’unica fazione.
Molti gruppi in Curia sono scontenti della sua gestione. Cardinali come Sodano e Re non condividono l’improvvisazione del suo governo. Personalità come Piacenza credono ci voglia più efficienza. Molti cardinali stranieri guardano esterrefatti alla perdita dello stile di potere soft, che ha sempre caratterizzato la Santa Sede. E tutti - bertoniani e oppositori, i critici e il partito dei neutrali scontenti - proclamano la loro fedeltà al pontefice e il desiderio di salvaguardare la Chiesa. Ecco perché senza una visione di governo la gogna di possibili “colpevoli” non farà che aumentare la disgregazione. Benedetto XVI ha già detto che non si dimetterà mai per paura. Ma le tensioni possono logorarlo ulteriormente.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- LA PAROLA INCOMPRESA (di Gianfranco Ravasi)21 maggio 2012, di Federico La Sala
- EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
 KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
La parola incompresadi Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore - Domenica, 20 maggio 2012)
La critica a un’informazione spesso approssimativa, superficiale, prevenuta e fin ostile per ragioni di principio, non deve quindi esimere la comunità ecclesiale da una ferma autocritica nei confronti dei propri limiti. Le evidenti incomprensioni che allignano nella società non devono produrre un rassegnato vittimismo e neppure un’altezzosa noncuranza del fenomeno. Anche se l’odierna esasperazione della comunicazione, la sua accelerazione ed estensione costituiscono una novità, nella sua sostanza, un fenomeno costante che risale alle origini stesse della cristianità. Quella che appare ai nostri occhi come la primavera della Chiesa (e che per molti versi lo era) fu una stagione tutt’altro che idilliaca, sottoposta a gelate, a tempeste, a devastazioni. E questo non solo a livello di vita ecclesiale: emblematiche sono le divisioni accese che frantumavano la Chiesa di Corinto, fieramente denunciate da san Paolo (1 Corinzi 1, 10-16).
La crisi si manifestava anche a livello di comunicazione, e l’apostolo lo conferma a più riprese puntando l’indice contro una serie di deviazioni dottrinali e morali che si ramificavano attraverso l’oralità, il medium allora dominante, «turbando e sovvertendo» (Galati 1, 7), «provocando divisioni e ostacoli contro l’insegnamento appreso» (Romani 16, 17), «incantando gli stolti» cristiani della Galazia (Galati 3, 1). Il fascino della stravaganza e dell’eccesso attirava già allora, al punto che san Paolo polemizza con alcune comunità cristiane nelle quali «ci si circonda di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole» (2 Timoteo 4, 3- 4). Anzi, la forza «performativa», cioè efficacemente incisiva, della comunicazione - soprattutto nei confronti delle persone più indifese - è rappresentata senza reticenze nel suo versante negativo al l’interno della stessa lettera indirizzata da san Paolo al collaboratore Timoteo: «Vi sono alcuni che entrano nelle case e circuiscono certe donnette cariche di peccati e in balia di passioni di ogni genere, sempre pronte a imparare, ma che non riescono mai a giungere alla conoscenza della verità» (3, 6-7). In quel contesto di comunicazione viziata, già allora non si esitava ad adottare la pura e semplice falsificazione a livello di massa: nella comunità cristiana di Tessalonica circolano persino
 dice l’apostolo - «alcune lettere fatte passare come nostre», tali da «confondere la mente e
allarmare» (2 Tessalonicesi 2, 2), tanto è vero che san Paolo si vede costretto ad apporre ai suoi
scritti - dettati, com’era prassi, a uno scriba - una specie di autenticazione: «Il saluto è di mia mano,
di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera; io scrivo così» (2 Tessalonicesi 3, 17);
«vedete con che grossi caratteri vi scrivo di mia mano» (Galati 6, 11). L’«adulterazione» del
messaggio secondo forme ingannevoli era una vera e propria piaga che attecchiva in varie Chiese
delle origini (2 Corinzi 4, 2). Il monito è, perciò, costante: «Fate attenzione che nessuno faccia di
voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri... Nessuno vi inganni con parole vuote» (Colossesi
2, 8; Efesini 5, 6).
dice l’apostolo - «alcune lettere fatte passare come nostre», tali da «confondere la mente e
allarmare» (2 Tessalonicesi 2, 2), tanto è vero che san Paolo si vede costretto ad apporre ai suoi
scritti - dettati, com’era prassi, a uno scriba - una specie di autenticazione: «Il saluto è di mia mano,
di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera; io scrivo così» (2 Tessalonicesi 3, 17);
«vedete con che grossi caratteri vi scrivo di mia mano» (Galati 6, 11). L’«adulterazione» del
messaggio secondo forme ingannevoli era una vera e propria piaga che attecchiva in varie Chiese
delle origini (2 Corinzi 4, 2). Il monito è, perciò, costante: «Fate attenzione che nessuno faccia di
voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri... Nessuno vi inganni con parole vuote» (Colossesi
2, 8; Efesini 5, 6).La comunicazione malata, le incomprensioni e le degenerazioni sono quindi un dato permanente e forse scontato non solo nel confronto con l’esterno, ma anche all’interno stesso della Chiesa. A questo punto vorrei apporre al nostro itinerario molto variegato, e forse anche un po’ disperso e dispersivo, una nota conclusiva, che vuole avere un sapore «controcorrente». Dopo aver trattato tanto di parole, di informazione, di comunicazione, vorrei infatti far entrare in scena l’antipodo, ossia il silenzio.
In uno dei suoi Shorts il poeta inglese Wystan H. Auden confessava: «Bisognosi anzitutto / di silenzio e di calore, / produciamo / freddo e chiasso brutali». Il filosofo Friedrich W. Nietzsche osservava che «è difficile vivere con gli uomini perché è assai difficile farli stare in silenzio». Il vaniloquio filtrato dai cellulari, il flusso incessante delle notizie, il chattare senza tregua e senza contenuti veri, ma spesso solo in una marea di fatuità e vacuità, il fiume limaccioso delle volgarità o quello fangoso delle falsità fanno venire talvolta il desiderio che, per questa società della comunicazione di massa superinflazionata, si compia quanto si annuncia nel libro dell’Apocalisse: «Si fece silenzio nel cielo per circa mezz’ora» (Apocalisse 8, 1).
È come se nell’etere risuonasse un poderoso: «Zitti!», così da bloccare ogni sproloquio per almeno mezz’ora. La parola autentica e incisiva, in verità, nasce dal silenzio, ossia dalla riflessione e dal l’interiorità, e per il fedele dalla preghiera e dalla meditazione. In mezzo al brusio incessante della comunicazione informatica, alla chiacchiera e all’immaginario televisivo e giornalistico, al rumore assordante della pubblicità, il cristiano (ma non solo) deve sempre saper ritagliare uno spazio di silenzio «bianco», che sia - come accade a questo colore che è la sintesi dello spettro cromatico - la somma di parole profonde, e che non è il mero silenzio «nero», cioè l’assenza di suono.
Il Dio dell’Oreb si svela a Elia non nelle folgori, nel vento tempestoso e nel terremoto bensì in una qôl demamah daqqah, in «una voce di silenzio sottile» (1 Re 19, 12). Anche la sapienza greca pitagorica ammoniva che «il sapiente non rompe il silenzio se non per dire qualcosa di più importante del silenzio». È solo per questa via che sboccia la parola assennata e sensata. Solo così si compie la scelta di campo sottesa a un famoso detto rabbinico: «Lo stupido dice quello che sa; il sapiente sa quello che dice».
- EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
-
> RELIGIOSE AMERICANE E VATICANO. "La Curia vaticana e papa Benedetto XVI hanno paura del significato dato dal Concilio Vaticano II a ciò che significa essere cattolico". Intervista a suor Jeannine Garmick della "Lcwr" (Usa).15 maggio 2012, di Federico La Sala
«Cristo è la vite, non il Vaticano». intervista a suor Gramick sul futuro delle religiose Usa
intervista a Suor Jeannine Gramick
a cura di Ludovica Eugenio (Adista- Notizie, n. 19, 19 maggio 2012)
La Curia vaticana e Benedetto XVI hanno paura «del significato dato dal Concilio Vaticano II a ciò che significa essere cattolico», della «libertà di espressione che esso comporta». Di conseguenza, hanno anche paura di permettere «alle voci critiche di essere ascoltate perché alcune di esse potrebbero legittimamente portare al cambiamento». Un cambiamento che, «nelle personalità autoritarie», fa temere di perdere «potere e controllo». In questa chiave, le suore statunitensi, prese di mira dal Vaticano con il commissariamento del loro organismo di coordinamento più importante, la Leadership Conference of Women Religious (Lcwr) (v. Adista Notizie nn. 16 e 17/12), risultano pericolose «perché forse sono l’ultimo gruppo organizzato a riflettere lo spirito conciliare di ciò che significa veramente essere Chiesa». È molto decisa suor Jeannine Gramick, dal 2001 componente della congregazione delle Sisters of Loretto, da sempre dedita al ministero rivolto alle minoranze sessuali e in tale ambito cofondatrice, insieme a p. Robert Nugent, dell’associazione New Ways Ministry, impegnata nella ricerca della giustizia sociale per gay e lesbiche.
Suor Gramick ha accettato di condividere con Adista le proprie opinioni e il proprio punto di vista sulla misura intrapresa di recente dal Vaticano e sul futuro della Lcwr, Di seguito, in una nostra traduzione dall’inglese, l’intervista che suor Gramick ci ha rilasciato.
 Con il Vaticano II la Chiesa, popolo di Dio, è stata chiamata ad essere più vicina al mondo. Le religiose statunitensi hanno incarnato questo appello in un’ampia varietà di ministeri, vivendo profondamente nel mondo e ascoltando le persone che, in diversi modi, si trovano in difficoltà. Ci può dire quali tipi di ministeri si sono sviluppati?
Con il Vaticano II la Chiesa, popolo di Dio, è stata chiamata ad essere più vicina al mondo. Le religiose statunitensi hanno incarnato questo appello in un’ampia varietà di ministeri, vivendo profondamente nel mondo e ascoltando le persone che, in diversi modi, si trovano in difficoltà. Ci può dire quali tipi di ministeri si sono sviluppati?Prima dell’inizio degli anni ’60, le religiose svolgevano il loro ruolo soprattutto come insegnanti nelle scuole o come infermiere o amministratrici negli ospedali. Dopo il Concilio Vaticano II, si sono impegnate in numerose nuove forme di ministero. Per esempio, in attività riguardanti la giustizia e la pace, per cambiare le politiche e le strutture nella società e nella Chiesa, a beneficio dei poveri e degli emarginati. Questo ruolo è stato portato avanti in un ministero di tipo politico che puntava sull’educazione e sulle pressioni, lavorando con i media, alla radio, alla tv e attraverso un ministero che si occupa di ecologia e di cura della terra. Molte religiose si sono messe a difendere le persone lesbiche e gay e per una partecipazione più piena delle donne in ogni forma di ministero ecclesiale, compresa l’ordinazione. Oltre al tradizionale ministero di servizio sociale, le suore hanno raggiunto i divorziati risposati, le prostitute, i detenuti, i senza fissa dimora e le donne maltrattate.
 Il Vaticano ha accolto positivamente questa vicinanza al mondo e alle persone?
Il Vaticano ha accolto positivamente questa vicinanza al mondo e alle persone?Il Vaticano non ha obiettato al fatto che le suore si facessero più vicine al mondo e alle persone, ma ha contestato le implicazioni di questa vicinanza nei ministeri non tradizionali che si occupano di politica, di sessualità o di entrambi. Per esempio, nel 1983 il Vaticano obbligò suor Agnes Mary Mansour a dare le proprie dimissioni dalla congregazione delle Sisters of Mercy a causa del suo incarico di direttore del Dipartimento dei servizi sociali del Michigan, che finanziava l’aborto per le donne povere. Nel mio caso, il Vaticano mi ha ingiunto, nel 1999, di interrompere il mio ministero pastorale rivolto ai cattolici gay e lesbiche perché avevo scelto di affermare che non condividevo la posizione tradizionale sulla moralità dell’omosessualità.
Si sono verificati numerosi casi meno noti nei quali vescovi diocesani hanno messo in pratica le posizioni vaticane. Per esempio, le religiose hanno ricevuto l’ordine di dimettersi dalla direzione di organismi che hanno a che fare con l’Hiv-Aids, perché promuovevano l’utilizzo dei condom. Alcune religiose sono state licenziate dai loro incarichi parrocchiali o diocesani perché appoggiavano l’ordinazione sacerdotale femminile.
L’attuale valutazione dottrinale della Lcwr da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede (Cdf) ne costituisce un ulteriore esempio. Le due obiezioni concrete citate dalla Cdf sono state la posizione dell’Lcwr sull’omosessualità e sull’ordinazione femminile.
 Il suo ministero ha portato la sua congregazione, quella della School Sisters of Notre Dame, ad escluderla perché lei aveva scelto di non obbedire al silenzio impostole, e nel 2001 è entrata nella congregazione delle Sisters of Loretto che, al contrario, l’hanno sostenuta nel suo ministero. Da allora ha più avuto problemi con il Vaticano?
Il suo ministero ha portato la sua congregazione, quella della School Sisters of Notre Dame, ad escluderla perché lei aveva scelto di non obbedire al silenzio impostole, e nel 2001 è entrata nella congregazione delle Sisters of Loretto che, al contrario, l’hanno sostenuta nel suo ministero. Da allora ha più avuto problemi con il Vaticano?Tra il 2001 e il 2009 il Vaticano ha mandato nove lettere alla presidente delle Sisters of Loretto riguardanti il mio ministero. In ognuna di esse, in sostanza, si affermava che dovevo interrompere il mio ministero a favore delle persone Lgbtq o sarei stata allontanata dalla vita religiosa. Le mie consorelle hanno scelto di non allontanarmi e, a questo punto, non l’ha fatto nemmeno il Vaticano.
 Dal 1956 la Lcwr rappresenta la maggioranza delle congregazioni religiose femminili statunitensi. Quali sono state le sue maggiori conquiste, attività e interessi?
Dal 1956 la Lcwr rappresenta la maggioranza delle congregazioni religiose femminili statunitensi. Quali sono state le sue maggiori conquiste, attività e interessi?La Lcwr offre una vasta gamma di attività e programmi che sono di supporto alle superiore e sono tese al rafforzamento delle relazioni tra le componenti della Lcwr con altri gruppi importanti. Tra queste attività vi è un workshop con cadenza annuale, comprensivo di un ritiro, per le nuove leader e un manuale che aiuta a sviluppare le competenze importanti per la leadership. Produce regolarmente anche materiali scritti, come una pubblicazione trimestrale sulla giustizia sociale, un volumetto di preghiera e riflessione, un diario di Occasional Papers e informazioni su giustizia e pace.
Credo che la conquista più importante dell’Lcwr sia stata quella di aver reso tutte le religiose che vi aderiscono, ma anche un pubblico più ampio, consapevoli di ogni genere di tema che implichi la giustizia. Offre riflessioni teologiche, analisi sociali e suggerimenti per l’azione su molti temi, come la giustizia economica, la difesa dei poveri, il dialogo con l’islam e interreligioso, la pena di morte, la riforma delle politiche migratorie, il cambiamento climatico e le questioni ambientali, la riforma sanitaria, gli armamenti nucleari, la testimonianza contro la tortura, la cancellazione del debito per i Paesi impoveriti, il traffico d’organi e la militarizzazione dello spazio e molti altri temi legati alla giustizia. La lista è praticamente inesauribile.
 Negli ultimi anni, le religiose sono state nel mirino del Vaticano. Oltre a singoli casi individuali, le congregazioni religiose femminili hanno subìto una visita apostolica. Lo stesso è accaduto alla Lcwr. C’è una relazione tra le due visite apostoliche? Di cosa ha paura Roma?
Negli ultimi anni, le religiose sono state nel mirino del Vaticano. Oltre a singoli casi individuali, le congregazioni religiose femminili hanno subìto una visita apostolica. Lo stesso è accaduto alla Lcwr. C’è una relazione tra le due visite apostoliche? Di cosa ha paura Roma?Non sono stata licenziata, perché la Cdf non è il mio datore di lavoro e non mi ha mai supportata finanziariamente in questo ministero. La Cdf, nel 1999, ha affermato che non avrei dovuto impegnarmi in questo ministero, ma dopo un discernimento approfondito ho concluso che Dio continuava a chiamarmi ad esso, quindi ho deciso di non cooperare con l’oppressione del silenzio. Continuo a occuparmi delle persone lesbiche e gay.
Per il resto sì, credo che ci sia un legame tra le visite alle singole congregazioni religiose e la valutazione dottrinale (o inquisizione dottrinale) dell’Lcwr, entrambe avviate all’inizio del 2009. Sono in molti a ritenere che entrambi i progetti di indagine sono stati avviati per eliminare il dissenso e spazzare via le ultime vestigia del rinnovamento portato dal Vaticano II. Nel documento che presenta il processo della visita, una delle domande poste ai leader delle comunità era: «Qual è il processo messo in atto per rispondere alle consorelle che esprimono pubblicamente o privatamente il loro dissenso dall’insegnamento autoritativo della Chiesa?».
A mio giudizio, la Curia vaticana e papa Benedetto XVI hanno paura del significato dato dal Concilio Vaticano II a ciò che significa essere cattolico. Hanno paura della libertà di espressione che esso comporta. Hanno paura di permettere alle voci critiche di essere ascoltate perché alcune di queste voci potrebbero legittimamente portare al cambiamento. Le personalità autoritarie hanno paura del cambiamento e di perdere potere e controllo. Ken Briggs, autore di Double Crossed: Uncovering the Catholic Church’s Betrayal of American Nuns (Vittime di un doppio gioco: lo svelamento del tradimento delle suore americane da parte della Chiesa cattolica, ndr), ritiene che le suore abbiano conservato più di qualsiasi altro gruppo nella Chiesa l’etica e lo spirito conciliare, nonostante una strenua opposizione da parte dei due ultimi papi. Le suore statunitensi sono pericolose perché forse sono l’ultimo gruppo organizzato a riflettere lo spirito conciliare di ciò che significa veramente essere Chiesa.
 Come vede il futuro della Lcwr, alla luce della nomina di un commissario che ne riveda gli statuti e i programmi?
Come vede il futuro della Lcwr, alla luce della nomina di un commissario che ne riveda gli statuti e i programmi?Penso che la Lcwr abbia due scelte: sottomettersi al controllo Vaticano o sciogliere la Lcwr e ricostituirla come organismo privo di legami con il Vaticano. Credo che la prima scelta rappresenterebbe un ripudio dei quarant’anni e più di rinnovamento nei quali le comunità religiose si sono impegnate. Bisogna ricordare che è stato chiesto alle religiose di rivalutare e aggiornare le loro comunità affinché rispondano alle esigenze dei tempi. Le religiose hanno preso sul serio questa richiesta e ora al Vaticano non piacciono i risultati. Il Vaticano vuole che le suore tornino alla vita religiosa del passato.
La storia ha dimostrato che la politica di appeasement (accomodamento, ndt) di Neville Chamberlain (primo ministro del Regno Unito dal 1937 al 1940, ndt) non ha soddisfatto i desideri di un dittatore come Hitler. La Chiesa istituzionale cattolica, come è attualmente, è uno stato totalitario religioso che dall’epoca del papato di Pio IX ha vissuto una sempre crescente centralizzazione. Il Concilio Vaticano II ha tentato di riportare la Chiesa sul binario di una comunità di credenti sulla via di Cristo, ma le forze curiali hanno cercato di far deragliare il rinnovamento negli ultimi 30 e più anni.
La seconda opzione, ritengo, rispetterebbe l’onore e l’integrità delle congregazioni religiose che hanno cercato, con la loro fedeltà, di tenere vivi i valori di una Chiesa come comunità di discepoli fedeli di Cristo. La ricostituzione della Lcwr come organismo che rispetta il Vaticano ma non abbandona nulla della propria autonomia rappresenterebbe un’applicazione del valore conciliare della sussidiarietà. Tale ricostituzione sarebbe un vantaggio per le religiose, ma anche per la Chiesa nel suo complesso. Essa affermerebbe la necessità di abbandonare un atteggiamento di obbedienza cieca a favore di una capacità decisionale morale adulta.
Fin da papa Pio IX, la Chiesa ha dato prova di un’atmosfera di infallibilità strisciante in forza della quale si partiva dal presupposto che ad ogni decisione, da parte di qualsiasi leader, accettata spesso come infallibile, si dovesse obbedire senza discutere. Il Vaticano II ha cercato di cambiare questo atteggiamento sottolineando la libertà di coscienza. Una ricostituzione mostrerebbe che la Chiesa consiste in molti rami radicati in Cristo, la vite. Il Vaticano è uno dei rami. Le singole diocesi, congregazioni religiose apostoliche, ordini monastici e contemplativi e movimenti laicali sono altri rami. Dobbiamo ricordarci sempre che Cristo, non il Vaticano, è la vite.
Non so per quale scelta opterà la Lcwr. Ha già cooperato con la Cdf nella sua investigazione dottrinale, quindi non so se l’organizzazione continuerà a collaborare nella sua oppressione invece di resistere alla presa di possesso da parte del Vaticano. Continuo a nutrire la speranza che i nuovi vertici della Lcwr siano più realistici nel constatare che si ha a che fare con il totalitarismo religioso e che esso rifiuterà la misura come intrusione indebita e come affronto alla natura profetica della vita religiosa.
 In che misura questo passo del Vaticano toccherà la vita, il ministero e il ruolo delle religiose nella Chiesa Usa in futuro?
In che misura questo passo del Vaticano toccherà la vita, il ministero e il ruolo delle religiose nella Chiesa Usa in futuro?L’intervento vaticano avrà effetti enormi sulla vita, il ministero e il ruolo delle religiose negli Usa e nella Chiesa mondiale. Gli effetti dipenderanno dal corso che la Lcwr sceglierà di intraprendere. Vorrei essere ottimista e credere che la decisione della Lcwr rafforzerà non solo le religiose ma la Chiesa intera. Rifiutare garbatamente di essere dominate da un sistema patriarcale che non comprende la natura comunitaria della Chiesa significherà dimostrare che un cristiano maturo non obbedisce ciecamente agli uomini, ma segue la chiamata di Dio nella preghiera. Tale scelta dirà che non c’è bisogno di persone controllori dell’ortodossia o di inquisizioni. Tale scelta dirà che Cristo, e non il Vaticano, è la vite e noi ne siamo i rami. Tale scelta dirà che lo Spirito di Dio guida la Chiesa e che sotto questa guida non abbiamo paura. Sotto questa guida abbiamo fede e fiducia. (l. e.)
-
> RELIGIOSE AMERICANE E VATICANO. ---- «CONTINUATE A SOSTENERE LE RELIGIOSE». APPELLO DI EX SUORE AI VESCOVI USA15 maggio 2012, di Federico La Sala
«CONTINUATE A SOSTENERE LE RELIGIOSE». APPELLO DI EX SUORE AI VESCOVI USA *
36679. NEW YORK-ADISTA. «Nessuno spazio per il dissenso; nessuna possibilità di prospettive diverse; nessun modo di impegnarsi nel dialogo su posizioni cattoliche tradizionali e spesso ristrette; in breve, le religiose devono tenersi le loro idee per loro e seguire semplicemente il dettato e la direzione di Roma, pena la censura, imbarazzo pubblico, atteggiamento oppressivo e persino potenziale espulsione». Dopo innumerevoli testimonianze di solidarietà e di appoggio cui hanno dato voce, negli Usa, media cattolici e laici, così inizia una lettera aperta che quindici ex suore statunitensi, capitanate da Helen Urbain-Majzler, direttora di un’istituzione sanitaria di carattere pubblico, hanno inviato ai vescovi del loro Paese - formalmente al card. Timothy Dolan, arcivescovo di New York, con preghiera di condividerla con i confratelli - riguardo all’attacco lanciato dal Vaticano alla Leadership Conference of Women Religious (Lcwr), l’organismo che riunisce i vertici dell’80% delle congregazioni religiose femminili, giudicati da Roma troppo liberal e femministe (v. Adista Notizie nn. 16 e 17/12 e notizia precedente).
Se la Lcwr ha mostrato sorpresa per il provvedimento romano, scrivono le ex-suore, tra le quali medici, psicologhe, docenti universitarie, educatrici, «donne come noi non si sono stupite. Tutte noi - ora ex religiose - abbiamo vissuto molti anni in comunità religiose e abbiamo sperimentato il trattamento crudele e punitivo delle religiose che hanno assunto posizioni coraggiose a livello pubblico per difendere i poveri, i più vulnerabili nella salute, e le vittime della società, tra cui gli omosessuali».
Il Vaticano, proseguono le ex-religiose, non ha riconosciuto i cambiamenti avvenuti nella Chiesa e nella società americana negli ultimi 40-50 anni, nella quale le forze cattoliche, un tempo maggioritarie, hanno lasciato il posto al pluralismo culturale, ma anche religioso; nella quale il cattolicesimo obbediente e mansueto del passato è in gran parte scomparso e numerosissimi sono i fedeli che hanno deciso di abbandonare la Chiesa. «Per molti cattolici adulti - scrivono le suore - le riforme del Vaticano II, così come il divieto della contraccezione naturale da parte della Chiesa, gli scandali degli abusi sessuali, le coperture della gerarchia, hanno cominciato a intaccare l’obbedienza cieca di molti fedeli. Di sicuro, i vescovi americani sono consapevoli del fatto che l’87% dei cattolici si oppone alla proibizione papale della contraccezione artificiale. Forse il Vaticano non ha capito che la cultura occidentale pone più enfasi sulla responsabilità personale».
Anche le superiore delle congregazioni religiose si sono trovate immerse in questa trasformazione e hanno dovuto fare i conti con le mutate esigenze delle donne che facevano parte delle loro congregazioni, nonché pubblico al quale rivolgevano il loro ministero, ma questo cambiamento «non ha messo in discussione l’orientamento spirituale e la fede in Dio», poiché «dottrina e ministero sono questioni separate». Il problema, semmai, è che non si comprende «perché il Vaticano trovi così difficile permettere un dialogo sincero e aperto sul futuro della Chiesa, sulla spiritualità, sulle priorità ministeriali, senza ingenerare paura di un’azione punitiva». E «solo le organizzazioni più repressive e autocratiche temono l’apporto sincero e onesto dei loro membri. Che cosa esprime questo aspetto riguardo all’autorità della Chiesa e alla relazione con le donne, che hanno offerto migliaia di anni di servizio dedicato, coerente e fedele?».
Le suore firmatarie della lettera affermano che l’impatto personale del provvedimento sulle suore della Lcwr, a molte delle quali sono legate da rapporti di amicizia, è stato pesante. «Speriamo che la Conferenza episcopale statunitense mantenga un atteggiamento di apertura mentale e di cuore nei confronti delle leader religiose, e continuino ad apprezzare e promuovere i loro numerosi doni, invece di supportare con atteggiamento mite e obbediente il Vaticano nel mettere al silenzio questa voce dello Spirito nella chiesa di oggi. Speriamo - è la loro conclusione - che abbiate il coraggio di fare la cosa giusta per le donne, anche se non siamo del tutto fiduciose nel fatto che ciò avverrà. Molte di noi hanno lasciato la propria comunità religiosa per il modo in cui le donne venivano trattato. La Chiesa, purtroppo, mostra ancora di avere paura e di volersi difendere dalla nostra influenza. Come potrà sopravvivere la Chiesa se continua a ignorare o a soggiogare metà della popolazione mondiale?».
Nel frattempo si sono moltiplicate, in numerose città statunitensi, veglie di preghiera e di sostegno alle religiose nonché manifestazioni di protesta; per il 29 maggio è stata programmata una grande manifestazione di supporto a Oakland, in California. È stato inoltre lanciato in tempi record un sito, www.nunjustice.org sul quale è possibile, tra l’altro, sottoscrivere le petizioni di sostegno. (ludovica eugenio)
* Adista Notizie, n. 19, 19/05/2012
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE ---- Benedetto XVI e l’appello dei preti austriaci (di Patrick Royannais, prete - Chi disobbedisce a chi?)13 maggio 2012, di Federico La Sala
Chi disobbedisce a chi?
di Patrick Royannais, prete
in “La Croix” del 13 maggio 2012 (traduzione: www.finesettimana.org)
Durante l’ultima messa crismale, Benedetto XVI ha fatto riferimento all’appello lanciato da più di trecento preti austriaci un anno fa relativo all’urgenza delle riforme nella Chiesa: “Di recente, un gruppo di sacerdoti in un Paese europeo ha pubblicato un appello alla disobbedienza, portando al tempo stesso anche esempi concreti di come possa esprimersi questa disobbedienza, che dovrebbe ignorare addirittura decisioni definitive del Magistero - ad esempio nella questione circa l’Ordinazione delle donne, in merito alla quale il beato Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato in maniera irrevocabile che la Chiesa, al riguardo, non ha avuto alcuna autorizzazione da parte del Signore.”
Benedetto XVI riconosce che questi preti vogliono servire la Chiesa ma si interroga sull’opportunità della disobbedienza, e lo possiamo capire. Ma, disobbedienza a chi? A Cristo? Non sembra si tratti di questo. Certo - in maniera fallace o per mancanza di rigore - il papa oppone “la conformazione a Cristo, che è il presupposto di ogni vero rinnovamento” e “la spinta disperata a fare qualcosa, a trasformare la Chiesa secondo i nostri desideri e le nostre idee”. Disobbedienza alla Chiesa? Non viene detto. La controversia riguarderebbe solo un punto, del resto discusso, dell’insegnamento di Giovanni Paolo II.
Che cosa dice la Chiesa? Chi non le è fedele? In che cosa? In quale ambito culturale o intellettuale bisogna trovarsi per pensare che, dato che il capo ha parlato, quello che ha detto è automaticamente vero? Nessun gruppo, nessuna persona, neppure il capo, può pretendere di detenere l’ultima parola della verità. Siamo lasciati al conflitto delle interpretazioni, non che si possa dire qualsiasi cosa o che la verità sia soggettiva, ma nulla garantisce in maniera definitiva qualsiasi interpretazione. Fragilità, recentemente riconosciuta, ma non nuova, della verità espressa in linguaggio umano. Inoltre, occorre ricordare che il capo della Chiesa cattolica non è il papa, ma Cristo? Questo evita di fare del governo del papa un regime politico mondano e permette di sottolineare, con l’ultimo concilio, che ogni discepolo è in ascolto della Rivelazione alla quale, magistero compreso, vuole obbedire.
“Il magistero non è superiore alla parola di Dio ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l’assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella parola” (Dei Verbum, n° 10).
Il papa e i preti austriaci ascoltano la parola del Signore, ma non comprendono la stessa cosa, almeno in punti molto periferici benché decisivi nel comportamento della Chiesa. Non può essere rimesso in discussione il loro attaccamento comune a Cristo che rivela nello Spirito la paternità di Dio; o alla Chiesa, che riceve missione di far risuonare la parola di Gesù e di lodare il Padre per i segni del Regno che germinano nel mondo; o alla forma storica della Chiesa cattolica in particolare nella sua strutturazione sacramentale del ministero.
Il conflitto delle interpretazioni deriva dal contraccolpo creato dalla secolarizzazione e dalla crisi delle istanze di verità o, in altri termini, dalla presa di coscienza della storicità della verità. Per essere fedeli all’insegnamento della Chiesa, non basta ripetere sempre la stessa cosa. Con il tempo, le stesse parole, le stesse pratiche hanno sensi diversi, di modo che chi si limita a ripetere, diventa inevitabilmente infedele. Per questo bisogna continuamente commentare le Scritture, commentare il Credo, reinterpretare la Tradizione della Chiesa, reinventare l’azione pastorale. La Chiesa ha sempre innovato per essere fedele alla sua tradizione e alla sua missione.
Quindi ci sono interpretazioni diverse o conflittuali tra quei preti e il papa. Ma quando chi ha l’autorità parla di disobbedienza, passa da un conflitto delle interpretazioni alla denuncia e all’esclusione di una posizione. Benedetto XVI pretende di chiudere il dibattito, ricorrendo de facto all’argomento d’autorità che la grande tradizione ha sempre contestato: “Al di sopra del papa in quanto espressione dell’autorità ecclesiale, c’è la coscienza alla quale bisogna innanzitutto obbedire, se necessario anche contro le richieste dell’autorità della Chiesa” (J. Ratzinger). Parlare di disobbedienza invece di ammettere la contingenza, l’indefinito conflitto delle interpretazioni, significa confiscare l’autorità e la verità. L’infallibilità papale non può legittimare l’argomento di autorità. Anche con la voce più dolce e lo spirito più umile che nessuno contesta a Benedetto XVI, potrebbe darsi che ci troviamo di fronte ad un abuso di potere. Chi disobbedisce a chi?
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- Nel Vaticano II torna la «razza» ebraica. Non è un errore antico: è un atto recente, volontario (di Alberto Melloni)6 maggio 2012, di Federico La Sala
E nel Vaticano II torna la «razza» ebraica
di Alberto Melloni (Corriere della Sera, 06.05.2012)
Lavora o ha lavorato per il sito della Santa Sede. Ignoriamo il suo nome, i suoi studi, cosa abbia pensato mentre mutavano i rapporti fra la Chiesa ed Israele. Ma questo sconosciuto - impunito come chi commercia carte e gossip d’oltre Tevere - è riuscito a depositare nel sito web vatican.va, per sfregio, una riga sulla «razza» ebraica. L’ha infilata nella traduzione italiana del Vaticano II: Nostra ætate affermò che la Chiesa ha sempre innanzi agli occhi le parole di Paolo «de cognatis eius» (cioè «sui suoi congiunti») che dicono che l’adozione, la gloria, il patto, la legge, il culto e le promesse appartengono a Israele e ai padri «dai quali è nato Cristo secondo la carne». Nel sito vatican.va quel «de cognatis» viene oggi tradotto «della sua razza»: ebraica, naturalmente.
Non è un errore antico: è un atto recente, volontario. Il testo latino (lo mostra la mia critica del Vaticano II nei Conciliorum œcumenicorum generaliumque decreta) non dava appigli. L’Osservatore Romano del 17 novembre 1965 traduceva «della sua stirpe». Le altre traduzioni d’allora, raccolte senza ritocchi dal sito, non hanno esitazioni. Il tedesco recita «Stammverwandten», cioè parenti. La versione portoghese parla di «compatriotas». L’inglese «kinsmen», come «soukmenovcích» in ceco. In swahili «juu ya watu wa ukoo wake» indica le persone «del suo clan». Più inquietante l’«hermanos de sangre» dello spagnolo, identica al bielorusso. Solo in francese si era già osato tradurre «race» nel 1965 (idiozia rimasta intonsa anche nel sito odierno).
La traduzione italiana usuale, dunque, è stata volontariamente manipolata per sfregiare il Vaticano II con un termine dalla storia inquietante: la razza. Entrato nella Spagna del secolo XV, passato al linguaggio giuridico e politico, venne consegnato dal trattato Sur l’inégalité des races humaines, opera del 1853 d’un cattolico come de Gobineau, a uno sviluppo «scientifico», di cui s’appropriano i perpetratori della Shoah. In quel lungo lasso di tempo anche il magistero cattolico ha parlato di razze: dalle discussioni sull’ammissione ai sacramenti degli indios fino al formarsi di un magistero sull’unità della famiglia umana, che negli anni Trenta afferma l’«uguaglianza delle razze».
Con la dichiarazione dell’Unesco del 1950 - la Santa Sede era rappresentata dal nunzio Roncalli - il mondo ripudia l’idea di razza: e al Vaticano II, proprio nella dichiarazione Nostra ætate, la Chiesa rompe con l’antisemitismo «di qualunque tempo e di chiunque».
Chissà se l’inventore di un inesistente Vaticano II «razzista» è un cretino inoffensivo o la voce in talare di xenofobi, antisemiti, suprematisti che innocui non sono. Ma che un nemico del Papa e della Chiesa faccia rientrare dalla finestra del web l’ombra d’un pensiero cacciato conciliariter dalla porta, dice che il Vaticano II ha ancora la forza di smascherare cosa c’è davvero dietro il sogno, di liberarsene o di spuntarne con un preambolo tradizionalista lo sperone riformatore che pungola la carne della Chiesa.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- E’ CHIARO CHE LA CARESTIA VA AL GALOPPO! Benedetto XVI "cambia la formula dell’Eu-carestia"! «Il calice fu versato per molti», non «per tutti»!25 aprile 2012, di Federico La SalaLa lettera di cinque pagine è rivolta alla conferenza episcopale tedesca ma riguarda ogni vescovo, a cominciare dagli italiani che ne discuteranno nell’assemblea di maggio. Benedetto XVI spiega le ragioni per cui si dovrà cambiare la formula dell’Eucarestia nella messa.
 Benedetto XVI "cambia la formula dell’Eu-carestia"! «Il calice fu versato per molti», non «per tutti»! Note di Gian Guido Vecchi e di Armando Torno
Benedetto XVI "cambia la formula dell’Eu-carestia"! «Il calice fu versato per molti», non «per tutti»! Note di Gian Guido Vecchi e di Armando Torno
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- COSA ABBIAMO FATTO DELLA GRAZIA CHE ABBIAMO RICEVUTO!!! RICEVUTO (di Marco Lillo - CL, cerchio magico intorno a papa Ratzinger)5 maggio 2012, di Federico La Sala
CL, cerchio magico intorno a papa Ratzinger
Nonostante scandali e “amici” arrestati l’organizzazione domina in Vaticano
di Marco Lillo (il Fatto, 05.05.2012)
Dopo 30 anni di assenza, un pontefice torna al Meeting di Cl a Rimini. Papa Ratzinger terrà un discorso alla grande kermesse di Comunione e Liberazione che quest’anno avrà come tema il rapporto tra l’uomo e l’infinito. Non è solo una voce ma un impegno preso nero su bianco da Benedetto XVI e dal segretario di Stato Tarcisio Bertone in un carteggio inedito che pubblichiamo. In un giorno d’estate compreso tra il 19 e il 25 agosto nei padiglioni della fiera il pontefice tedesco abbraccerà decine di migliaia di seguaci e simpatizzanti del movimento fondato da don Luigi Giussani nel 1954 e guidato dopo la morte del “Don” nel 2005 da don Julian Carron.
L’ULTIMO PAPA a partecipare al meeting è stato Giovanni Paolo II nel 1982. E proprio alla ricorrenza del trentennale si richiama la presidente del Meeting, Emilia Guarnieri, per chiedere a Benedetto XVI di tornare. La professoressa Guarnieri scrive il 23 novembre 2011 al segretario di Stato Tarcisio Bertone: “Il 1982 fu l’anno della storica visita al meeting del Beato Giovanni Paolo II. Il medesimo anno vide anche il riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. Il2012pertantorappresenta per noi un duplice e significativo trentennale ed un contesto estremamente suggestivo per accogliere il Santo Padre”. La professoressa, nella sua lettera a Bertone ricordava un incontro del 19 giugno a San Marino, nel quale il Papa le disse: “È molto tempo che non ci vediamo! Lei lavora ancora per il Meeting? ” in memoria delle antiche partecipazioni dei primi anni novanta dell’allora cardinale Joseph Ratzinger alla kermesse. E la lettera si concludeva con una preghiera a Bertone: “Affido alla Sua paternità e alla Sua benevolenza questo invito”.
Il segretario di Stato non si è risparmiato e nel volgere di due settimane ha ottenuto il sì del Pontefice. Il 9 dicembre del 2011 Tarcisio Bertone scrive al segretario del Papa don Georg Ganswein perché annoti l’impegno: “Con la presente Ti informo che nell’Udienza a me concessa il 5 dicembre 2011, il Santo Padre ha preso visione della lettera del 23 novembre 2011 della professoressa Emilia Guarnieri, Presidente del Meeting di Rimini. Considerando i due anniversari che cadono nel 2012, il Santo Padre ha espresso il suo favore per una breve visita e un suo intervento al Meeting di Rimini in data da stabilire”.
In fondo però quella che si sta preparando da mesi è solo la consacrazione di un legame che sempre di più sta diventando un elemento caratterizzante di questo e forse persino del prossimo pontificato, se troveranno conferma le voci dell’investitura dell’arcivescovo di Milano di provenienza ciellina, Angelo Scola. Proprio il Fatto ha pubblicato nel febbraio scorso un documento anonimo nel quale si annunciava la fine del papato di Ratzinger entro novembre 2012. Un annuncio di morte reinterpretato da alcuni osservatori come una previsione certa di “dimissioni” del Papa per far posto al suo successore preferito, cioè proprio Angelo Scola.
UNA SOLUZIONE “anomala” ma possibile, secondo l’interpretazione dottrinaria che lo stesso Ratzinger avrebbe avallato in un’intervista. Vera o falsa che fosse, la profezia della staffetta tra Ratzinger e Scola ha portato allo scoperto il peso crescente di Cl negli equilibri vaticani. Non è un mistero che siano cielline le quattro signore cinquantenni che dormono nell’appartamento papale e sono ammesse a pranzare e cenare con il Pontefice tanto da formare la cosiddetta famiglia papale. Per l’esattezza sono aderenti ai Memores Domini, associazione laicale i cui membri vivono i consigli evangelici di povertà, castità perfetta e obbedienza sotto l’egida di Comunione e Liberazione. Anche l’arcivescovo di Milano Angelo Scola condivide la quotidianità con alcune signore aderenti ai Memores.
Il legame tra Cl e Scola è molto stretto. Il Fatto ha rintracciato una lettera del marzo 2011 al Nunzio Apostolico in Italia Giuseppe Bertello dal leader di Cl don Julian Carron. In questa lettera Carron suggerisce di nominare Scola anche per la sua sensibilità all’area politica di centrodestra. “Rispondo alla Sua richiesta permettendomi di offrirle”, scrive Carron “in tutta franchezza e confidenza”, ben consapevole della responsabilità che mi assumo di fronte a Dio e al Santo Padre, alcune considerazioni sullo stato della Chiesa ambrosiana”. La diagnosi del leader di Cl è spietata: “Il primo dato di rilievo è la crisi profonda della fede del popolo di Dio... perdura la grave crisi delle vocazioni... la presenza dei movimenti è tollerata, ma essi vengono sempre considerati più come un problema che come una risorsa”.
Poi Carron arriva al dunque: “dal punto di vista poi della presenza civile della Chiesa non si può non rilevare una certa unilateralità di interventi sulla giustizia sociale, a scapito di altri temi fondamentali della Dottrina sociale, e un certo sottile ma sistematico ‘neocollateralismo’, soprattutto della Curia, verso una sola parte politica (il centrosinistra) trascurando, se non avversando, i tentativi di cattolici impegnati in politica, anche con altissime responsabilità nel governo locale, in altri schieramenti”. Il nome di Formigoni non c’è ma chiunque intravede dietro queste righe la figura del governatore. “Questa unilateralità di fatto... finisce per rendere poco incisivo il contributo educativo della Chiesa al bene comune, all’unità del popolo e alla convivenza pacifica”.
Per tutte queste ragioni, conclude Carron: “l’unica candidatura che mi sento in coscienza di presentare all’attenzione del Santo Padre è quella dell’attuale Patriarca di Venezia, Card. Angelo Scola. Tengo a precisare che con questa indicazione non intendo privilegiare il legame di amicizia e la vicinanza del Patriarca al movimento di Comunione e Liberazione, ma sottolineare il profilo di una personalità di grande prestigio e esperienza... ”.
L’arcivescovo di Milano, con la raccomandazione di Cl, oggi è dato per favorito a prendere il posto di Benedetto XVI. È questo il paradosso di Cl: proprio nell’anno della sua massima potenza e della annunciata benedizione del Papa con la sua visita al Meeting, esplodono gli scandali e le indagini della magistratura.
Dopo gli arresti di due ciellini amici di Formigoni come Antonio Simone e Pierangelo Daccò e la pubblicazione delle fotografie dei resort a cinque stelle dove il presidente della Lombardia è stato in vacanza persino don Julian Carron ha scritto a Repubblica: “Sono stato invaso da un dolore indicibile dal vedere cosa abbiamo fatto della grazia che abbiamo ricevuto. Se il movimento di Comunione e Liberazione è continuamente identificato con l’attrattiva del potere, dei soldi, di stili di vita che nulla hanno a che vedere con quello che abbiamo incontrato, qualche pretesto dobbiamo aver dato”. Una lettera che finora non ha fatto cambiare idea sul suo viaggio a Rimini a Benedetto XVI.
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- Benedetto XVI, un cammino drammatico e luminoso (di Bruno Forte).19 aprile 2012, di Federico La Sala
Benedetto XVI, un cammino drammatico e luminoso
di Bruno Forte (Il sole 24 Ore, 19 aprile 2012)
Sedici e 19 aprile sono due date importanti nella vita di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. La prima è quella della nascita, a Marktl am Inn in Baviera, ottantacinque anni fa. La seconda è la data dell’elezione al pontificato, nel 2005. Entrambe le ricorrenze hanno suscitato un’ondata di attenzione, di auguri da parte dei grandi della Terra, di innumerevoli messaggi di affetto, di segnali di tenerezza e di fiducia dai piccoli e dagli umili di ogni parte del mondo. Le due date sono anche un’occasione di riflessione e di bilancio per l’impatto di questo pontificato, che già segna di sè la storia. È il filone che vorrei seguire, chiedendomi quali caratteri fondamentali presenti l’opera di questo Papa e che cosa essa vada soprattutto dicendo alla Chiesa e al mondo. Non esiterei a definire la vita e il pontificato di Benedetto XVI con due aggettivi, che li caratterizzano come un cammino inseparabilmente drammatico e luminoso.
L’aspetto drammatico dell’esistenza di Joseph Ratzinger e della Sua azione quale Successore di Pietro risulta evidente se solo si pensa al contesto storico dei Suoi giorni: nato ai tempi della Repubblica di Weimar, l’attuale Papa ha vissuto molto presto gli anni sconvolgenti della dittatura nazionalsocialista e della guerra. Educato da genitori saldamente credenti, ha appreso con naturalezza la diffidenza verso le menzogne del potere, che lo ha portato da giovanissimo studente a dichiarare apertamente a chi con la forza del potere avrebbe voluto arruolarlo nelle file del regime che i suoi progetti erano totalmente diversi, perché nel suo cuore sentiva di essere chiamato al ministero di perdono e di carità del sacerdozio.
La reazione violenta che seguì a quella dichiarazione non smosse minimamente la fermezza del giovane Ratzinger, tanto che egli venne destinato a ruoli secondari e "insignificanti" nella difesa contraerea. Al dramma del totalitarismo seguì l’esperienza non meno difficile del dopoguerra, della Germania divisa fra i due blocchi, di un Occidente attraversato dalle contrapposizioni ideologiche e dal vento della contestazione del ’68.
Il giovane sacerdote, professore di teologia, non cedette alle mode, e - come aveva lucidamente rifiutato da ragazzo la barbarie ideologica - così continuò a opporsi alle semplificazioni di letture ispirate ai "grandi racconti" delle ideologie, matrici di violenza e di strumentalizzazioni della dignità umana. Accanto a Giovanni Paolo II il Card. Ratzinger fu l’amico, il consigliere lucido e discreto, il compagno di viaggio messo al fianco del Mosé che Dio aveva scelto per attraversare il guado fra i due millenni. Gli scenari dello "scontro di civiltà" dell’inizio del nuovo Millennio hanno ulteriormente accentuato il senso drammatico dei processi in atto, di cui Papa Benedetto ha mostrato di avere precisa consapevolezza pronunciando sin dall’inizio il suo "no" deciso a ogni uso della violenza in nome di Dio, sia in forza della ragione rettamente adoperata, sia in forza della fede nell’unico Padre e Signore di tutti.
Ma il dramma ha attraversato anche dal di dentro la Chiesa: è la crisi della fede su cui questo Papa si è espresso con singolare chiarezza e determinazione. «Quando annunciai di voler istituire un Dicastero per la promozione della nuova evangelizzazione - affermava Benedetto XVI il 30 maggio del 2011 -, davo uno sbocco operativo alla riflessione che avevo condotto da lungo tempo sulla necessità di offrire una risposta particolare al momento di crisi della vita cristiana, che si sta verificando in tanti Paesi, soprattutto di antica tradizione cristiana». La crisi non è quella di superficie che possa toccare l’una o l’altra struttura della Chiesa, ma quella che va alla radice dell’intera esistenza credente. Si tratta di quella «perdita del senso del sacro, che giunge a porre in questione i fondamenti che apparivano indiscutibili, come la fede in un Dio creatore e provvidente, la rivelazione di Gesù Cristo unico salvatore, e la comune comprensione delle esperienze fondamentali dell’uomo quali il nascere, il morire, il vivere in una famiglia, il riferimento a una legge morale naturale».
Davanti agli scenari del dramma in atto, Benedetto XVI non cede alla rinuncia o al pessimismo: egli non esita ad annunciare il grande "sì" di Dio risuonato in Gesù Cristo, e a proporre ragioni di vita e di speranza che rendano sensata la vita e bello l’impegno per il bene di tutti. Si tratta di un messaggio luminoso, che mira a promuovere e sostenere uno straordinario sforzo di rinnovamento della vita cristiana ed ecclesiale: come aveva affermato da giovane professore di teologia, la riforma «non consiste in una quantità di esercizi e istituzioni esteriori, ma nell’appartenere unicamente e interamente alla fraternità di Gesù Cristo...Rinnovamento è semplificazione, non nel senso di un decurtare o di uno sminuire, ma nel senso del divenire semplici, del rivolgersi a quella vera semplicità...che in fondo è un’eco della semplicità del Dio uno. Diventare semplici in questo senso - questo è il vero rinnovamento per noi cristiani, per ciascuno di noi e per la Chiesa intera» (Il nuovo popolo di Dio, Brescia 1971, 301. 303).
L’autentica riforma voluta da questo Papa è, insomma, quella della conversione evangelica, la sola capace di riportare la Chiesa alla bellezza originaria e di farla risplendere come segno levato fra i popoli. Sarà da questo ritrovato riconoscimento del primato di Dio confessato e amato - cui precisamente punta l’anno della fede indetto per il 2012-2013 - che verrà la nuova primavera della Chiesa e del mondo, di cui gli uomini hanno immensa necessità e urgenza: «Ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della storia - aveva detto qualche settimana prima di diventare Papa - sono uomini che, attraverso una fede illuminata e vissuta rendano Dio credibile in questo mondo. La testimonianza negativa di cristiani che parlavano di Dio e vivevano contro di Lui, ha oscurato l’immagine di Dio e ha aperto la porta dell’incredulità. Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all’intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini» (Subiaco, 1 Aprile 2005).
Tale è in prima persona questo Papa: e il riconoscimento sempre più ampio che gli viene tributato sta a dire che la forza della verità, da lui amata e servita, si irradia di per sé, attraverso la mitezza del gesto e la semplicità della vita, la forza dei ragionamenti e l’ascolto dell’altro, la testimonianza coraggiosa e la speranza vissuta. Che tutto questo raggiunga e illumini tante menti e tanti cuori è l’augurio più vero, certo il più gradito, che possiamo fare all’ottantacinquenne Papa, giovane di appena sette anni di pontificato...
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA ... ---- Ratzinger e quelle dimissioni possibili: “un’ipotesi concreta”. Monsignor Bettazzi torna a parlarne.17 aprile 2012, di Federico La Sala
Ratzinger e quelle dimissioni possibili
Monsignor Bettazzi torna a parlarne come di “un’ipotesi concreta”
di Luca de Carolis (il Fatto, 17.04.2012)
Quell’ultimo tratto di strada “potrebbe essere quello fino alle dimissioni”. E comunque, Benedetto XVI potrebbe lasciare “solo dopo aver finito il libro su Gesù”. Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, descrive come un’ipotesi concreta le dimissioni di Joseph Ratzinger. E lo dice ai microfoni di “Un Giorno da pecora”, programma su Radio2 dove già due mesi fa aveva parlato di un “Papa pronto a dimettersi, perché molto stanco”.
Non solo per l’età: “Di fronte ai problemi che ci sono, forse anche di fronte alle tensioni che ci sono all’interno della Curia, potrebbe pensare che di queste cose se ne occuperà il nuovo pontefice”. Una replica, neanche troppo indiretta, a smentite, versioni ufficiali e silenzi imbarazzati sulle lotte di potere in Vaticano, puntualmente raccontate dal Fatto. Scontri a colpi di documenti e veti incrociati, che hanno amareggiato e logorato Benedetto XVI. Un’amarezza lucida, su cui peserebbero anche ricordi dolorosi.
Pochi giorni fa, a Tg2 dossier, ancora Bettazzi aveva raccontato possibili e fragorose verità: “Il Papa potrebbe dare le dimissioni, prima che arrivi quel momento in cui non è più il pontefice a guidare la Chiesa. Ha visto gli ultimi anni di Giovanni Paolo II, e sapeva che lui voleva dare le dimissioni ma non gliel’hanno lasciate dare. Io gli auguro lunga vita e lucidità, ma se Benedetto XVI si accorgesse che le cose stanno cambiando, avrebbe il coraggio di dimettersi”. Ratzinger insomma non accetterebbe di continuare da simbolo vivente, svuotato però di effettivi poteri. E potrebbe lasciare, prima che a governare di fatto la Chiesa sia qualcuno non eletto al soglio pontificio .
Ieri il vescovo di Ivrea ha ribadito: “Il Papa è molto stanco, e può darsi che dica: ‘Piuttosto che un pontefice stanco, lasciamo che ne venga uno nuovo, che continui con vigore la purificazione della Chiesa che Ratzinger ha iniziato e che gli sta tanto a cuore’”.
Ma quando? Bettazzi precisa: “Il pontefice vuole prima finire il libro su Gesù, gli preme tanto. I giornali dicono che lo finirà a dicembre , ma può essere anche che approfitti dell’estate per finirlo prima”. Poi da scrivere ci sarebbero il futuro di un Papa e della Chiesa. Guidata da un intellettuale che potrebbe anche scegliere di dedicarsi solo ai suoi libri. Bettazzi cita come possibili papabili “Scola, Ravasi, Bertello”. Ma conclude: “Lasciamo fare ai cardinali”. Chiaro e semplice. Come certe verità difficili da dire.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE .... ANCHE AD 85 ANNI, SI PUO’ RINASCERE (COME INSEGNAVA GESU’ A NICODEMO). Gli auguri a Benedetto XVI che il 16 aprile compie 85 anni (di "Osservatore Romano)..14 aprile 2012, di Federico La Sala
Gli auguri a Benedetto XVI che il 16 aprile compie 85 anni
Nella semplicità della preghiera
Benedetto XVI è rientrato nella serata di venerdì 13 aprile in Vaticano da Castel Gandolfo, dove si trovava dal pomeriggio della domenica di Pasqua. Il Papa ha anticipato di quarantotto ore il suo ritorno per accogliere il fratello, monsignor Georg Ratzinger, che trascorrerà con lui i prossimi giorni, segnati da ricorrenze particolarmente significative: l’ottantacinquesimo compleanno, lunedì 16, il settimo anniversario dell’elezione a successore dell’apostolo Pietro, giovedì 19, e quello del solenne inizio del pontificato, martedì 24. Le immagini che pubblichiamo ritraggono un momento della preghiera delle Lodi che i due fratelli hanno recitato insieme questa mattina, nella cappella privata del Pontefice, dopo la celebrazione della messa. Ed è proprio nella semplicità della preghiera quotidiana che "L’Osservatore Romano" si unisce ai suoi lettori e a moltissime altre persone in tutto il mondo - donne e uomini, anche al di là di distinzioni religiose - nell’augurare a Benedetto XVI buon compleanno. Chi crede non è mai solo, ama ripetere il Papa, che esprime con questa frase la realtà misteriosa e invisibile, ma non per questo meno vera, della comunione dei santi. E Benedetto XVI non è certo solo perché lo circondano l’affetto di persone vicine e lontane e l’amicizia dei santi: ad multos annos, beatissime pater, ad multos et felicissimos annos!
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE .... RINASCERE- Nicodemo a Gesù:«Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» (Gv., 3. 1-15)14 aprile 2012, di Federico La Sala
"CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4, 1-8)
Giovanni - Capitolo 3
Colloquio con Nicodemo *
[1]C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. [2]Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui». [3]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». [4]Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?».
[5]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. [6]Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. [7]Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. [8]Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito».
[9]Replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». [10]Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? [11]In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. [12]Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? [13]Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorchè il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo. [14]E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, [15]perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna».
-
> RINASCERE ---- Nati da Dio, siamo Cristo risorto. Pace a voi (di di Raymond Gravel - una riflessione).15 aprile 2012, di Federico La Sala
Noi siamo Cristo risorto!
di Raymond Gravel
in “www.lesreflexionsderaymondgravel.org” del 13 aprile 2012 (traduzione: www.finesettimana.org)
Per 50 giorni, o meglio 49 giorni (7x7), la Chiesa dispiega la festa di Pasqua. Questo tempo termina il 50° giorno, che si chiama Pentecoste. Sant’Attanasio diceva infatti che c’è solo un’unica domenica di Pasqua che si prolunga fino a Pentecoste. Così, se è vero che senza Pasqua non ci sarebbe mai stato Natale, sappiamo che prima di essere annuale, la celebrazione pasquale fu, per i primi cristiani, settimanale: ogni domenica era un memoriale della Resurrezione del Signore. Solo nel II secolo la Chiesa ha scelto di celebrare ogni anno la festa di Pasqua. Ma in realtà, ogni domenica è Pasqua, poiché celebriamo il memoriale della morte-resurrezione di Cristo.
Purtroppo, nella Chiesa cattolica, a partire dal XVI secolo, nel conflitto con i Protestanti, si è talmente insistito sul sacrificio della messa che ci ricorda il sacrificio della croce, che si è messo in secondo piano il memoriale della Resurrezione. Eppure non si possono separare le due cose: la messa, cioè l’Eucaristia è il memoriale della morte-resurrezione di Cristo, ed è quindi la festa di Pasqua.
Oggi i testi biblici che ci sono proposti sono ricchi di senso e di significati. Eccone alcuni:
1. L’ideale della Chiesa primitiva. Nella prima lettura di oggi, nel libro degli Atti degli Apostoli, abbiamo il secondo sommario di tre, sull’ideale proposto dai primi cristiani. Questo sommario riprende ciò che era stato il tema del primo: la predicazione apostolica ed il suo successo presso le folle (Atti 4,33). Luca inserisce questo versetto tra due descrizioni della vita interna della comunità cristiana:
“La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune” (Atti 4,32).
“Nessuno tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno” (Atti 4,34-35).
Queste due descrizioni del vissuto dei primi cristiani possono sembrare irrealistiche ed utopistiche, ma si tratta invece di un ideale proposto dalla Chiesa primitiva, a partire dal concetto dell’amicizia greca vantata da Aristotele: “Gli amici hanno una sola anima tra loro e i beni sono proprietà comune”, e a partire da una rilettura del libro del Deuteronomio sulla ripartizione della ricchezza:
“Non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi” (Dt 15,4).
È evidente che tanto tra i primi cristiani che tra i cristiani di oggi c’è una grande distanza dall’applicazione di questo ideale. L’episodio di Saffira e di Anania riferito dagli Atti (Atti 5,1-11), ce lo mostra chiaramente. Del resto, anche oggi, dobbiamo lasciarci interpellare da questo ideale; siamo ancora lontani dalla sua realizzazione. Tuttavia, la fede cristiana lo esige.
2. Nati da Dio, siamo Cristo risorto. Che bella la lettera di Giovanni che ci dice la dignità di coloro che credono nel Cristo risorto: “Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato” (1Gv 5,1). Pasqua è presentata come una nuova creazione, già sulla croce del Venerdì santo, la Chiesa è nata, e la sua missione comincia la mattina di Pasqua. San Giovanni Crisostomo, nel IV secolo, diceva: “Uscì dal suo costato sangue ed acqua (Gv 19,34)... Ho detto che quell’acqua e quel sangue erano il simbolo del battesimo e dei misteri (l’eucaristia). Ora, la Chiesa è nata da questi due sacramenti: da questo bagno della rinascita e del rinnovamento nello Spirito, dal battesimo quindi, e dai misteri. Ora, i segni del battesimo e dei misteri provengono dal costato. Quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu formata Eva”.
Allo stesso tempo, tutto è Amore: “In questo riconosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio” (1Gv 5,2a), e, per amare Dio, bisogna prima di tutto amare i suoi figli: “Se uno dicesse: ’Io amo Dio’, e odiasse suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede” (1Gv 4,20). E l’amore si manifesta nel nostro modo di essere e nel nostro modo di vivere come cristiani: “In questo infatti consiste l’amore di Dio: nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi” (1Gv 5,3). Il che ha fatto dire a Sant’Agostino, nel IV secolo: “In ciò che si ama, o non c’è fatica, oppure questa stessa fatica è amata”.
3. La missione cristiana: pace, gioia, liberazione, speranza e presenza. La pagina di vangelo che leggiamo ogni anno nella seconda domenica di Pasqua costituiva, agli inizi della Chiesa, la fine del vangelo di Giovanni. Il capitolo 21 è un’aggiunta posteriore, con la quale l’autore o gli autori hanno voluto riconciliare i cristiani che credevano nel ruolo particolare di Pietro e quelli che accordavano un posto preponderante al discepolo che Gesù amava. La pagina del vangelo di oggi comporta dei messaggi importanti:
1) L’apparizione ai discepoli la sera di Pasqua e la domenica successiva significa innanzitutto l’importanza della riunione domenicale, come luogo di incontro del Risorto. Di modo che, nella prima riunione, Tommaso è assente; non ha quindi potuto fare l’esperienza del Risorto. Solo la domenica successiva ha potuto anche lui incontrare il Signore. Il che significa che ancora oggi è possibile anche a noi vivere l’esperienza del Risorto nelle nostre riunioni domenicali.
2) Durante queste riunioni, Cristo si fa presente, nonostante le nostre porte chiuse a chiave. Ed è presente per darci la sua pace. Ma in quale modo lo si riconosce? Giovanni ci dice che il Risorto di Pasqua è proprio il Crocifisso del Venerdì santo. Si tratta quindi di una continuità tra il Gesù del Calvario e il Cristo della mattina di Pasqua. In fondo, la Resurrezione non abolisce la passione, la sofferenza e la morte; le trasforma, ne rivela il senso. Soprattutto non dimentichiamo che siamo alla fine del I secolo, in piena persecuzione cristiana, Per questo, è vedendo gli altri, e specialmente coloro che portano i segni e le ferite del crocifisso, che i partecipanti alla riunione riconoscono il Signore e provano una grande gioia: “I discepoli gioirono al vedere il Signore” (Gv 20, 20b). La pace li invade: “Pace a voi!” (Gv 20, 19b.21a).
3) Riuniti in nome della nostra fede e della nostra appartenenza a Cristo, siamo ricreati, investiti del suo Spirito: “Detto questo soffiò e disse loro: ’Ricevete lo Spirito Santo’” (Gv 20,22). È la Pentecoste, è la missione che comincia. Questa nuova creazione fa dei discepoli dei Cristi risorti. Bisogna quindi aprire le porte e partire ad annunciare questa Buona Notizia che Cristo è vivo, che ci assicura la sua presenza, che ci lascia la sua pace e che ci offre la liberazione, la libertà: “A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati; a coloro a cui non li perdonerete non saranno perdonati” (Gv 20,23). È una responsabilità: si ha il potere di liberare la gente o di rifiutare di farlo. Una cosa è certa, se vogliamo assomigliare a Cristo, la liberazione è obbligatoria.
4) Assente dalla prima riunione, Tommaso, che è, insieme, il nostro gemello e il nostro modello nella fede, non ha fatto l’esperienza del Risorto. Sentiva la testimonianza degli altri, ma gli ci voleva qualcosa di più: “Se non vedo nelle sue mani il segno e se non metto il mio dito nel suo fianco, io non credo” (Gv 20,25b). Alla riunione della domenica successiva, Tommaso è presente. Il testo di Giovanni non dice che Tommaso ha toccato le piaghe di Cristo... Dice semplicemente che le ha viste, e il verbo vedere, nel vangelo di Giovanni ha lo stesso senso del verbo credere: vedere porta necessariamente alla fede. Per questo, l’evangelista Giovanni ci presenta Tommaso non come un incredulo, ma proprio come un modello di fede. L’espressione: “Mio Signore e mio Dio” (Gv 20,28) è la più bella professione di fede del discepolo che incontra il Risorto.
5) La Beatitudine che segue al versetto 29: “Beati coloro che credono senza aver visto”, si rivolge a tutti i cristiani di tutti i tempi che sono invitati a credere sulla testimonianza dei primi testimoni, cioè di coloro che hanno conosciuto Gesù di Nazareth e che, dopo la sua morte, lo hanno riconosciuto vivente nella comunità dei suoi discepoli. La loro esperienza del Risorto è unica, nel senso che possono verificare la sua autenticità rispetto a quel Gesù che hanno conosciuto, seguito, amato, accompagnato fino alla morte. Sono in qualche modo dei testimoni privilegiati, ed è sulla loro testimonianza che si fonda la fede nostra, di noi, discepoli di oggi.
Terminando vorrei condividere con voi questo bellissimo commento dell’esegeta francese Jean Debruynne su questa pagina di vangelo:
“Questo testo del vangelo è una meravigliosa canzone di speranza. È quando noi abbiamo chiuso la porta a Gesù, quando abbiamo messo il chiavistello, che Gesù entra e sta lì. È nel momento in cui si dubita di più che Gesù arriva. È nella notte che nasce il giorno. È nell’inverno che comincia la primavera. È quando non c’è più speranza terrena, che sorge la Speranza vera. È quando non c’è più ragione di credere che la fede apre gli occhi. Il chiavistello è messo, la porta è ermeticamente chiusa eppure Gesù è lì. Non è fuori di noi, è dentro. Si presenta: ’Pace a voi!’ Gesù non è né rimprovero né accusa, è Pace. La Pace sia con voi!”
-
-
-
> L’EUCARESTIA, L’EUCHARISTIA, E IL PARROCO EMILIANO. Don Piergiorgio Zaghi rifiuta la comunione a un bimbo disabile (di Giacomo Galeazzi - Parroco sotto accusa Ferrara, il Vaticano contro la decisione del sacerdote)12 aprile 2012
GRAZIA ("CHARIS") E AMORE EVANGELICO ("CHARITAS"). I Padri delle origini chiamavano l’Eucharistia, il "sacramento della misericordia divina", al pari del sacramento stesso della riconciliazione.
"La parola «Eucaristia» deriva dal verbo greco «eu-charistèō/rendo grazie» che a sua volta proviene dall’avverbio augurale «eu-...-bene» e «chàirō-rallegrarsi/essere contento»" (Paolo Farinella, prete).
Parroco sotto accusa Ferrara, il Vaticano contro la decisione del sacerdote
di Giacomo Galeazzi (La Stampa, 12 aprile 2012)
Un parroco emiliano rifiuta la comunione a un bimbo disabile ed esplode una polemica così infuocata da rimbalzare subito a Strasburgo e in Vaticano. Il sacramento negato a Pasqua trasforma l’episodio in una controversia internazionale e la protesta in due esposti. Il primo alla Corte europea dei diritti dell’uomo «per violazione della libertà religiosa».
Il secondo alla Santa Sede. Tutto inizia giovedì santo a Comacchio, nel Ferrarese, alla cerimonia propedeutica alle prime comunioni. Don Piergiorgio Zaghi ritiene che il bambino, affetto da un grave ritardo mentale, non sia in grado di «comprendere il mistero dell’Eucarestia». Sconcerto, clamore, raffica di reazioni.
Il sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio dei diritti sui minori e consulente della Commissione parlamentare dell’Infanzia, denuncia «un oscurantismo culturale da medioevo». Negando al piccolo la comunione, «il sacerdote ha leso la sua dignità di persona». I parrocchiani si dividono fra chi condivide la scelta e chi dissente richiamando l’appello papale ad assicurare il sacramento, per quanto possibile, anche ai disabili mentali. Al sacerdote scrive una lettera un compagno di classe del bambino: «Se fosse con noi sarebbe una grande gioia per lui e noi avremmo il vero valore della Comunione».
I genitori prendono male il no del parroco e affidano alle carte bollate l’amara sorpresa. Nella Curia romana il cardinale canonista Velasio De Paolis solidarizza con loro e stigmatizza l’eucarestia rifiutata a un bimbo ritenuto incapace di comprendere il sacramento.
Lo stretto collaboratore di Benedetto XVI ricorda come nelle comunità orientali i bambini ricevano l’eucarestia subito dopo il battesimo, quindi «se il disabile non profana l’ostia, se la accoglie serenamente, nella Chiesa è prassi che gli venga amministrata». E, aggiunge, «io non l’avrei negata», soprattutto per «la forza del sacramento che raggiunge anche chi è malato o in punto di morte». Spera ancora che don Zaghi «ci ripensi», Claudia, la madre del bambino «discriminato senza ragione in quanto è andato regolarmente al catechismo». E aggiunge: «Ci andava volentieri, certo il grado di attenzione non era come quello degli altri bambini, perché mio figlio ha anche un ritardo mentale».
E riguardo al fatto che non possa capire il «mistero del sacramento dell’Eucarestia», alla mamma «sembra che anche un bimbo di 10 anni “normale”, anche se non mi piace la parola, non possa comprenderlo fino in fondo». I legali della famiglia si appellano al fatto che «l’ordinamento giuridico canonico non fa alcun riferimento né all’età né alla capacità di intendere e volere del soggetto che si appresta a ricevere il Sacramento dell’Eucarestia». E sottolineano che «il minore in questione pur se affetto da grave disabilità motoria non è comunque giuridicamente totalmente incapace di comprendere il significato dell’istituto sacramentale».
Interviene la comunità Papa Giovanni XXIII: «Da noi molti cerebrolesi ricevono regolarmente la comunione». Per l’associazione di don Oreste Benzi, «la comunione negata al bambino disabile deve interpellare tutta la comunità cristiana». Nella comunità, anche i ragazzi gravemente disabili ricevono la comunione. «Sono degli angeli crocifissi, come diceva don Benzi, e dobbiamo ripartire dagli ultimi accogliendoli realmente nelle nostre comunità, avvicinando le famiglie che hanno al loro interno i disabili e sostenerle».
La cerimonia della prima comunione si terrà in maggio e coinvolgerà una ventina di ragazzi in totale. C’è abbastanza tempo per la retromarcia in cui la famiglia confida. «Spero che il bambino possa fare la comunione con tutti i suoi compagni, che hanno dimostrato di tenerci: anche loro hanno insistito perché facesse la comunione con loro, sono stati tutti molto solidali con noi», conclude mamma Claudia. Per ora la diocesi ha avallato il no del parroco. Da lì potrebbe partire il ripensamento. Per carità e buon senso.
Il Papa santo Pio X aveva fissato un’età-limite per la prima comunione: può ricevere l’Eucarestia chi è in grado di distinguere il pane di Dio da quello materiale. E quindi è meglio attendere i 9-10 anni per amministrare il sacramento, anche se la Chiesa cattolica non ha mai condannato la prassi consolidata nelle comunità orientali di concedere la comunione subito dopo il battesimo, quindi a bimbi appena nati.
Benedetto XVI nell’esortazione apostolica del 2007 «Sacramentum Caritatis» cancella ogni dubbio. «Venga assicurata anche la comunione eucaristica, per quanto possibile, ai disabili mentali, battezzati e cresimati: essi ricevono l’Eucaristia nella fede anche della famiglia o della comunità che li accompagna», chiarisce Joseph Ratzinger, Pontefice teologo e pastore. E il «quanto possibile» si riferisce ad una possibilità fisica, non mentale (per esempio se i disabili riescano a deglutire e ingerire l’ostia o meno).
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- LA RECITA E’ FINITA. Pensieri tra Quaresima e Pasqua (di don Angelo Casati)30 marzo 2012, di Federico La Sala
Recitare o essere? Pensieri tra Quaresima e Pasqua
di don Angelo Casati
Viandanti (www.viandanti.org, 30 marzo 2012
Mi succede - qualcuno la ritiene una mia ossessione - di avere in sospetto ogni parola che, poco o tanto, sembra recitata, ogni atteggiamento che, poco o tanto, sembra studiato. Si recita una parte. A volte mi sorprendo a guardarmi. E mi chiedo: "Stai recitando? Stai celebrando o recitando? Stai pregando o recitando? Stai predicando o recitando? Stai parlando o recitando?". Nella recita non ci sei. C’è una parte che indossi. Che non è la tua.
Gesù incantava
Gesù non recitava. Forse per questo o anche per questo, incantava. Era autentico, aderente la vita, non a una parte da recitare. E la gente lo sentiva vero. A differenza di altri. A differenza, per esempio, di una certa frangia - non tutti! - di farisei che "recitavano": "Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini. Allargano i loro filatteri, allungano le frange; amano posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbì dalla gente"(Mt.23,5-7).
Qualcuno, anche nel mondo ecclesiastico, sconcertato dalla calda umanità di Gesù, tende a presentarla come se il Signore stesse recitando, quasi non gli fosse consentito, in quanto Dio, di crescere, di essere stanco, di non sapere, di amare i banchetti, di desiderare la tenerezza di un bacio o il profumo dell’unguento, di provare paura e solitudine. Quasi recitasse, in tutto ciò una parte non sua. Gesù non ha mai recitato. Era.
Dominante è il ruolo
C’è il pericolo - lo avverto sempre più acutamente e il racconto delle tentazioni di Gesù, all’inizio della Quaresima, lo segnalava - che anche la religione diventi spettacolo, luogo in cui si recita. Strano verbo, questo "recitare", che abbiamo nel nostro linguaggio religioso legato al pregare! Si "recita" una Ave Maria o un Padre Nostro, si "recita" il rosario. È in agguato la recita. La avverti. A volte è nell’aria. A tradirla è un tono affettato, artefatto, poco naturale, studiato.
Aria strana. L’aria di certi raduni ecclesiastici. Volti impassibili, non tradiscono la benché minima emozione. Ci si parla di errori, di cedimenti o di smarrimenti, sono sempre quelli degli altri. L’inquietudine non esiste. Esiste la sicurezza. Si recita la parte di Dio. Mai uno che dica: "Ho peccato". Lo si dice nella Messa, ma per modo di dire. Nessuno che abbia mai fatto un errore. E che lo riconosca. Domina il ruolo. L’impassibilità del ruolo. Impenetrabili, drappeggiati, diplomatici. E senti la distanza. E come se mancasse gente vera. Non sono i volti che cerchi, quelli che ti incantano fuori le mura, volti che non mascherano le stanchezze e le emozioni, volti che confessano l’inquietudine e la lontananza.
Scrive Carlo Maria Martini: "Non di rado mi spavento sentendo o leggendo tante frasi che hanno come soggetto "Dio" e danno l’impressione che noi sappiamo perfettamente ciò che Dio è e ciò che egli opera nella storia, come e perché agisce o in un modo e non in un altro. La Scrittura è assai più reticente e piena di mistero di tanti nostri discorsi pastorali".
Come figli di Dio
Comunità alternativa si diventa vivendo il Vangelo, non recitando la parte del "perfetto". Alternativi diventiamo non mascherandoci dietro il ruolo o dietro il titolo, ma dando trasparenza ai rapporti. Incontrandoci come persone. Come figli di Dio. Questa la più grande dignità che ci è toccata. Non esiste, per un vero credente, altra tanto grande.
Essere Papa, essere Vescovo, essere prete, non vale l’essere figli di Dio. E, se figli, liberi, e quindi non soffocati, non mascherati, non misurati da titoli e da ruoli.Quando Papa Giovanni, poco dopo la sua elezione, si accorse che l’ Osservatore Romano introduceva le sue parole con questa formula di rito: "Come abbiamo potuto raccoglierle dalle auguste labbra di Sua Santità", chiamò il capo redattore e gli disse: "Lasciate perdere queste sciocchezze e scrivete semplicemente: Il Papa ha detto".
La grande sfida
Quale perdita per la società, se la Chiesa, che nel mondo dovrebbe apparire come lo spazio dove risplende la libertà e l’umanità dei rapporti, diventasse luogo di relazioni puramente formali, deboli e fiacche, non sincere e intense.
Rischierebbe l’insignificanza. Verrebbe meno alla grande sfida, all’opportunità che oggi le si offre di tessere in una società ampiamente burocratizzata rapporti autentici e profondi.
E non sarà che alla Chiesa di oggi, e quindi a ciascuno di noi, Dio chieda meno protagonismo, meno organizzazione, meno recite e più vicinanza, più sincerità?
Alla mente ritorna una pagina folgorante dello scrittore Ennio Flaiano, là dove abbozzava un ipotetico ritorno di Gesù sulla terra, un Gesù, infastidito da giornalisti e fotoreporter, come sempre invece vicino ai drammi e alle fatiche dell’esistenza quotidiana: "Un uomo" - scrive - "condusse a Gesù la figlia ammalata e gli disse: "Io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami". Gesù baciò quella ragazza e disse: "In verità questo uomo ha chiesto ciò che io posso dare". Così detto, sparì in una gloria di luce, lasciando le folle a commentare quei miracoli e i giornalisti a descriverli".
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- Essere cristiani di Hans Küng, l’occasione sprecata dalla Chiesa (di Enzo Bianchi)11 marzo 2012, di Federico La Sala
Hans Küng, l’occasione sprecata dalla Chiesa
di Enzo Bianchi (La Stampa, 11 marzo 2012)
C’ è da rallegrarsi a ritrovare nelle librerie un’opera come Essere cristiani di Hans Küng (Rizzoli, pp. 936, € 25), a quasi quarant’anni dalla prima pubblicazione: «un’introduzione all’essere cristiani [...], una piccola “summa” della fede cristiana», secondo le parole stesse dell’autore, volta a presentare «non un Vangelo diverso, ma lo stesso Vangelo di sempre, riscoperto per il nostro tempo». Un’analisi densa e articolata del cristianesimo a partire dal Gesù storico e dal suo annuncio della «buona notizia», una ricerca condotta con competenza e grande sensibilità ecumenica da un allora giovane teologo cattolico che aveva partecipato al Concilio Vaticano II come esperto.
Küng era e rimane un appassionato di Cristo, un credente convinto che il Vangelo possa parlare al cuore e alla mente di uomini e donne di ogni tempo e di ogni cultura, un pensatore che non teme di affrontare le sfide del dialogo con la ragione e con le altre religioni. E l’impatto profondo che questa sua opera ha avuto presso tanti cristiani e anche presso chi era estraneo alla Chiesa o si era ritirato ai margini di essa ne sono una prova inequivocabile. Parlo di «impatto» e non di «successo» perché se sui numeri delle copie vendute di un libro possono incidere tanti fattori contingenti o meno, anche estranei al contenuto, sugli effetti duraturi che un’opera può avere e sull’arricchimento personale che riesce a offrire anche a distanza di anni solo il messaggio del testo può influire.
In questo senso Küng non solo espone «una» possibile introduzione al cristianesimo - per quanto ricca e documentata - ma, attraverso di essa, lascia trasparire la passione di una ricerca assidua del radicalismo evangelico, comunica a un largo pubblico il clima spirituale e la volontà di dialogo che hanno segnato la feconda stagione della Chiesa nel postconcilio, getta squarci di luce su orizzonti di speranza.
Certo, Essere cristiani è stata e rimane anche un’opera altamente controversa: assieme ad altri suoi testi di quella stagione gli valse il ritiro della missio canonica per l’insegnamento della teologia nelle facoltà cattoliche, senza tuttavia che si giungesse a una condanna nei confronti dell’autore e della sua teologia.
La complessità dei problemi sollevati, la durezza di certi accenti polemici, l’incomprensione reciproca ha portato a scavare un fosso sempre più ampio tra Küng e il magistero cattolico. E proprio qui il rammarico si unisce al compiacimento per la riedizione di Essere cristiani. Sì, perché questo testo fa toccare con mano la grande opportunità che non si è saputo o potuto cogliere. Il teologo svizzero, infatti, proponeva «una introduzione [all’essere cristiani]: un’introduzione diversa o diversamente orientata non incorre nella scomunica, ma chiede invece un po’ di tolleranza».
La scomunica non è giunta, ma anche la tolleranza è rimasta latitante: poteva innescarsi un dialogo estremamente fecondo all’interno della Chiesa stessa, un dialogo magari anche aspro, che avrebbe però arricchito dal di dentro la comunità dei credenti alla quale Küng non ha mai smesso di appartenere. Invece si è acconsentito a un progressivo estraniamento della ricerca teologica di Küng dal cuore del messaggio cristiano e, soprattutto, dal contesto cattolico. Normale e positivo progresso di una ricerca teologica libera e indipendente? Forse è stato così dal punto di vista dell’autore.
Dal punto di vista della comunità cristiana, non solo cattolica, del suo cammino ecumenico, della sua ricerca di sempre maggiore fedeltà al Vangelo, si è trattato piuttosto dell’incrinarsi di una voce dovuta alla perdita di autorevolezza oggettiva (quella soggettiva è rimasta intatta, anzi, si è forse rafforzata): le posizioni di Hans Küng, così stimolanti per i cristiani di oggi e per l’uomo contemporaneo, non hanno più avuto come luogo di confronto e di risonanza la comunità cattolica in quanto tale.
Eppure i problemi sollevati nell’opera - il ruolo della parola di Dio, il significato del Gesù storico, la funzione dell’autorità, le modalità dell’esercizio del ministero presbiterale, ildialogo ecumenico e con le altre religioni, l’apertura al mondo... restano ineludibili ancora oggi e la riflessione teologica ha tuttora da guadagnare a tener conto dell’analisi acuta e tagliente di Küng.
Non a caso, la breve prefazione alla nuova edizione di Essere cristiani si chiude con la medesima frase posta a sigillo dell’edizione originale del 1974, affermazione definita dall’autore stesso «il mio credo»: «Seguendo Gesù Cristo l’uomo nel mondo d’oggi può vivere, agire, soffrire e morire in modo veramente umano: nella felicità e nella sventura, nella vita e nella morte, sorretto da Dio e fecondo di aiuto per gli altri». Sì, la sequela cristiana, il camminare sulle tracce di Gesù di Nazaret che ha narrato Dio può avere senso per l’uomo di ogni tempo e cultura, per la riscoperta dell’umanità che lo abita: colui che la fede confessa come «vero Dio e vero uomo» restituisce all’uomo la sua qualità e dignità più profonda.
-
>IL BENE E’ PIU’ DELLA FEDE. La fede è fare del bene, non dire "ho fede". “Ciascuno è la vera chiesa”. Intervista ad Ermanno Olmi (di Arianna Prevedello)3 marzo 2012, di Federico La Sala
“Ciascuno è la vera chiesa”
intervista ad Ermanno Olmi
a cura di Arianna Prevedello (“settimana” - attualità pastorale, 4 marzo 2012)
“Cinema, specchio della vita” è il titolo di una serie di iniziative della diocesi di Padova che, attraverso la "settima arte", mette a confronto registi, presbiteri e operatori pastorali su tematiche di forte attualità per la comunità ecclesiale. Ecco un estratto del primo incontro avvenuto il 13 febbraio. Successivamente alla proiezione de Il villaggio di cartone i presbiteri diocesani hanno intensamente dialogato con il regista Ermanno Olmi.
 Maestro Olmi, lei è uno sposo da tanti anni, eppure con questo film ha saputo raccogliere il sentimento interiore di moltissimi sacerdoti. Dove ha trovato ispirazione?
Maestro Olmi, lei è uno sposo da tanti anni, eppure con questo film ha saputo raccogliere il sentimento interiore di moltissimi sacerdoti. Dove ha trovato ispirazione?Non si sa mai da che parte arrivi l’ispirazione. È come quel vento dello Spirito che non si sa da dove viene e dove vada. Pensate quando, alla fine di alcuni appuntamenti di tipo culturale, ci accorgiamo di aver ascoltato cose interessanti fuori dalla nostra aspettativa.
Quando Picasso disse «vorrei dipingere come i bambini», intendeva dire che i bambini non hanno la consapevolezza necessaria ad amministrare la loro potenzialità comunicativa. Sentono l’esigenza di comunicare senza preoccuparsi della forma. Dovremmo arrivare all’età della libertà, come per esempio la mia, attrezzati in questo senso e pretendendo di essere ascoltati con l’innocenza dei bambini. Quindi, l’ispirazione non sai da dove arriva. Arriva, e senti che lì ci sono domande che ti poni e tenti di dare alcune risposte, ma non è mai "la" risposta. Il modo di pronunciare una frase cambia il senso di ciò che vuoi comunicare. Pur essendo rigidamente confezionata in un testo, la frase cambia di significato a seconda di come tu cambi. Lo stesso Vangelo cambia a seconda di come noi cambiamo. Nel momento in cui non lo leggiamo più perché pensiamo di conoscerlo o di poterlo ripetere a memoria, quello è il momento del fallimento. È come se, amando una persona, dicessimo «adesso non ho più parole d’amore». Quando senti che non hai più parole, vuol dire che hai perduto quell’amore.
La religione si basa come intima convinzione su alcuni principi che abbiamo ascoltato, condiviso e che ora manteniamo vivi. È davvero così se ogni giorno, leggendo una frase di quella religione, sentiamo che quella frase cambia significato. Altrimenti è un fatto puramente amministrativo e, se fossi il Padre eterno, mi incavolerei, perché ha dato la possibilità di vivere la realtà come la più bella opportunità di scoperta delle grandi manifestazioni che abbiamo sotto gli occhi. Altrimenti le religioni rischiano di essere delle gabbie mortificanti.
Perché un film come il suo è scomparso subito dalle sale?
Il problema non è che questo film è scomparso dalle sale, ma che capita a questo film e a molti altri film più belli del mio, come il Faust, Leone d’Oro a Venezia, o Una separazione, Orso d’Oro a Berlino. In realtà, nell’ultima stagione ci sono state produzioni italiane che hanno incassato bene e che rispetto ma sono tutti film di genere "spensierato".
Le persone cercano rifugio in occasioni - e lo capisco - che non danno il tempo di soffermarsi sulla gravità di problemi che dovremo arrivare ad affrontare. Prima di tutto la chiesa! Nel vedere ogni giorno la realtà che abbiamo intorno, per alcune cose pensiamo di poter rispondere, per altre veniamo interrogati e non abbiamo risposte. Un’infinità di interrogativi irrisolti, e allora io chiamo il Maestro. Se tu, Cristo, fossi al mio posto, cosa faresti? Secondo voi, Cristo si preoccuperebbe del cattolicesimo o di quella religione del perdono per relazionarci agli altri, per renderci disponibili agli altri. Se io guardo il suo percorso, ogni giorno c’è sempre un insegnamento che mi riguarda.
Il cattolicesimo - come apparato - oggi è diventato forse troppo ingombrante. So che qualcuno non è d’accordo con me... e va bene. Non pretendo questo, ma mi domando qual è il cristianesimo di oggi. Tante volte dico ai cattolici: «ricordatevi che siete anche cristiani».
 Qual è oggi il modello di Cristo? Cristo ha chiamato Pietro e gli ha detto «chi dici che io sia?». Chi diciamo che sia questo Cristo? Un orpello appeso ai punti apicali delle volte delle chiese? O è quell’altro chenon osa entrare in chiesa perché non ha i panni adatti?
Qual è oggi il modello di Cristo? Cristo ha chiamato Pietro e gli ha detto «chi dici che io sia?». Chi diciamo che sia questo Cristo? Un orpello appeso ai punti apicali delle volte delle chiese? O è quell’altro chenon osa entrare in chiesa perché non ha i panni adatti?La chiesa di questo film è chiesa quando si è svuotata dagli orpelli, quando qualcuno che non è cristiano ha bisogno di aiuto. Gli devo chiedere «sei cristiano? cattolico? Allora entra, se no stai fuori...». Cristo dice «Tu che sei Pietro, tu sei pietra». Tu! Ciascuno di noi è la vera chiesa. C’è qualcosa che mi fa dire in questo momento: «Cristiani svegliamoci! È il nostro momento». È il momento di presentarci agli altri dicendo all’altro «Ecco il volto di Cristo!».
Quando rincasiamo, possiamo dire alla sera: oggi ho visto Cristo? Oppure, ho visto il ragioniere, l’architetto, il neretto all’angolo della strada? Quale volto di Cristo abbiamo visto in ogni giorno della nostra vita?
Ecco perché non rispondo a chi si preoccupa se sono o meno cristiano, io non mi preoccupo se loro lo sono. Mi basta guardarti, sei una creatura di Dio. E poi, quando ci innamoriamo, è il massimo. E l’estasi dell’umanità. Anche quel prete nel film che guarda gli occhi di una fanciulla. E perché no? Quanti preti innamorati infelici! Io credo che l’innamoramento sia una chiamata, certo che poi dobbiamo comportarci di conseguenza. Rispetto all’innamoramento, c’è un passaggio difficile da accettare: quando il prete dice al Cristo della piccola Pietà «sei troppo lontano nel tempo perché io possa amarti come dovrei». Ma che cosa, allora, si riconosce di quel piccolo Cristo? Anche Cristo ha conosciuto la solitudine dell’ultimo istante. Dio, che è venuto e ha parlato a profeti e ad angeli, non ha parlato a Cristo nel silenzio dell’ultimo respiro. Come mai? Avrebbe - credo - intaccata la santa, la sacra eroicità della donazione. Dobbiamo accettare la solitudine dell’ultimo respiro.
 Nel film il prete sintetizza tante epoche, stagioni e passaggi della vita. Alla fine cos’è diventato quel prete?
Nel film il prete sintetizza tante epoche, stagioni e passaggi della vita. Alla fine cos’è diventato quel prete?All’inizio il prete rimpiange il fatto che non sarà più quel prete lì, perché gli manca lo strumento della sua pratica sacerdotale. Quando non c’è più un fedele, lui fa quella predica alle panche vuote, si confida con esse. Dice «quante volte qui alla domenica, quando la chiesa era piena di fedeli... eppure ogni tanto avevo il dubbio!». Guai ad avere le certezze assolute. Ti siedi comodamente su queste certezze e rinunci alla tua vita come continua curiosità della riscoperta. Se qualcuno mi dice che crede in Dio, prega Dio, ama Dio in maniera così graniticamente definitiva, ho l’impressione che non conosca il termine amore. L’amore è una lotta continua, un travaglio che non ci dà tregua.
All’inizio il prete si accontentava di avere la chiesa piena di fedeli. Nel momento in cui essa diventa vuota, scopre che cosa significa essere prete. Anche grazie alle circostanze che è costretto a vivere con un gruppo di pellegrini erranti che sostano nella sua chiesa mettendo in piedi quel villaggio di cartone di chi è continuamente in cammino e che non è affatto di cartone. Di cartone sono i muri di cemento armato. Anche Cristo ci dice «non ho nemmeno una pietra su cui poggiare il capo».
Tutte cose di cui il prete non si poneva più una domanda, ma era fermamente convinto della giustezza delle risposte. Finalmente avverte l’idea del porsi la domanda. Quale volto di Cristo ho incontrato?
Tutti i giorni la medesima domanda, perché infinite sono le risposte. La risposta che il prete dà al sacrestano: «mi sono fatto prete per fare del bene. Ho capito che il bene è più della fede».
Perché il bene è più della fede? Lo dico in maniera grezza: quando recitiamo le nostre preghiere, abbiamo la sensazione di compiere un atto di fede; poco dopo usciamo ed abbassiamo lo sguardo senza guardare in faccia l’umanità. Allora la fede è fare del bene o è dire "ho fede"? Si riesce perfino a pregare pensando ad altro. Il prete a quel nero che lo ringrazia per averli accolti dice «anch’io sto tornando alla casa del Padre». Questo è l’atto di fede. Sapere che il Padre è lì che mi aspetta. Siamo tutti dei "figliol prodigo". L’importante è capirlo e tornare a lui.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ... --- Leadership carente e «incertezza di conduzione strategica». Crisi di un papato: Ratzinger, le riforme che non vuole (o non può) fare.3 marzo 2012, di Federico La Sala
Crisi di un papato
Secondo Politi, leadership carente e «incertezza di conduzione strategica»
Ratzinger, le riforme che non vuole (o non può) fare
di Andrea Tornielli (La Stampa/TuttoLibri, 03.03.2012)
- Marco Politi JOSEPH RATZINGER. CRISI DI UN PAPATO Laterza, pp. 328, 18
Politi, commentatore de Il Fatto Quotidiano, è stato per diciassette anni corrispondente vaticano di Repubblica e, prima ancora, del Messaggero. Ha scritto con il premio Pulitzer Carl Bernstein la biografia best-seller di Giovanni Paolo II «Sua Santità» (Rizzoli)
La tesi dell’autore è chiarissima fin dal titolo: Joseph Ratzinger. Crisi di un papato. Secondo il vaticanista Marco Politi, autore del saggio, quello di Benedetto XVI, a sei anni e mezzo dall’elezione, sarebbe dunque un pontificato «in crisi». Politi mette in fila e analizza tutti gli episodi «critici» che hanno caratterizzato il papato ratzingeriano, dalle reazioni al discorso di Ratisbona al caso Williamson, dalla risposta sul preservativo durante il viaggio in Africa del marzo 2009 allo scandalo dei preti pedofili.
L’autore riconosce le indubbie doti intellettuali e di predicatore del Pontefice tedesco, ne apprezza l’essenzialità del messaggio, giudica positivamente anche l’attività di scrittore e di teologo che Ratzinger ha continuato anche da Papa, attraverso i libri su Gesù di Nazaret: «Al di là della battaglia teologica», scrive Politi riferendosi al primo volume sul Nazareno, «il libro appare una splendida catechesi letteraria, un ritratto avvincente, un inno alla sequela di Gesù. Pagina dopo pagina il pontefice propone con essenzialità una spiritualità intensa, rigorosa, gioiosa». E riconosce anche una caratteristica peculiare di Benedetto XVI, l’umiltà: «Raramente un Papa ha espresso in maniera così toccante la propria fragilità», osserva Politi, riferendosi al libro-intervista nel quale il Pontefice racconta la sua reazione all’elezione e il suo rivolgersi a Dio per dirgli: «Tu mi devi condurre! Io non ce la faccio».
Ma Politi rivolge anche, pagina dopo pagina, una critica serrata al «governo» di Ratzinger e conclude che l’attuale papato appare caratterizzato da uno stallo delle riforme necessarie per la Chiesa e per la Curia romana. Come pure osserva la carenza di una visione geopolitica da parte della Santa Sede e un venir meno dell’incidenza che la voce vaticana aveva sulla scena internazionale fino a qualche anno fa, nonostante molti viaggi di Benedetto XVI - anche quelli considerati più difficili - riconosce l’autore, siano stati «coronati da grande successo».
Il Papa «si dedica scrupolosamente allo studio dei dossier che gli vengono sottoposti», ma «crisi dopo crisi, resta insoluta la questione della solitudine decisionale... Il cosiddetto deficit di comunicazione rimanda piuttosto ad una carenza di leadership» e a un’«incertezza di conduzione strategica».
È indubbio che le crisi del pontificato abbiano messo in luce reali problemi di governo (meglio, di assenza di governo) che non sono soltanto comunicativi, nonostante molti in Vaticano continuino purtroppo a pensare in modo auto-assolutorio che tutte le responsabilità siano dei giornali e dei giornalisti. È al contempo vero, però, che la figura e il magistero del Papa teologo sia ben più articolato e complesso di quanto vorrebbero farlo apparire certe semplificazioni tendenti a schiacciarlo sui cliché conservatori. Ed è probabile che alcuni aspetti indicati come negativi da Politi - ad esempio la minore incidenza geopolitica della Santa Sede - appartengano volutamente allo stile pontificale di un Papa più concentrato sulla comunicazione dell’essenziale della fede cristiana.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ----- "Attonito sbigottimento" vien da ripetere di fronte alle ultime vicende vaticane (di Giovanni Colombo - Aspettando Francesco I).1 marzo 2012, di Federico La Sala
Aspettando Francesco I
di Giovanni Colombo (“Il Margine”, febbraio 2012)
"Attonito sbigottimento" disse nel settembre scorso il Cardinal Bagnasco, Presidente dei vescovi italiani, di fronte alle ultime convulsioni del governo Berlusconi. "Attonito sbigottimento" vien da ripetere di fronte alle ultime vicende vaticane.
L’ inizio di febbraio è stato micidiale. Prima la pubblicazione delle lettere di fuoco scritte dall’attuale nunzio apostolico negli Stati Uniti, Mons. Carlo Maria Viganò, quand’ era segretario generale del Governatorato (l’ ente che gestisce lo Stato della Città del Vaticano), al Papa e al Cardinal Bertone, contenenti accuse di corruzione negli appalti e di malagestione dei soldi, affidata a banchieri che "fanno di più il loro interesse che i nostri" e che "hanno mandato in fumo in una sola operazione finanziaria nel dicembre 2009 due milioni e mezzo di dollari". Mons. Viganò si aspettava di diventare Cardinale e presidente del Governatorato e invece è stato mandato in America. La Santa Sede si è difesa con un lungo e dettagliato comunicato: "il Governatorato non è in balìa di forze oscure".
Poi le notizie riguardanti lo Ior, il forziere del Vaticano. Sta proseguendo con il coinvolgimento di 4 preti - l’ inchiesta della Procura di Roma sul trasferimento di 23 milioni, attraverso il Credito Artigiano, alla JP Morgan Frankfurt e alla Banca del Fucino. Secondo i giudici il trasferimento è avvenuto in violazione della normativa antiriciclaggio. Pare inoltre che, a seguito di questa inchiesta, lo Ior abbia deciso di spostare gran parte delle proprie attività finanziarie dalla banche italiane a quelle tedesche. Sempre lo Ior continuerebbe ad opporre resistenza all’ AIF (Autorità di informazione finanziaria, presieduta dal Cardinal Nicora) sulla piena applicazione delle nuove norme vaticane in tema di trasparenza.
Infine la fuga di notizie dalla Segreteria di Stato che ha reso pubblico un memorandum anonimo, presentato dal Cardinale colombiano, Darìo Castrìllon Hoyos, circa le confidenze che avrebbe fatto un altro Cardinale, Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, durante un viaggio in Cina del novembre scorso. Nel testo si legge che "Benedetto XVI avrebbe solo altri 12 mesi da vivere" e che "si starebbe occupando in segreto del suo successore: il Cardinale Scola". La gendarmeria vaticana sta indagando per scovare la "talpa".
L’ attonito sbigottimento fa tornare alla mente il testo scritto nel 2005 dall’ allora Cardinal Joseph Ratzinger per la via crucis del Giovedì Santo. Nona stazione, Gesù cade per la terza volta:
 " ... Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa? ...
Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di lui! Quante volte la
sua Parola viene distorta e abusata! Quanta poca fede c’è in tante teorie, quante parole vuote!
Quanta sporcizia c’ è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero
appartenere completamente a lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza!"
" ... Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa? ...
Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di lui! Quante volte la
sua Parola viene distorta e abusata! Quanta poca fede c’è in tante teorie, quante parole vuote!
Quanta sporcizia c’ è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero
appartenere completamente a lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza!"Parole dure come pietre, che forse hanno contribuito a spingerlo verso il soglio di Pietro. Ma adesso cosa sta succedendo? Siamo sempre lì, alla nona stazione, o la via crucis è andata avanti? In termini più mondani: stiamo assistendo ad una delle solite partite di potere, giocate con stile cattivo, dalle fazioni opposte d’ Oltretevere, di cui la storia della Chiesa è piena fino alla nausea, oppure questi episodi dicono qualcosa di più: la frana di un impianto ecclesiastico millenario, in moto da anni e anni, ma che ora ha preso la discesa con velocità sempre più crescente? Motus in fine velocior. Il 18 febbraio scorso mia moglie ed io abbiamo deciso di andare a vedere di persona com’ è la situazione. Siamo scesi a Roma per partecipare al concistoro. Fra i 22 nuovi cardinali c’ è pure lui, il prete che ha celebrato le nostre nozze e battezzato i nostri figli. Quindi non potevano assolutamente mancare al grande appuntamento.
Alle 9.30 attraversiamo Piazza San Pietro dove l’ 8 dicembre 1965 Paolo VI, chiudendo il Concilio Vaticano II, disse che quello che conta è l’homo integer, l’ uomo completo, quello che cammina eretto. Eretti entriamo nella Basilica di San Pietro dove l’ 11 ottobre di 50 anni fa Giovanni XXIII l’ aprì, il Concilio, con il celebre discorso Gaudet Mater Ecclesia, in cui criticò i profeti di sventura.
Alle 10.30 gli squilli di tromba danno inizio alla cerimonia e la mia mente s’ eleva ad Deum, pardon inizia a svolazzare per la navata e a farsi una serie di domande.
Perché sono tutti maschi?
Metà della Basilica è occupata dal Collegio cardinalizio e da molti vescovi. Son tutti maschi. Non è una novità. Ma si può continuare a vivere così? Si può continuare a tenere lontane le donne? Ormai, a cinquant’ anni, posso confermarlo per esperienza: gli uomini hanno paura delle donne. Non so quando inizi il timore, forse inizia proprio all’ inizio, appena ci si accorge che si è rotta per sempre la fusione originaria con la propria madre. Questa paura accompagna noi uomini tutti i giorni e crediamo di scacciarla coi giochi di seduzione o mostrandoci forti nelle guerre e nel lavoro. Ma non la superiamo mai realmente e così ci condanniamo a non conoscere quasi nulla di noi stessi, a non gustare quasi niente della vita e di Dio. Perché sono molto vicini: la donna, la vita e Dio. Le Chiese, tutte le Chiese, essendo fatte da uomini, cercano di addomesticare le donne - e la vita e Dio - definendo bene le posizioni. Uomo è colui che ha la presidenza, che sta sopra, al suo posto d’uomo, che vi sta con gravità, con serietà, ben al caldo della sua paura. Donna è colei che sta sotto, anzi non sta da nessuna parte, non occupa altro posto se non quello, sempre mobile e marginale, del servizio e della cura. Questa differenza è stata praticata per millenni ma può essere superata in un istante. Basta un movimento, un semplice movimento fuori dal posto, dalle gerarchie imposte dalla legge o dal costume, senza più l’ ossessione di cadere e di diventare nessuno. E finalmente s’ avvia la relazione, quella relazione sempre negata ( o praticata di nascosto in qualche breve momento subito interrotto), in cui non si capisce più chi sta sopra e chi sta sotto ma in cui si capisce molto bene quello che sta avvenendo: l’ aiuto reciproco a conoscersi e a vivere in pace e in Dio. La Chiesa di Roma, a differenze di altre Chiese, fa riferimento al Cristo e vuole rimanere fedele al Cristo, lo sta ripetendo anche adesso il Papa durante l’ omelia: ma nessuno più del Cristo ha fatto saltare le posizioni e ha rivolto il suo viso verso le donne, come ci si china sull’ acqua di un fiume per attingervi forza e volontà di proseguire il cammino. Le donne nel Vangelo sono altrettanto numerose degli uccelli. Sono là all’ inizio e sono là alla fine. Sono le apostole della resurrezione. E come mai non se ne vede neanche una tra questi marmi?
Perché son tutti vecchi?
Anche questa non è una novità. Sono i vecchi quelli che guidano la Chiesa. La vecchiaia è sinonimo di saggezza. Ma proprio in tema di saggezza, quanta ce n’è in quel proverbio indiano che parla dei quattro stadi nella vita di un uomo! Nel primo stadio si impara. Nel secondo si insegna e si servono gli altri, mettendo a frutto quello che si è imparato. Nel terzo si va nel bosco, a far silenzio e meditare su quant’ è successo. Nel quarto si impara a mendicare. Lasciamo stare per un momento quest’ ultima fase. La mendicità, il dipendere dagli altri, se da una parte è il sommo della vita ascetica, dall’ altra è l’ infimo che non vorremmo mai sperimentare (ma che spesso viene, e al quale bisogna prepararsi per tempo). Fermiamoci ai primi tre. In quale stadio si dovrebbero trovare queste neo berrette rosse e la stragrande maggioranza degli altri celebranti? Direi nel terzo. E lo stadio buono per il ritiro nel bosco, dove riordinare i ricordi e ripensare con gratitudine a tutte le cose ricevute e a tutte le persone incontrate. La fase in cui tornare a rileggere la Bibbia con calma, senza lo stress di dover preparare la predica perfetta. La fase in cui mettersi a disposizione per il colloquio con l’altro: noi siamo colloquio e il colloquio è l’ esperienza umana-divina per eccellenza. Invece in molti hanno ancora incarichi assai importanti, da secondo stadio, che non mollano, come se il mollare fosse il segno di una qualche infedeltà. Alcuni addirittura dimostrano un attaccamento al proprio posto e un dinamismo tale nell’ interpretare il proprio ruolo da far invidia a un quarantenne.
Ma se il calendario segna i settanta e passa è tempo di vivere un sereno distacco dalle scene di questo mondo. Non serve più a niente aspirare ad ulteriori livelli di carriera. Ora la prossima ascensione, per la quale prepararsi a puntino, è unicamente verso il Cielo. Non possiamo fare qualcosa di più per seguire la saggezza del proverbio indiano? In termini mondani: la responsabilità, la dirigenza dai 45 ai 65 anni, poi ministra Fornero permettendo - in pensione. In termini ecclesiastici, idem: l’ episcopato, con ruoli di governo, dai 45 ai 65 anni, poi nel bosco. E per quanto riguarda i cardinali... ma son proprio necessari? Il Concilio Vaticano II non dedica loro neppure una riga. E allora noi cosa ci facciamo qui?
Perché son (quasi) tutti grassi?
Li guardo, i cardinales, guardo i loro corpi. E il corpo a mostrare, è il corpo a parlare più di un’ enciclica. E il corpo la nostra guida costante, troppo spesso lo dimentichiamo e non lo ascoltiamo anche là dove le decisioni non riguardano azioni banali ma scelte decisive per il nostro destino. Ritrosie, silenzi, malattie, mancamenti, entusiasmi, vibrazioni: sono tutti i segni di una saggezza più profonda delle nostre ragioni consapevoli, diceva Nietzsche e confermano i dottori olistici. Con tutta probabilità questi Cardinali sono cresciuti con un’ altra impostazione, in cui il corpo è soltanto un asino, un mezzo di trasporto. Francesco d’ Assisi lo chiamava proprio così: fratello asino . Ma conviene sempre ascoltarlo, l’ asino, o meglio l’ asina, come nel caso di Baalam. Nella pagina biblica l’ asina parla. Racconta la visione dell’ angelo, per tre volte la volontà di Dio d’ impedire a Baalam il compimento del suo infame disegno. E alla fine Baalam comprende e rinuncia. Chissà cosa starà dicendo ora l asina su cui stanno seduti questi principi della Chiesa. Forse parole del genere: sono grassa perché sto ferma tutto il giorno nelle sacre stanze. Sono grassa perché accumulo senza bruciare. Sono grassa perché non ti sei mai occupato di me. Anche se ormai son vecchia, non ho perso la voglia di andare, quando vado sputo veleni e incamero pensieri, bevo il doppio e mangio la metà, sperimento un lavacro rigeneratore. Dài, facciamo come nostro padre Abramo, che non ebbe paura di accogliere l’ invito: Lekh lekhà, vattene. Partiamo come lui, verso l’ inedito. E preghiamo che sia lunga la via, colma d’ avventure, colma di conoscenze.
Perché sono vestiti così?
Certo che camminare vestiti in questa maniera non è mica facile. Premetto che non ho nessuna competenza di paramenti liturgici. So per esperienza umana che il vestito è importante. Lo sanno tutti gli innamorati. Mi son fatto bello, per andare bello da un bello , dice Socrate nel Simposio. Io devo assomigliare a chi amo. Faccio il maggior numero possibile di cose come l’ altro, di più voglio essere l’ altro, voglio che lui sia me, uniti, rinchiusi nel medesimo sacco di pelli. Il vestito non è altro che l’ involucro che esprime il mio immaginario amoroso. Do per scontato che anche il vestito del papa e dei cardinali siamo vestiti d’ amore per il nostro Dio e non strumenti per darsi importanza agli occhi del mondo. Ma non basterebbe in questo caso una bella veste bianca di bucato? Questi paramenti pesanti sembrano il retaggio di una visione di Dio potente e avvolgente, fin troppo potente, fin troppo avvolgente, tanto da ridurre il corpo dei suoi seguaci in prigionia. Il corpo di questi cardinali è fasciato, appesantito dalle vesti, sacrificato. Forse per qualcuno va bene così, non avverte il problema, anzi potrebbe rispondere irritato: "Queste vesti sono belle, belle anche se pesanti, perché bello, bello anche se pesante, è il nostro Dio" . Ma in generale il discorso non dovrebbe prendere una piega diversa? Se è il nostro Dio è vento sottile e sua salvezza la nostra liberazione, non dovrebbero saltare le cinture e scomparire le sottane?
L’ attuale vestiario non solo appare fin troppo debitore delle usanze rinascimentali e barocche ma soprattutto sembra trasmettere un visione distorta del rapporto con l’ Amato. Può esser utile domandarsi com’ erano vestiti gli apostoli. Non andavano in giro mezzi nudi? E Gesù? Non mise né la pianeta, né la casula, nè il camice, né la berretta, né l’ anello d’ oro. Nel momento decisivo si mise un grembiule.
Perché non risparmiamo sulla luce?
Stamattina affari doro per l’ Enel. C’ è tanta, troppa luce, dentro la Basilica sembra acceso un sole artificiale. E perché invece di essere contento mi viene da dire alla Conrad "nessuna gioia nello splendore del sole" ? Non è che il problema di questa Chiesa è di volere, con la sua dottrina e la con la sua presenza, una visibilità totale? I contorni devono essere sempre ben definiti, altrimenti potrebbero intrufolarsi pensieri eretici e immagini pericolose. Si pensa di trasmettere più nitidamente i significati e di realizzare la comunicazione perfetta della verità non lasciando nessun intervallo tra gli spazi. Però se tutto viene occupato da quello che arriva dall’ esterno, ciò che risiede all’ interno è costretto a rimanere inespresso. In linguaggio psicoanalitico: repressione. Diventiamo prigionieri dei riflettori, alla mercé degli occhi. Gli occhi possono diventare entità persecutorie. Non a caso gli dei crudeli hanno gli occhi sempre aperti senza palpebre: non li chiudono mai, non dormono mai. Ma coloro che vedono sono ciechi e solo i ciechi possono vedere... Le meditazioni vanno fatte al buio, così con il favore delle tenebre posso apparire timidamente le creature che popolano le nostre foreste e i nostri mari. Le cerimonie hanno bisogno di nuvole e nebbie, che gentilmente velino le alogene. L’ hanno già detto in tanti nel corso della storia, anche tanti santi e tanti papi, eppure fatichiamo a crederci. La verità è sempre al di là del visibile. Scorre sotterranea, dimora nell’ oscurità coperta dalla nebbia, circondata dal silenzio. Spegniamo dunque la luce e chiudiamo gli occhi e mettiamoci in attesa. "Ascolta, mio cuore...ascolta l’ ininterrotto messaggio che dal silenzio si crea. Ecco fruscia qualcosa ... e viene a te" (Rilke).
Il Papa sta bene?
Vedendolo dal vivo direi di sì. Lo trasportano in pedana. La sua faccia è un po’ stanca. Però è lucido e presente. La predica lo dimostra. E lo conferma la sua agenda, che prevede, per il prossimo 23 marzo, la partenza per il viaggio apostolico in Messico e a Cuba, poi, a giugno, la presenza a Milano per il VII Forum mondiale delle famiglie e, a settembre, la visita in Libano. E se qualche malvagio volesse ucciderlo, secondo la "profezia" del memorandum? Le misure di protezione sono altissime e dovrebbero dare garanzia assoluta.
Certo, Benedetto XVI compirà tra poco 85 anni, ha cinque bypass al cuore, ha sulle spalle sette anni di pontificato, quindi è arrivato alla sera del suo lungo giorno. E la sera è fatta per pregare (vedi quanto detto sopra per i vecchi). Se a questo punto il Papa diventasse preghiera mollando tutto il resto? Quello che doveva scrivere come teologo l’ ha scritto, quello che doveva dire come pastore l’ ha detto. Silenzio, il Papa prega! Pensate che messaggio spiazzante per questo mondo che si agita con il suo fare sconclusionato. E non ci sarebbe modo migliore per spiegare ai nostri figli che significhi davvero "non di solo pane vive l’ uomo". Col pane campiamo. Ma è di ben altro che viviamo. Noi viviamo di quel Vento che ci fa costantemente rinascere.
Mi piacerebbe vedere il Papa esposto senza sosta al Vento a invocare il rinascimento. "Devi rinascere dall’ alto", è una delle più belle parole dette da Gesù nel Vangelo. L’ invito, rivolto a Nicodemo, vale in ogni epoca sia per i singoli sia per la Chiesa intera. Questa Chiesa superaccessoriata e pesante come il marmo è chiamata a perdere potere, sicurezze, abitudini per rinascere leggera, con il volto migliore.
Arriverà Francesco I ?
Sì. Dopo tanta preghiera del Papa e, modestamente, anche di noi laici, si può star sicuri che arriverà. Sarà lui il volto migliore. Non conosciamo ancora il colore, se bianco o nero (per il giallo stanno lavorando in tanti, c’è un proliferare di viaggi di ecclesiastici in Cina, ma la questione pechinese ha tempi troppo lunghi perché si risolva prima dell’ avvento desiderato). Però conosciamo già il nome. Si chiamerà Francesco. Sarà Francesco I.
Il giorno dopo l’ elezione, affiderà all’ Unesco, quali siti artistici e turistici, i Palazzi Vaticani, metterà in vendita Castelgandolfo, chiuderà lo Ior affidando i soldi alla Banca popolare etica. Abiterà per lunghi mesi a Assisi e scenderà a Roma - in treno - per celebrare i riti principali nella "vera" cattedrale del vescovo di Roma, quella di San Giovanni in Laterano. Molte cerimonie le farà all’ aperto, sul Monte Subasio o su culmini di colline dove non s’ innalza alcun tempio. Inviterà a sedersi rispettosamente sull’ erba. A prendersi le mani tra sconosciuti per storie personali ma ben noti per comune origine. Ad adorare in spirito e verità.
Ridurrà la struttura istituzionale al minimo, con una drastica diminuzione del terziario ecclesiastico (il Concilio Vaticano II voleva snellire la Corte papale ma da allora l’ Annuario pontifico ha triplicato le sue pagine). Toglierà il celibato obbligatorio: più piacere, meno ipocrisie. Ordinerà le donne, ma le donne lo vorranno? Non è per nulla scontata la loro disponibilità, dovrà riconquistarle. Darà le dimissioni a 80 anni. Abolirà definitivamente icardinales. D’ ora in poi i grandi elettori del Papa saranno i rappresentanti delle conferenze episcopali. Scriverà un’ unica enciclica dal titolo: In nuditate, Domine. In essa chiederà perdono di tutte le volte che il cattolicesimo è stato potere persecutorio su coscienze coartate, finzione autoritaria e violenta della verità, pretesa di non errare smentita incessantemente dai fatti. Nel testo elencherà i dogmi, le norme morali e i canoni del Codice di diritto canonico da gettare nel biondo Tevere. Tolto il fasullo, tolto l’inutile, Gesù di Nazareth tornerà ad affascinare. Sarà di nuovo possibile incontrarlo e seguirlo. Nudus nudum Christum sequi.
Finisce la cerimonia, finiscono le domande. Sono sette, sette come i colli di Roma, sette come i vizi capitali, sette come le opere di misericordia spirituale che sommate a quelle di misericordia corporale fanno 14 come l’ora in cui riusciamo finalmente ad abbracciare il neo-porporato. Felicitazioni vivissime. L’ affetto ha il sopravvento e cancella ogni altra elucubrazione. Volete sapere chi è? No che non parlo, non faccio la talpa, io. E non voglio stroncargli la carriera accomunandolo con un extra-vagante come me. Però, a pensarci bene, più in alto di così dove può arrivare? Non insistete, il cognome non ve lo dico. Ma provate a chiamarlo Francesco e vi risponderà.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- IL VATICANO E LA RESA DEI CONTI (di Marco Politi)29 febbraio 2012, di Federico La Sala
Il Vaticano e la resa dei conti
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 29 febbraio 2012)
Ha il sapore di un fine-regime la lotta di potere scatenatasi all’interno del Vaticano. Perché scontri e bracci di ferro sotterranei sono sempre avvenuti nel Palazzo apostolico. Ma l’asprezza degli attacchi rivolti al segretario di Stato, in un crescendo che pare inarrestabile, rivela che all’interno della Curia ci sono gruppi e persone che - con il pontefice ormai in età avanzata e l’evidente mancanza di direzione della barca di Pietro - ritengono necessario arrivare a un nuovo assetto ai vertici della Santa Sede. La novità assoluta è che non si procede, come in altre stagioni, per insinuazioni o messaggi tenuti rigorosamente segreti. Di fronte alla stagnazione, in cui si sta arenando il pontificato ratzingeriano, ci sono forze che hanno deciso di portare tutto alla luce del sole, di svolgere questa battaglia sul palcoscenico dei mass media, di rendere chiara anche la posta in gioco: una svolta nell’amministrazione delle finanze, nei rapporti tra Vaticano e Chiesa italiana, nelle relazioni tra il segretario di Stato e i cardinali. Non ci sono (più) “corvi” in questa storia. Ci sono combattenti clandestini.
Il carteggio Bertone-Tettamanzi pone sotto la luce dei riflettori i punti più vulnerabili del governo bertoniano.
Primo, un assolutismo che i suoi avversari denunciano come centralismo senza autentica managerialità: poiché procede per scatti di improvvisazione e crea opposizione laddove dovrebbe lavorare per la massima coesione dell’apparato su linee strategiche condivise.
Secondo, la tendenza a scavalcare sistematicamente i confini del proprio ambito. Il segretario di Stato ha in cura la strategia della Chiesa universale. Invece, sottolineano i suoi oppositori, lo si è visto occuparsi di un fantomatico polo ospedaliero ecclesiastico italiano (caso San Raffaele). E ancora, l’Istituto Toniolo riguarda la Chiesa italiana, idem l’Università Cattolica. Non erano certo in ballo questioni dottrinali di massimo rilievo, tali da provocare un intervento del Papa.
Assistere a un segretario di Stato, che pone e dispone a suo arbitrio, per puri disegni di potere è diventato allarmante in certi ambienti ecclesiastici e - per alcuni - talmente intollerabile da avere voluto informare l’opinione pubblica della sconfitta subita da Bertone dopo l’appello diretto del cardinale Tettamanzi al pontefice, come risulta dalle lettere pubblicate ieri dal Fatto.
D’altronde al momento del cambio della guardia alla presidenza della Cei tra Ruini e Bagnasco il cardinale Bertone si è arrogato per lettera l’alto comando delle relazioni con la politica italiana, scavalcando la dirigenza della conferenza episcopale. Ma viene il momento in cui qualcuno e più d’uno presenta il conto.
Già nel 2009, all’indomani del disastroso caso Williamson (il vescovo lefebvriano negazionista cui venne tolta la scomunica) e dell’altrettanto penoso caso Wagner (un prete reazionario austriaco nominato vescovo e poi costretto a rinunciare in seguito alla protesta dei cattolici e dell’episcopato d’Austria) alcuni porporati di rilievo avevano posto a Benedetto XVI la questione di un avvicendamento di Bertone.
Quando in aprile, nella residenza di Castelgandolfo, i cardinali Scola, Schoenborn di Vienna, Bagnasco e Ruini interpellarono il pontefice, la risposta lapidaria risposta fu, in tedesco: “Der Mann bleibt wo er ist, und basta”. L’uomo resta dove sta, e basta! Pochi mesi dopo Benedetto XVI fece pubblicare sull’Osservatore Romano uno sperticato elogio per il “grande impegno e la perizia” dimostrati dal segretario di Stato.
Ora il vento è cambiato. Il suo braccio destro, ricordano quotidianamente i suoi silenziosi, ma attivi antagonisti, ha commesso in pochi mesi due errori capitali su un terreno, che papa Ratzinger considera sensibilissimo per il prestigio internazionale della Santa Sede. Bertone ha cacciato Viganò dopo che questi aveva denunciato storie di corruzione riguardanti appalti in Vaticano. Bertone ha frenato la strategia di trasparenza finanziaria della banca vaticana perseguita dal cardinale Nicora e dal direttore dello Ior Gotti Tedeschi. Due autogol micidiali per la Santa Sede.
Sono errori che avvelenano l’atmosfera. La cosa più pericolosa per il segretario di Stato è che i favorevoli a un suo avvicendamento si trovano sia nel campo conservatore sia in quello riformista.Anche tra i ratzingeriani di ferro. Si avverte il senso di un silenzioso accerchiamento. Mentre qualche monsignore già si avvicina al “candidato-segretario” cardinale Piacenza. Anche perché la guerra dei documenti non è destinata a finire.
In un cassetto c’è un messaggio di Bertone al premier Monti - nelle ore frenetiche della formazione del governo a dicembre - per raccomandare a un posto di sottosegretario il suo pupillo Marco Simeon, già paracadutato come direttore di Rai Vaticano e responsabile delle relazioni istituzionali e internazionali. Un Segretario di Stato vaticano, che chiede un posto di sottosegretario per un suo protetto al presidente del Consiglio italiano? Che c’azzecca, direbbe Di Pietro.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- Bertone si vantò con Tettamanzi: il papa vuole cacciarti (di Marco Lillo)29 febbraio 2012, di Federico La Sala
Bertone si vantò con Tettamanzi: il papa vuole cacciarti
di Marco Lillo (il Fatto Quotidiano, 28 febbraio 2012)
Le lettere che il Fatto pubblica oggi in esclusiva, descrivono una situazione inedita al vertice della Chiesa. Il braccio destro del Papa, il segretario di Stato Tarcisio Bertone, si arroga il diritto di parlare a nome di Benedetto XVI e, forte di questo mandato, nel marzo del 2011 arriva a licenziare su due piedi il presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo, un cardinale autorevole come Dionigi Tettamanzi, allora arcivescovo di Milano e accreditato dalla stampa nel 2005 come un possibile successore di Giovanni Paolo II.
Per tutta risposta Tettamanzi scrive a Benedetto XVI per chiedergli di sconfessare Bertone annullando la sua decisione. E, colpo di scena, la sconfessione di fatto si realizza. Nonostante il rinnovo dei vertici del Toniolo fosse stato già comunicato ufficialmente al successore in pectore, Giovanni Maria Flick, un anno fa. La vicenda era stata già narrata a grandi linee nella primavera scorsa, ma nessuno aveva mai letto le lettere dei due cardinali. L’oggetto della lettera di “licenziamento” per Tettamanzi non era il posto di arcivescovo di Milano, che nel giugno 2011 sarà poi assegnato ad Angelo Scola, ma la presidenza dell’Istituto Toniolo, uno dei maggiori centri di potere in Vaticano, che controlla il Policlinico Agostino Gemelli di Roma e l’Università Cattolica con gli atenei di Brescia, Cremona, Piacenza, Roma e Campobasso, oltre alla casa editrice Vita e pensiero e numerosi beni immobili in tutta Italia più altre proprietà intestate a società commerciali.
Il Toniolo è sempre stato uno snodo dei rapporti tra politica e Chiesa, dai tempi in cui il suo consiglio includeva Oscar Luigi Scalfaro ed era presieduto dall’ex presidente del Consiglio Emilio Colombo. Nel 2003 Dionigi Tettamanzi, da poco nominato arcivescovo di Milano, fu spedito da Giovanni Paolo II a presiedere l’istituto proprio per togliere dall’imbarazzo il Vaticano dopo il coinvolgimento di Colombo, come consumatore, in un’inchiesta sullo spaccio di cocaina a Roma.
Quando nel marzo 2011 Bertone intima brutalmente a Tettamanzi di levare le tende entro due settimane, nemmeno fosse la sua colf, il cardinale ha già i nervi tesi perché si sente nel mirino di una campagna diffamatoria partita con una serie di lettere velenose sui giornali che gli imputano la presunta mala-gestio familistica del direttore amministrativo della Cattolica, Antonio Cicchetti. E proprio nella lotta per il controllo del Toniolo molti iscrivono anche la pubblicazione, sempre nel 2010, della velina falsa e calunniosa contro l’ex direttore dell’Avvenire Dino Boffo, consigliere del Toniolo vicino al presidente della Cei Angelo Bagnasco e al suo predecessore Camillo Ruini.
Quando Tettamanzi, il 26 marzo del 2011, legge il fax con la lettera di licenziamento nella quale Bertone gli intima di lasciare il posto al professor Flick e di non fare nomine prima dell’arrivo del successore, l’arcivescovo reagisce come una belva ferita. Tettamanzi scrive al Papa una lettera nella quale sostanzialmente insinua che Bertone non avesse l’investitura papale, da lui millantata, per cacciarlo e chiede a “Sua Santità” di essere confermato. Detto fatto. Il Papa, dopo avere ricevuto Bertone il 31 marzo e Tettamanzi il 30 aprile, lascia quest’ultimo al suo posto (e lì si trova tuttora a distanza di quasi un anno). L’aperta sconfessione di Bertone non viene accolta bene dal segretario di Stato che da allora medita la rivincita.
Il primo scricchiolio dell’equilibrio precario raggiunto dopo il braccio di ferro si è avvertito qualche settimana fa quando nel consiglio del Toniolo è entrato il cardinale Angelo Scola. Probabilmente Bertone ha pensato di dare scacco matto a Tettamanzi mettendo in campo un uomo stimato dal Papa ma che non è considerato un suo fedelissimo. Il cardinale ciellino Angelo Scola però non è certo paragonabile al laico ed ex ministro prodiano Flick. La sostituzione del progressista Tettamanzi con un arcivescovo vicino alle posizioni del Pdl (anche se recentemente ha preso le distanze dai seguaci lombardi di don Giussani) sarebbe una piccola rivoluzione negli equilibri del potere Vaticano esarebbe vista come una presa da parte dei conservatori di un feudo dei moderati non berlusconiani. Per questo, nonostante risalgano a quasi un anno fa, le lettere (che pubblichiamo in parte sotto e integralmente sul sito www.ilfattoquotidiano.it ) conservano una grande attualità.
IL FAX del segretario di Stato del 26 marzo 2011 e la missiva di Tettamanzi al Papa del 28 marzo sono la prova migliore della situazione anomala in cui versa oggi il vertice della Chiesa. Il segretario di Stato si arroga sempre più spesso i poteri del Santo Padre e agisce con lo stile di un capo azienda. Dall’altro lato i cardinali più autorevoli, come Tettamanzi, e i monsignori più orgogliosi, come Carlo Maria Viganò, si ribellano ai diktat di Bertone. E il risultato è un governo schizofrenico che oscilla tra autarchia e anarchia. Mentre Benedetto XVI si isola negli studi e nella scrittura dei libri, alle sue spalle si svolge una lotta di potere senza esclusione di colpi che danneggia l’autorità morale della Chiesa dentro e fuori le mura leonine.
Ratzinger mi dice che devi lasciare (lettera di Bertone a Tettamanzi)
di Tarcisio Bertone
del 24 marzo 2011
Signor Cardinale, circa otto anni or sono Ella, accogliendo con encomiabile zelo e generosa disponibilità la richiesta che Le veniva fatta, accettò per un biennio la nomina a Presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.(...). Di fatto, l’impegno di Vostra Eminenza a servizio dell’Istituto Toniolo si è protratto ben oltre il tempo originariamente previsto, e questo ovviamente a prezzo di ben immaginabili sacrifici (...) Ora, essendo scaduti alcuni Membri dei Comitato Permanente, il Santo Padre intende procedere a un rinnovamento, in connessione col quale Vostra Eminenza è sollevata da questo oneroso incarico. Adempiendo pertanto a tale Superiore intenzione, sono a chiederLe di fissare l’adunanza del Comitato Permanente entro il giorno 10 del prossimo mese di aprile. In tale circostanza. (...) Contestualmente indicherà il Prof. Giovanni Maria Flick, previa cooptazione nel Comitato Permanente, quale Suo successore alla Presidenza. Il Santo Padre dispone inoltre, che fino all’insediamento del nuovo Presidente, non si proceda all’adozione dì alcun provvedimento o decisione riguardanti nomine o incarichi o attività gestionali dell’Istituto Toniolo. Sarà poi compito del Prof. Flick proporre la cooptazione dei membri mancanti nell’Istituto Toniolo, indicando in particolare il prossimo Arcivescovo pro tempore di Milano e un Prelato suggerito dalla Santa Sede. In previsione dell’avvicendamento indicato, questa Segreteria di Stato ha già informato il Prof. Flick, ottenendone il consenso. Non c’è bisogno che mi soffermi ad illustrare le caratteristiche etiche e professionali che raccomandano questa illustre Personalità, ex allievo dell’Università Cattolica del Sacro. Cuore, oggi nelle migliori condizioni per assumere la nuova responsabilità in quanto libero da altri incarichi. (...)
Ma il cardinale parla a nome tuo? (Lettera di Tettamanzi a Ratzinger)
di Dionigi Tettamanzi
Beatissimo Padre, sabato 26 marzo mattina per fax è arrivata alla mia attenzione, in qualità di Presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, una lettera “riservata - personale” del Segretario di Stato, che mi induce (...) a sottoporre direttamente alla Sua persona alcune spiacevoli considerazioni. La lettera in oggetto prende le mosse dalla mia nomina a Presidente dell’Istituto nel 2003, pochi mesi dopo il mio ingresso a Milano, sostituendo il Sen. Emilio Colombo, dimissionario non tanto a causa di modifiche statutarie, come affermato nello scritto, ma per più consistenti ragioni legate alla sua condotta personale e pubblica (...) L’accenno a un originario ’’biennio" di carica, anch’esso senza alcun riscontro, e a un tempo di governo prolungato è l’unico motivo che viene addotto per procedere immediatamente nella coazione al mio dimissionamento (...) Annoto a margine che il candidato (Giovanni Maria Flick Ndr), sul cui profilo gravano non poche perplessità, sorprendentemente è già stato avvisato della cosa da parte della Segreteria di Stato. Tutte queste sanzioni (...) sono direttamente ricondotte all’esplicito volere di Vostra Santità, cui lo scritto fa continuamente riferimento. Ben conoscendo la mitezza di carattere e delicatezza di tratto di Vostra Santità e avendo serena coscienza di avere sempre agito per il bene dell’Istituto e della Santa Chiesa, con trasparenza e responsabilità e senza avere nulla da rimproverarmi, sorgono in me motivi di profonda perplessità rispetto all’ultima missiva ricevuta e a quanto viene attribuito direttamente alla Sua persona (...) Nell’ultimo anno l’Istituto Toniolo è stato oggetto di attacchi calunniosi, anche mediatici, a causa di presunte e non dimostrate inefficienze amministrative e gestionali, apostrofate con l’espressione di mala gestio. Nulla di tutto questo! (...) (...) Ma lascio a Lei di confermarmi con una Sua parola
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- Guerre vaticane. Tutta la rabbia di Bertone (di Luca De Carolis)1 marzo 2012, di Federico La Sala
Guerre vaticane
Tutta la rabbia di Bertone
di Luca De Carolis (il Fatto Quotidiano, 1 marzo 2012)
Sul volto e nei gesti, i segni della tensione. Nelle parole, la curiale eppure chiara risposta a settimane di rivelazioni e scricchiolii: “Questi sono i documenti da vedere e presentare, che mostrano la verità storica”. I documenti sono quelli dell’Archivio segreto vaticano, e a parlare è il segretario di Stato del Vaticano, Tarcisio Bertone.
Ieri mattina il cardinale ha incontrato la stampa, per la prima volta dopo l’esplodere del caso Vatileaks: i documenti riservati della Santa Sede, pubblicati dal Fatto, che raccontano di lotte di potere e veleni infiniti nella Curia che governa la Chiesa. Bertone ha concesso poche battute, a margine della sua visita privata (e blindatissima) alla mostra nei Musei Capitolini sui documenti dell’Archivio segreto vaticano.
Un appuntamento dal grande interesse storico, che però suona come una beffa della sorte sulla Santa Sede: nella bufera per i tanti, troppi segreti che non ha saputo trattenere Oltretevere. Al centro della tempesta c’è proprio Bertone, segretario di Stato e principale collaboratore di Papa Benedetto XVI.
Rumorose voci, dentro e fuori il Vaticano, lo danno in bilico. E ieri il segretario di Stato ha indirettamente risposto. Bertone arriva in Campidoglio assieme a una folta delegazione, di cui fa parte anche il cardinale Gian-franco Ravasi. Ad attenderlo, il sindaco Alemanno, il ministro per i Beni culturali Lorenzo Ornaghi e Gianni Letta. Accesso vietato ai tanti giornalisti. Bertone è protetto da parecchi agenti e gendarmi vaticani. Ha l’espressione tirata, qualcuno nota i suoi movimenti poco fluidi, forse nervosi.
Il cardinale entra nei musei, e può guardare da vicino le carte del processo a Galileo e i documenti che provano il sostegno di Papa Pio XII ai prigionieri di guerra, durante la Seconda guerra mondiale. All’uscita, il cordone di sicurezza prova a tenere lontani taccuini e telecamere. Ma è proprio Bertone ad avvicinarsi ai giornalisti, per dire: “Questi sono i documenti da vedere e presentare, quelli mostrano la verità storica”. Bertone spiega poi di essere rimasto particolarmente colpito dalla documentazione su Pio XII.
Ma tutti i cronisti pensano a Vatileaks. E arriva la domanda: i documenti della mostra, veri, vanno contrapposti ad altri che si presumono falsi? Bertone sorride, fa un gesto con la mano. Ma non si sbilancia: “Voi lo sapete, voi siete bene informati”. Di più non può e non vuole dire.
Il cardinale torna in Vaticano, lasciandosi dietro interrogativi e previsioni. C’è chi parla di una prossima rimozione del segretario di Stato, e chi rinvia la sua sostituzione al prossimo dicembre, quando Bertone compirà 78 anni. La stessa età in cui lasciò il suo predecessore, il cardinale Angelo Sodano. Ipotesi, a fronte della certezza di un Vaticano in costante ebollizione.
Troppo rumorosi, quei documenti che parlano di scontri al calor bianco ai vertici della Chiesa. Troppo forte, l’impatto del carteggio tra Bertone e il cardinale Dionigi Tettamanzi, pubblicato due giorni fa dal Fatto.
Nel marzo 2011, il segretario di Stato scrive all’allora arcivescovo di Milano Tettamanzi, e lo invita a lasciare la presidenza dell’Istituto Toniolo. Per giunta, precisando di parlare a nome del Papa: “Il Santo Padre intende procedere a un rinnovamento, in connessione col quale Vostra Eminenza è sollevata da questo oneroso incarico. Adempiendo pertanto a tale Superiore intenzione, sono a chiederle di fissare l’adunanza del Comitato Permanente entro il giorno 10 del prossimo mese di aprile”. Bertone indica anche il sostituto, l’ex ministro alla Giustizia Giovanni Maria Flick. Ma Tettamanzi non cede, e scrive al Pontefice, chiedendogli di annullare la decisione. Annullamento che, nei fatti, arriva, sconfessando un documento del segretario di Stato. Basterebbe questo, per capire che aria tira in Vaticano. Eppure c’è tanto altro. Pesa il complotto per uccidere il Papa, paventato in un documento che dalle pagine del Fatto è rimbalzato in mezzo mondo. E pesano le lettere dell’ex segretario del Governatorato, il nunzio apostolico negli Usa Carlo Maria Viganò.
Missive che denunciavano al Papa e a Bertone episodi di corruzione. Lo stesso Viganò, in un’altralettera al Papa del marzo 2011, chiedeva di non essere nominato nunzio apostolico, “perché un mio trasferimento provocherebbe smarrimento e scoramento in quanti hanno creduto fosse possibile risanare tante situazioni di corruzione”. Storie complicate, dolorose.
Ieri il Corriere della Sera raccontava che a qualcuno, Oltretevere, era venuta la tentazione di rispondere al flusso di notizie riservate con una protesta ufficiale nei confronti dello Stato italiano. Idea che sarebbe stata respinta, per motivi di opportunità politica.
-
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- COME SI ELEGGE UN PAPA. Le consolazioni «celesti» del politologo (di Michele Prospero)28 febbraio 2012, di Federico La Sala
Le consolazioni «celesti» del politologo
di Michele Prospero (l’Unità, 28 febbraio 2012)
Sull’inserto domenicale del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, turbato per gli aspri scontri di potere che si odono nei paraggi delle segrete stanze del Vaticano, suggerisce di mutare il sistema elettorale della Chiesa.
Il tema di come si elegge il Papa non è nuovo. Appassionò anche Marsilio da Padova. Quando nel 1343 il Papa Clemente VI annunciò la sopraggiunta morte del grande padovano, con un punto di malizia affermò «osiamo dire di non avere mai conosciuto un eretico peggiore di lui». Ma non è sulla strada della democratizzazione tracciata da Marsilio che Galli della Loggia intende muoversi nel suo disegno riformatore. Egli schiva le insidie dell’eresia (disprezza i «duecento anni di secolarizzazione» che hanno privato la Chiesa del diritto ad avere ragione a prescindere) ma sfida anche la sobria logica della non contraddizione.
Sostiene che il carisma non sopporta la democrazia, ma poi invoca l’ampliamento del corpo elettorale chiamato ad eleggere il Pontefice fino a comprendere 6 mila vescovi. Sostiene anche che il dibattito pubblico è del tutto sconveniente per i pastori del sacro, ma poi dichiara che il compito prioritario di una grande riforma istituzionale è proprio quello di garantire alcune sedi stabili in cui i contrasti dottrinali possano svolgersi senza spargimenti (metaforici) di sangue.
Lamenta una grave eclisse del sacro, a causa di un perfido «mondo anglosassone» ostile alla tradizione che impone il chiacchiericcio dei media ma per liberare il mistico dai media anche lo storico si avvale dei media, naturalmente. Galli della Loggia scorge che anche oltreTevere l’amore della carriera prevale sulle idee e ciò determina un «peggioramento qualitativo del personale dirigente». Contro la patologia dell’organizzazione del potere e il suo «discredito profondo», egli reclama le superiori istanze del merito, delle capacità. Oddio, i tecnici anche in Vaticano? Ma lì non serve fedeltà, tradizione?
Per assicurare il ritorno del sacro, e per far contare meno i conformismi delle carriere, della Loggia ha una ricetta sicura: una nuova legge elettorale per l’elezione del Papa. Il principio di maggioranza (anticamera del relativismo) è tendenzialmente pericoloso per chi si prefigge di puntellate il carisma ma, ancora incurante della logica, lo storico propone che ai grandi elettori si presentino diverse candidature tra le quali scegliere. I segreti del sacro sono nelle formule elettorali e allora non il maggioritario secco all’inglese ma il maggioritario alla francese (a doppio turno) per della Loggia è la comprovata garanzia della riscoperta della missione profetica.
Anche qui la logica è ballerina: se davvero «dove il potere è personale tutti i contrasti diventano personali» che senso ha poi prevedere il gran duello tra aspiranti pontefici? Con candidati in lizza e tutti con un bel po’ di firme a sostegno (le primarie no?), il soglio pontificio poggerà finalmente su tradizione, carisma, lealtà.
Molto deluso per come sono andate le cose nella prosaica terra della politica dopo la stagione dei referendum maggioritari, della Loggia si prefigge ora di disegnare la nuova mappa dei poteri nelle istituzioni celesti. Vent’anni fa egli guardava con gli occhi estasiati della teologia la terra promessa del maggioritario all’inglese e si candidava nelle liste Giannini. Ora scruta con le ruggini della battaglia politica le antiche dispute teologiche sulla natura del sacro e si pone alla ricerca di un cesarismo democratico, dimenticando che proprio nel disprezzato mondo anglosassone ne esistono le versioni più antiche.
Come aspirante riformatore ecclesiastico, Della Loggia non sembra avere migliori carte di quanto si proponeva come riformatore secolarizzato delle istituzioni.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" --- E’ CHIARO CHE VUOLE SOLO ALLARGARE I CONFINI DEL SUO CORTILE.17 febbraio 2012, di Federico La Sala
Ravasi: «Il Cortile allarga i confini»
intervista a Gianfranco Ravasi
a cura di Lorenzo Fazzini (Avvenire, 17 febbraio 2012)
Dall’illuminista Parigi alla Tirana ex comunista; da Assisi, patria del Poverello, a Bucarest, porta d’Oriente. E, a venire: Barcellona, vetrina della Sagrada Familia, Stoccolma, terra dei Nobel, la Milano sede della Borsa, Marsiglia, patria di Albert Camus. In futuro: Gerusalemme, Washington, Vienna. Il Cortile dei gentili si allarga e abbraccia culture, località, centri accademici diversissimi ma uniti - chiarisce il cardinale Gianfranco Ravasi, regista dell’operazione voluta da Benedetto XVI - dal desiderio di indagare il senso del mistero dell’uomo.
Dall’iniziale intuizione del pontefice (eravamo nel dicembre 2009) affinché la Chiesa aprisse un «nuovo Cortile dei gentili» per dialogare con quanti «sentono la religione come una cosa estranea» ma vogliono avvicinare Dio «almeno come uno Sconosciuto», molto è già stato fatto e altrettanto è in cantiere. Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, confida: «Il problema è tener testa alle tantissime richieste: tutto questo significa che c’è un desiderio comune contrassegnato dalla ricerca di senso». Insomma, da quando il laico "Le Figaro" titolò l’anno scorso «Il Vaticano si invita alla Sorbona» (inaudito negli anni passati, se si pensa alla Francia laicissima), ormai sembra soffiare un’aria nuova tra Chiesa e cultura umanista: Julia Kristeva, Jean Clair, Remo Bodei, Axel Kahn, Giuliano Amato, Jean Luc Marion, Rémi Brague, Jean-Claude Casanova, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Fabrice Hadjadj. Questi solo alcuni dei nomi che hanno punteggiato il primo anno di vita del Cortile. E altri se ne stagliano all’orizzonte.
Eminenza, tempo fa aveva annunciato il confronto con l’ateismo "popolare", quello alla Michel Onfray per intendersi: a che punto siamo?
«Per ora abbiamo escluso - ma non necessariamente - le due ali "estreme" dell’ateismo lasciando da parte l’ateismo "nazional-popolare", di superficie, caustico e sarcastico, quasi aggressivo. Si tratta di una forma antropologica: i suoi sostenitori sembrano alfieri di un’anti-religione. Su questo dobbiamo operare una riflessione perché è un fenomeno molto diffuso, complesso e con una sua letteratura. Tale movimento si inserisce nel più grande ambito dell’indifferenza: questi autori, se lanciano una battuta forte ("l’illusione di Dio", "l’assurdità della religione") suscitano interesse. Prima o poi affronteremo questa atmosfera nebbiosa che rappresenta il frutto estremo della secolarizzazione».
E gli atei devoti? Alcuni, dal mondo cattolico tradizionale, le rimproverano di escluderli...
«Anche questo è un ambito molto variegato. Degli "atei devoti" non ce ne siamo interessati perché in molti casi i suoi esponenti hanno un’implicanza politica. Da queste persone il tema religioso viene affrontato in maniera apologetica, per cui la religione cristiana costituisce solo un grande valore per l’Occidente. Si tratta di una sottolineatura giusta ma che non rappresenta uno scavo profondo. Questi autori non tengono in conto grandi prospettive di indagine. Si accontentano di ripetere la dottrina, e basta. Comunque è vero che queste "ali estreme" chiedono il dialogo: tra gli atei "nazional-popolari" cito Paolo Flores D’Arcais e Piergiorgio Odifreddi; fra gli "atei devoti" Giuliano Ferrara... Ma fino ad ora l’impostazione del Cortile rientra nell’alveo centrale del confronto tra le grandi visioni di interpretazione della realtà mediante un linguaggio comune: il concetto di cultura. Nelle tappe del Cortile di Bologna, Parigi, Firenze, Tirana si sono affrontate tematiche come la cosmologia, il male, il diritto, la laicità, l’arte».
Quale la ragione d’essere del Cortile?
«Ritornare al modello di evangelizzazione di Paolo: l’Apostolo è stato capace di assumere le categorie del pensiero classico a lui contemporaneo per annunciare il cristianesimo. Come evidenzia Jacques Dupont, l’idea della Chiesa come corpo mistico è mutuata dalla concezione stoica dell’anima mundi. Paolo andava in campo "laico" ad attingere concetti e categorie. Mi emoziono sempre a pensare quanto Agostino ha studiato Platone e Plotino per poterli poi "battezzare"».
Gli atei accettano di esser definiti tali?
«Il termine "ateismo" è obsoleto. Il filosofo non credente messicano Guillermo Hurtado, presente all’incontro di Assisi, sull’“Osservatore romano” ha rilevato come l’ateismo non si autodefinisce nemmeno terminologicamente. Le racconto un dettaglio eloquente. Quando il Papa decise di invitare i non credenti ad Assisi, sorse il problema di come definirli: atei è parola desueta e una categoria illuministica, richiama il marchese de Sade. Agnostici? Ma essi ci dicevano: “Allora voi siete gnostici?”. Infatti il cristianesimo ha rifiutato ogni gnosi. Non credenti? Determina solo in senso negativo. Alla fine è prevalsa, dopo un giro di consultazioni, l’idea di Julia Kristeva: umanisti, un termine accettato sia in ambiente francese che in quello anglofono».
Lei tiene un blog, twitta, usa i social network. Che legame esiste tra il web e il Cortile?
«Stiamo pensando a una plenaria del Pontificio Consiglio dedicata alle culture giovanili, alla secolarizzazione e alle indifferenze su vari campi: la musica (un linguaggio fondamentale), l’amicizia (non più quella della nostra generazione), i raduni corali (i concerti), le spiritualità vaghe dell’Oriente. Su questo mi piacerebbe coinvolgere il filosofo Charles Taylor e lo scrittore Claudio Magris».
Quali i risultati già delineati dopo il primo anno di Cortile?
«L’umanesimo "laico" e la fede sono accomunati da un elemento: il ruolo fondamentale della ricerca. È un tema che troviamo in due classici come l’Apologia di Socrate ("una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta") e l’incipit delle Confessioni di Sant’Agostino (il "cuore inquieto"). Su questo vorrei spendere una parola, perché spesso i giornalisti obiettano che comunque la Chiesa, con il Cortile, intende convertire chi non crede. Il problema è intendersi: quando un non credente interviene al Cortile non fa solo opera di informazione. Il suo è un intervento anche performativo, che cerca di convincere l’altro della sua posizione. Basti pensare con quanta passione sono intervenuti il genetista Axel Kahn o la scrittrice Julia Kristeva alla Sorbona. Non lo avrebbero fatto così se non pensassero di convincere i presenti delle loro ragioni. Questo non è negativo. E poi un risultato importante del Cortile c’è già...».
Quale?
«Abbiamo contribuito a elevare il tono del dibattito culturale che spesso risulta abbassato fino alla polvere. Diamo così un contributo alla società deponendo alcuni semi che possono crescere e fruttificare. A Firenze, ad esempio, si è parlato di temi alti (arte e fede, ndr) e la gente è rimasta ad ascoltare per ore. Non è vero che la gente si interessa solo di cibo e festini, o che ascolta unicamente il menù del giorno, per citare Kierkegaard».
Cosa le dice il Papa del Cortile? Le ha dato suggerimenti?
«Anzitutto, va evidenziata una cosa: che l’invito ai "non credenti" ad Assisi è un’idea precisa di Benedetto XVI in persona. Fu lui, in una riunione ristretta con quattro cardinali di Curia, a chiedere questa presenza. E mi sorprese la motivazione di tale invito: rinverdire il modello della teologia patristica, cioè riprendere la capacità dei Padri di entrare in dialogo con le categorie della filosofia del proprio tempo. Se si scorre l’indice di Introduzione al cristianesimo del teologo Joseph Ratzinger, si vedono moltissime citazioni di autori "laici" della cultura tedesca».
In che modo il pontefice si interessa al Cortile?
«Ogni volta che incontro Benedetto XVI, ciò di cui si informa subito (e che considera più importante nel mio lavoro) è il Cortile dei gentili. Una volta mi ha detto: "Le sono particolarmente grato perché con il Cortile lei va dove noi, come Chiesa, non potremmo andare". E infatti nelle varie istituzioni in cui mi invitano io vado sempre come cardinale e rappresentante della Santa Sede».
Ci sarà un giorno un evento del Cortile con Benedetto XVI presente?
«Stiamo pensando a un evento del genere. Lui sa fare molto bene il dialogo "a braccio", specialmente con i giovani. Ma anche con un interlocutore. Vediamo. Potrebbe essere all’interno della plenaria dedicata alle culture giovanili, come dialogo con dei ragazzi e ragazze».
Il Cortile e la cattedra dei non credenti di Milano, inventata dal cardinal Martini: più volte le due iniziative sono state accomunate. Paragone corretto?
«C’è una differenza. Nella Cattedra, per la prima volta, un non credente veniva a parlare a dei credenti dalla cattedra, presentando la sua visione su un certo tema; a Martini spettavano le conclusioni. Nel Cortile invece c’è una dimensione di parità, come se ci fossero due cattedre. Ma posso dire che Martini è molto contento di questa iniziativa perché prosegue, seppur in maniera diversa, quella sua intuizione».
Lei ha un sogno personale sul Cortile? Un dialogo che le piacerebbe vivere?
«Non ci ho mai pensato. Però ... beh, sicuramente la partecipazione diretta di Benedetto XVI sarebbe molto bella. Un sogno sul passato sarebbe stato un dibattito con Albert Camus. Oggi invece mi interessano molto le questioni delle nuove comunicazioni: è venuto a incontrarmi il presidente di Google, Eric Schmidt. E penserei a Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook. Ci sono contatti in corso con lo scrittore Mario Vargas Llosa per un dialogo a due: lo farei molto volentieri».
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- Se la feroce religione del denaro divora il futuro (di Giorgio Agamben)16 febbraio 2012, di Federico La Sala
Se la feroce religione del denaro divora il futuro
di Giorgio Agamben (la Repubblica, 16.02.2012)
Per capire che cosa significa la parola "futuro", bisogna prima capire che cosa significa un’altra parola, che non siamo più abituati a usare se non nella sfera religiosa: la parola "fede". Senza fede o fiducia, non è possibile futuro, c’è futuro solo se possiamo sperare o credere in qualcosa.
Già, ma che cos’è la fede? David Flüsser, un grande studioso di scienza delle religioni - esiste anche una disciplina con questo strano nome - stava appunto lavorando sulla parola pistis, che è il termine greco che Gesù e gli apostoli usavano per "fede". Quel giorno si trovava per caso in una piazza di Atene e a un certo punto, alzando gli occhi, vide scritto a caratteri cubitali davanti a sé Trapeza tes pisteos. Stupefatto per la coincidenza, guardò meglio e dopo pochi secondi si rese conto di trovarsi semplicemente davanti a una banca: trapeza tes pisteos significa in greco "banco di credito".
Ecco qual era il senso della parola pistis, che stava cercando da mesi di capire: pistis, " fede" è semplicemente il credito di cui godiamo presso Dio e di cui la parola di Dio gode presso di noi, dal momento che le crediamo. Per questi Paolo può dire in una famosa definizione che "la fede è sostanza di cose sperate": essa è ciò che dà realtà a ciò che non esiste ancora, ma in cui crediamo e abbiamo fiducia, in cui abbiamo messo in gioco il nostro credito e la nostra parola. Qualcosa come un futuro esiste nella misura in cui la nostra fede riesce a dare sostanza, cioè realtà alle nostre speranze.
Ma la nostra, si sa, è un’epoca di scarsa fede o, come diceva Nicola Chiaromonte, di malafede, cioè di fede mantenuta a forza e senza convinzione. Quindi un’epoca senza futuro e senza speranze - o di futuri vuoti e di false speranze. Ma, in quest’epoca troppo vecchia per credere veramente in qualcosa e troppo furba per essere veramente disperata, che ne è del nostro credito, che ne è del nostro futuro?
Perché, a ben guardare, c’è ancora una sfera che gira tutta intorno al perno del credito, una sfera in cui è andata a finire tutta la nostra pistis, tutta la nostra fede. Questa sfera è il denaro e la banca - la trapeza tes pisteos - è il suo tempio. Il denaro non è che un credito e su molte banconote (sulla sterlina, sul dollaro, anche se non - chissà perché, forse questo avrebbe dovuto insospettirci - sull’euro), c’è ancora scritto che la banca centrale promette di garantire in qualche modo quel credito.
La cosiddetta "crisi" che stiamo attraversando - ma ciò che si chiama "crisi", questo è ormai chiaro, non è che il modo normale in cui funziona il capitalismo del nostro tempo - è cominciata con una serie sconsiderata di operazioni sul credito, su crediti che venivano scontati e rivenduti decine di volte prima di poter essere realizzati. Ciò significa, in altre parole, che il capitalismo finanziario - e le banche che ne sono l’organo principale - funziona giocando sul credito - cioè sulla fede - degli uomini.
Ma ciò significa, anche, che l’ipotesi di Walter Benjamin, secondo la quale il capitalismo è, in verità, una religione e la più feroce e implacabile che sia mai esistita, perché non conosce redenzione né tregua, va presa alla lettera. La Banca - coi suoi grigi funzionari ed esperti - ha preso il posto della Chiesa e dei suoi preti e, governando il credito, manipola e gestisce la fede - la scarsa, incerta fiducia - che il nostro tempo ha ancora in se stesso. E lo fa nel modo più irresponsabile e privo di scrupoli, cercando di lucrare denaro dalla fiducia e dalle speranze degli esseri umani, stabilendo il credito di cui ciascuno può godere e il prezzo che deve pagare per esso (persino il credito degli Stati, che hanno docilmente abdicato alla loro sovranità).
In questo modo, governando il credito, governa non solo il mondo, ma anche il futuro degli uomini, un futuro che la crisi fa sempre più corto e a scadenza. E se oggi la politica non sembra più possibile, ciò è perché il potere finanziario ha di fatto sequestrato tutta la fede e tutto il futuro, tutto il tempo e tutte le attese.
Finché dura questa situazione, finché la nostra società che si crede laica resterà asservita alla più oscura e irrazionale delle religioni, sarà bene che ciascuno si riprenda il suo credito e il suo futuro dalle mani di questi tetri, screditati pseudosacerdoti, banchieri, professori e funzionari delle varie agenzie di rating. E forse la prima cosa da fare è di smettere di guardare soltanto al futuro, come essi esortano a fare, per rivolgere invece lo sguardo al passato. Soltanto comprendendo che cosa è avvenuto e soprattutto cercando di capire come è potuto avvenire sarà possibile, forse, ritrovare la propria libertà. L’archeologia - non la futurologia - è la sola via di accesso al presente.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA --- MONSIGNOR LUIGI BETTAZZI: IL PAPA PUO’ DIMETTERSI. Dietro la teoria del complotto contro Benedetto XVI ci sarebbe l’intenzione di preparare l’opinione pubblica alle sue dimissioni14 febbraio 2012, di Federico La Sala
Bettazzi: il Papa può dimettersi. Il Vaticano: siamo sotto attacco.
di Roberto Monteforte (l’Unità, 14 febbraio 2012)
Il Papa si vuole dimettere. Dietro la teoria del complotto contro Benedetto XVI ci sarebbe l’intenzione di preparare l’opinione pubblica alle sue dimissioni a cui lo stesso papa Ratzinger starebbe pensando. La pensa così monsignor Luigi Bettazzi, padre conciliare e vescovo emerito di Ivrea che dai microfoni del programma di Radio2 Un Giorno da Pecora (interviste provocatorie) ha avanzato la sua teoria.
Ai due conduttori, Sabelli Fioretti e Lauro, che gli chiedono un giudizio sulla teoria del complotto per uccidere papa Ratzinger svelato dal Fatto Quotidiano, risponde: «No, non credo. Fosse stato il Papa precedente lo capirei, ma questo Papa - aggiunge - qui mi sembra così mite, religioso. Non troverei i motivi per attentarlo».
Alla domanda su cosa abbia pensato quando è venuta fuori la notizia del complotto, arriva l’originale risposta di monsignor Bettazzi: «Penso ad un cosa per preparare l’eventualità delle dimissioni. Per preparare questo choc, perché - spiega - le dimissioni di un Papa sarebbero un choc, cominciano a buttare lì la cosa del complotto».
Ma - gli chiedono - papa Ratzinger vorrebbe dimettersi? «Io credo di sì - risponde - anche se l’hanno smentito. Un vecchio cardinale, però, mi diceva sempre: se il Vaticano smentisce vuol dire che è vero...».
L’anziano vescovo emerito di Ivrea, quindi, spiega quali sarebbero a suo avviso le ragioni di questa determinazione di papa Benedetto XVI: «Penso che si senta molto stanco, basta vederlo, è un uno abituato agli studi». «E di fronte ai problemi che ci sono, forse anche di fronte alle tensioni che ci sono all’interno della Curia - conclude - potrebbe pensare che di queste cose se ne occuperà il nuovo Papa».
Oltretevere non si commentano le parole di monsignor Bettazzi. Ci si limita a definire piuttosto ardita, addirittura «bizzarra», la sua teoria delle dimissioni del Papa di cui non si capirebbe il nesso con i fatti di questi giorni e con l’ipotesi del «complotto», ritenuta una «farneticazione».
La possibilità di dimissioni l’ ha riconosciuta lo stesso Benedetto XVI nel suo libro autobiografico Luce del mondo. Ma in astratto. Qualora lo stesso pontefice si rendesse conto di non essere più nelle condizioni di governare bene la Chiesa. Non vi sarebbe nessun rapporto con la situazione che vive oggi in Vaticano. Anche se quelli attuali non sono certo momenti facili.
La fuga dei documenti è segno evidente dello scontro interno. Lo riconosce anche padre Federico Lombardi che dai microfoni di Radio Vaticana invita a «tenere tutti i nervi saldi perché nessuno si può stupire di nulla». Denuncia un «duro attacco contro la Chiesa». «L’amministrazione americana ha avuto Wikileaks, il Vaticano ha ora i suoi leaks, le sue fughe di documenti che tendono a creare confusione e sconcerto e a facilitare una messa in cattiva luce del Vaticano e della Chiesa».
I LEAKS OLTRETEVERE
Il direttore di Radio Vaticana invita i media a fare «uso della ragione» e a saper distinguere. «Mettere tutto insieme - osserva - giova a creare confusione». Una cosa sono i documenti sulla gestione economica vaticana, cosa diversa e «farneticante» è la storia del complotto contro il Papa.
«C’è qualcosa di triste - ammette - nel fatto che vengano passati slealmente documenti dall’interno all’esterno in modo da creare confusione. La responsabilità c’è dall’una e dall’altra parte. Anzitutto da parte di chi fornisce questo tipo di documenti, ma anche di chi si dà da fare per usarli per scopi che non sono certo l’amore puro della verità».
Lombardi insiste sull’impegno serio della Santa Sede «nel garantire una vera trasparenza del funzionamento delle istituzioni vaticane anche dal punto di vista economico». Come contro la pedofilia. Vede nella recente campagna di stampa un tentativo di «screditare questo impegno» e «ciò - assicura- costituisce una ragione di più per perseguirlo con decisione senza lasciarsi impressionare».
Ma le carte riservate fatte uscire dal Vaticano non sono segno di una lotta di potere? PadreLombardi respinge questa lettura. L’attribuisce alla «rozzezza morale di chi la provoca e di chi la fa, che spesso non è capace di vedere altro». Le vere preoccupazioni di chi porta responsabilità nella Chiesa-assicura - sono i problemi gravi dell’umanità».
-
> Il pontificato del fine teologo Ratzinger rischia di chiudersi in mezzo agli schiamazzi di lavandaie sempre più sguaiate e alle liti da cortile di eminenze e illustrissimi che non meriterebbero di gestire nemmeno il più infimo degli ordini religiosi (di Aldo Maria Valli).14 febbraio 2012, di Federico La Sala
Il Vaticano delle lavandaie
di Aldo Maria Valli *
Che il Vaticano sia (anche) un villaggio di lavandaie si sapeva da tempo. Il pettegolezzo, nei sacri palazzi, è pane quotidiano, un grande gioco al quale giocano in tanti, con molteplici obiettivi. Mondo piccolo e chiuso, lo staterello del papa è anche un concentrato di poteri e di interessi: miscela esplosiva.
Inoltre è una monarchia assoluta, il che impedisce al dibattito interno di trovare sfogo attraverso vie istituzionali. Man mano che il sovrano, per età, per condizioni di salute o per entrambe le circostanze, si inoltra nella fase finale del regno, o in quella che i più ritengono tale, il villaggio entra in fibrillazione, le lavandaie danno il peggio di sé e il grande gioco si fa più duro. Alcuni esponenti del piccolo mondo, per ragioni diverse, si mettono a difendere posizioni, a tentare scalate, a cercare di guadagnare terreno.
Ad alcuni fa gola il potere, ad altri il denaro, a molti l’uno e l’altro. Poi ci sono le cordate, i gruppi di pressione, le amicizie e le inimicizie. A volte la linea che separa un vincente da un perdente è sottilissima. La curia vaticana è una corte, e nelle corti basta poco perché gli equilibri siano messi in discussione. Basta una parola avventata, un commento fuori posto, un inchino poco convinto o esagerato, ed ecco che ci si ritrova al centro di voci, di insinuazioni, di malignità o di vere e proprie calunnie. Una palla di neve, così, può diventare rapidamente una valanga. La lingua batte dove il dente duole. Per questo il terreno di gioco molto spesso è quello economico o quello sessuale. E anche sotto questo aspetto niente di nuovo da segnalare.
Gli elementi veramente nuovi, che emergono dalle ultime vicende, sono due: la spiccata propensione delle lavandaie a gettare i panni sporchi in pasto ai mass media e il basso, bassissimo livello denunciato dai giocatori. Un tempo le lavandaie arrivavano a scannarsi, esattamente come ora, per i più diversi motivi, ma il tutto restava all’interno delle sacre mura. Ora invece, nell’epoca dell’informazione, alcuni dei giocatori anno preso gusto a rovesciare i loro veleni nel grande imbuto dei mass media. In questo modo, pensano alcune lavandaie, la potenza dei proiettili è moltiplicata. Un’insinuazione o una calunnia, finché restano dentro le mura, hanno una certa forza: se ne fuoriescono, acquistano molta più incisività. E così i giornalisti vengono sempre più coinvolti nel grande gioco, con la funzione di megafoni.
Le lavandaie tuttavia sembrano non rendersi conto dell’effetto assuefazione e della distrazione del pubblico. Se una lettera anonima fa notizia, una seconda lettera anonima passa quasi inosservata e una terza provoca soltanto noia. Idem per complotti e cospirazioni varie, sia pure targate Vaticano. Circa il basso livello dei giocatori, basta passare in rassegna le ultime vicende (almeno dal caso Boffo in poi) per verificare che il materiale umano è davvero deludente. C’è modo e modo di ordire trame e architettare complotti.
Per dirla con Sciascia, anche nel campo delle macchinazioni ci sono uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraqua. Puoi essere un Borgia o un Castrillon Hoyos. E se una vecchia volpe come il cardinale Re ha soprannominato quest’ultimo “Pasticcion Hoyos”, un motivo ci dev’essere.
Da secoli il Vaticano si porta appresso la fama (più o meno meritata) di luogo incline alla congiura. Ma se una volta, dicendo “congiura”, si pensava a qualcosa di grande e raffinato, adesso si pensa più che altro a liti da comari bisbetiche. Sic transit gloria mundi, verrebbe da dire, ammesso che nello scandalo ci possa essere qualcosa di glorioso. Resta da capire come stia vivendo tutto questo un uomo intelligente, e ottimo conoscitore della curia, come Joseph Ratzinger.
Fu lui, quando era cardinale, a parlare di riforma paragonandola a un‘opera di ablatio (lo disse in latino, perché una volta gli uomini di Chiesa ancora lo parlavano), ovvero di eliminazione di tutte le cose e le persone inutili. Fu sempre lui a usare una parola inequivocabile, “sporcizia”, per dipingere certe degenerazioni all’interno della Chiesa, ed è stato ancora lui a mettere in guardia a più riprese dal carrierismo degli ecclesiastici. Dunque, i problemi li conosce bene, e non potrebbe essere altrimenti visti i decenni trascorsi nella stanza dei bottoni.
Eppure, proprio il pontificato del fine teologo Ratzinger rischia di chiudersi in mezzo agli schiamazzi di lavandaie sempre più sguaiate e alle liti da cortile di eminenze e illustrissimi che non meriterebbero di gestire nemmeno il più infimo degli ordini religiosi. Triste destino per lui e triste situazione per la gerarchia cattolica. Anche perché le voci coraggiose e limpide, dotate di profezia (guardare lontano) e di parresia (libertà di dire tutto) sembrano scomparse.
Aldo Maria Valli
* Europa, 14 febbraio 2012
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE --- guardate alla radice dei termini che, nel Nuovo Testamento, indicano gratuità e gioia; è la stessa, char: char-is per gratuità, charà per gioia (di Luisito Bianchi - Gratuità nel ministero)3 febbraio 2012, di Federico La Sala
Gratuità nel ministero
di Luisito Bianchi
in “Il Regno” - Attualità - n. 20 del 15 novembre 2006
Se la sapienza ama giocare con gli uomini (cf. Pr 8,31), può darsi che anche il giorno scelto dal potere religioso in Italia per decretare l’entrata in vigore di una legge concordataria faccia parte di tale gioco. Come può essere capitato per il 25 gennaio 1987.
Dicono che da mille anni questa data è consacrata alla memoria liturgica della Conversione di san Paolo. Ma conversio ad quid? Sappiamo che cosa avvenne sulla via che portava a Damasco. E fu in quel bagliore accecante che l’intransigente difensore della legge rimase per sempre travolto dalla piena della gratuità che proveniva dal corpo di Gesù, crocifisso e risorto, unica salvezza.
Accadde in quel momento il definitivo convergere di Paolo (la conversione appunto) sulla gratuità della salvezza, che viene non dalla legge ma da Gesù, come dono assoluto, senza contraccambio. Per tutta la sua vita, Paolo altro non fece che raccontare questa gratuità, operare perché altri si convertissero a questo Evangelo che è la buona notizia della salvezza come dono gratuito, non soggetto a pentimento. E tutto questo spinto dalla «necessità», cui è impossibile sottrarsi, di trasmettere quanto è stato ricevuto, una tradizione fondata sul ricevere e dare gratuitamente.
Da qui la sua assoluta intransigente gratuità nel trasmettere l’accaduto che gli rivelò la gratuità di Dio, al punto da preferire la morte (cf. 1Cor 9, 15) piuttosto che avvalersi perfino della facoltà di sedersi a mensa (eppure «l’operaio è degno del suo nutrimento», come da Mt 10,10) riconosciuta al rabbi nella cultura ebraica, perché non fosse sottoposto il suo annuncio di gratuità («economia della gratuità» di Ef 3,2ss) anche solo al sospetto d’una strumentalizzazione per risolvere il problema del vivere. Di qui la necessità di lavorare con le proprie mani per trarne il sostentamento ed essere assolutamente gratuito nella predicazione.
«Lavorai giorno e notte» dice in diversi luoghi delle sue lettere, e non tanto iperbolicamente se teniamo conto delle cinque motivazioni del lavoro stesso, come riporta il discorso di Paolo agli anziani di Efeso (cf. At 20,33ss), fra le quali il sostentamento anche dei suoi collaboratori che non avevano la possibilità di lavorare per provvedervi da soli, sempre in viaggio a tenere i contatti fra le giovani Chiese e lo stesso Paolo. Anche loro, quindi, essendo suoi collaboratori, non dovevano far dipendere il loro sostentamento dal Vangelo. Quando poi Paolo, infermo o in prigione, non potrà sostentarsi col lavoro, solo allora accetterà l’aiuto dalla Chiesa di Filippi, ma non perché apostolo (anche da altre Chiese avrebbe dovuto pertanto accettarlo) bensì per amicizia (si ricordi la dolce violenza che gli fece Lidia in At 16,15, dove il verbo scelto da Luca per indicare l’irresistibile pressione di Lidia è lo stesso che usa per i due discepoli di Emmaus quando insistono perché lo sconosciuto entri in casa!).
Lavoro in primo luogo e amicizia poi sono, per Paolo, le due difese della gratuità dell’annuncio. Si raggiunge, così, attraverso l’esperienza di Damasco, il cuore della missione, come l’aveva indicato lo stesso Gesù: «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).
All’inizio, dunque, delle Chiese d’Occidente (non si dimentichi che anche Barnaba, a detta dello stesso Paolo - cf. 1Cor 9,6 - era del medesimo sentire) sta questa scelta di gratuità assoluta che viene indicata come esempio da imitare (cf. At 20,35; 1Ts 1,6-7; Fil 3,17; e, soprattutto, 2Ts 3,9). Come mai, allora, si arrivò a dichiarare impossibile la gratuità dell’annuncio dopo poco meno di 20 secoli di storia di tale gratuità, scaturita impetuosa dal cuore di Cristo, fatta da Paolo un tutt’uno con la propria vita, e continuata come fiume più o meno abbondante, fluente o in secca, ma sempre presente, per lunghi anni magari alla maniera d’un fiume carsico, che all’improvviso riappare con freschissime acque? Giacché, volere o no, è un fatto innegabile che dal 25 gennaio 1987 il sacerdote, nel momento in cui è ordinato (ordo ad) alla celebrazione della Parola e dell’eucaristiaentra necessariamente nell’istituto del sostentamento del clero e gli viene quindi praticamente chiusa e sigillata la porta alla gratuità in quanto è sottoposto al gesto del do ut des che è il contrario del gesto gratuito, indipendentemente dall’uso che può fare di tale retribuzione.
Questi sono fatti oggettivi, dai quali è facilissimo scivolare via. Che l’illazione poi che ne traggo sia altrettanto oggettiva, bisognerebbe che lo si chiedesse a san Paolo. «Io non Enea, io non Paulo sono: me degno a ciò né io né altri ’l crede» (D. Alighieri, Divina Commedia, Inferno, II, 32-33). Non so se ci sia stato o ci sia un vescovo che, accettando quanto avvenne il 25 gennaio 1987, abbia pensato alla possibilità che qualche prete, avendo già gustato la gioia liberante della gratuità che fu di Paolo e del filone che ne discende e attraversa tutta la storia della Chiesa, si trovasse sconcertato e perdesse la ragione del vivere dopo che, praticamente, i suoi vescovi gli avevano dichiarato illusoria, senza fondamento, la gioia liberante che durava da due decenni e che lo faceva sentire immerso nella tradizione della sua Chiesa, non ai margini. È vero che la storia di un prete fra migliaia è solo una storia; ed è pur sempre vero che la morte di uno vale la salvezza di tutti. Ma qui entra in gioco quella gioia liberante che è un bene di tutti, che tutti dovrebbero avere la possibilità di sperimentare, i miei confratelli intendo.
La mia storia non interessa, io fui un graziato perché continuai a beneficiare di tale gioia: e sono altri vent’anni che debbo aggiungere a quelli di prima. E tuttavia non sarei onesto se dovessi tacere l’interrogativo che mi posi quando mi fu chiaro che in quel 25 gennaio 1987 l’istituzione ecclesiastica aveva fatto una ben altra conversio di quella di Paolo. E l’interrogativo è questo: se nel 1950, anno in cui fui ordinato prete, al posto del «non datevi pensiero (...) di quello che mangerete (...) guardate i gigli» (Lc 12,22.27) o dell’invio sine baculo, sine pera, sine calceamentis (cf. Lc 10,4), mi si fosse imposta una congrua retribuzione mensile, sarei diventato prete? Non so. Forse sì, forse sarei stato addirittura contento di queste viscere materne della mia Chiesa che si preoccupava, al mio posto, di quello che avrei mangiato; o forse no se qualcuno, col cuore di don Mazzolari, m’avesse parlato della gioia liberante della gratuità del ministero seguendo le orme di san Paolo, e non solo della povertà.
Anche in questo momento mi torna l’interrogativo, e anche ora do la stessa risposta del primo momento: la mia storia non è fondata sui «se», ma mi assicura che da cinquantasei anni sono prete e che da quarant’anni gusto la gioia liberante dell’essere gratuito nell’annunciare il gratuito. Come si può calcolare da questi numeri, io sono giunto ormai al termine della mia corsa. E se ho un testimone da trasmettere alla nuova staffetta che sta per iniziare la sua corsa per tradere a sua volta, eccolo: guardate alla radice dei termini che, nel Nuovo Testamento, indicano gratuità e gioia; è la stessa, char: char-is per gratuità, charà per gioia.
Chissà se posso, senza suscitare diffidenze o malintesi, ma lo dico ugualmente (tanto nessuno può strapparmi questa radice che dà senso ai miei quattro palmi di terra): Fratelli vescovi, introducete fra le materie di studio dell’ultimo anno di teologia la storia della gratuità nel ministero nei venti secoli della Chiesa, e fate voi stessi l’esame finale con la domanda sul significato che racchiude la festa del 25 gennaio, Conversione di san Paolo. Ad quid? chiedete ai vostri giovani candidati, o anche vecchi. E dalla loro risposta capirete se dovete chiudere l’esame con una seconda domanda: «E tu?».
Posso sognare che qualcuno risponderà: sì, eccellenza, proprio ad modum sancti Pauli, e che voi avrete la magnanimità di dargli fiducia e studierete con lui il modo di sostentarsi nell’immane libertà e gioia di non far dipendere il sostentamento dall’annuncio evangelico?
Posso sognare che questa utopia (il non-luogo) diventi una charis-topia (il luogo della gratuità) per qualcuno? Ma fosse anche nessuno, che sia però nella libertà di scegliere, avendo ben presenti i rischi dell’una e dell’altra risposta. È tutt’altra cosa scegliere liberamente l’assegno mensile che il doverlo «subire» ope legis.
L’importante è che anche in circostanze simili, uno, nessuno o centomila si diano onore e gloria all’Unico che nel suo stesso corpo crocifisso e risorto ha fatto dell’u-topia una charis-topia, come unica salvezza. Non è una conclusione consolatoria. Non c’è consolazione né nel ricevere né nel non ricevere l’assegno mensile per il fatto che si è preti. La sola consolazione è il potermi affidare, nel buio, a questo corpo che siede sul trono della gratuità, egli stesso il solo gratuito, «per ricevere misericordia (...) ed essere aiutati nel momento opportuno» (Eb 4, 16).
Non ho comunque difficoltà ad ammettere che queste «parolette brevi» (Paradiso, I, 95) abbiano tutta l’aria d’un monologo, con i fantasmi che tale termine suscita, più che di una dimostrazione attraverso venti secoli di storia della gratuità ministeriale, e, per giunta, un monologo partigiano. Luisito Bianchi*
* Don Luisito Bianchi è noto per la sua esperienza di prete operaio prima e di scrittore poi (La messa dell’uomo disarmato, Come un atomo sulla bilancia, Monologo partigiano sulla gratuità ecc.).
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE --- La Condivisione del pane come fondamento della carità (di Benedetto XVI)11 febbraio 2012, di Federico La Sala
- IN MEMORIA DI LUISITO BIANCHI: "(...) io sono giunto ormai al termine della mia corsa. E se ho un testimone da trasmettere alla nuova staffetta che sta per iniziare la sua corsa per tradere a sua volta, eccolo: guardate alla radice dei termini che, nel Nuovo Testamento, indicano gratuità e gioia; è la stessa, char: char-is per gratuità, charà per gioia" (Gratuità nel ministero, "Il Regno", n. 20, 2006)
La Condivisione del pane come fondamento della carità cristianadi Benedetto XVI (Corriere della Sera, 11.02.2012)
Nel secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, San Luca descrive la Chiesa nascente con quattro caratteristiche che ne connotano la vita: «Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere» (At 2,42). Alcuni versetti dopo, Luca ritorna nuovamente su quanto aveva detto: «Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore» (At 2,46). Lo spezzare il pane, nominato due volte, appare come elemento centrale della comunità cristiana e ci ricorda l’incontro del Risorto con i discepoli di Emmaus (Lc 24,30 ss.), che a sua volta ci rimanda all’ultima cena (Lc 22,19). Questa è una parola che nella molteplicità dei suoi significati lascia trasparire il centro portante e al tempo stesso tutta l’ampiezza dell’esistenza cristiana.
Certo, essa si riferisce innanzitutto a qualcosa di molto semplice, di quotidiano. Nel mondo ebraico era compito del padrone di casa spezzare il pane dopo una preghiera e distribuirlo tra i commensali; questo sia durante pranzi familiari, o convivi, che in occasione di pasti di carattere rituale, come la sera della Pesah. Gesù padrone di casa e ospite paterno dei suoi ha raccolto questa usanza la quale, nella cena alla vigilia della sua agonia, acquista tuttavia un nuovo significato. Infatti, in quell’ora, Gesù non distribuisce solo pane, ma se stesso: Egli si dona. Già nel pasto quotidiano lo spezzare il pane ha un doppio significato: è allo stesso tempo un gesto di condivisione e di unione. In virtù del pane condiviso la comunità a tavola diventa una: tutti mangiano dello stesso pane. La condivisione è un gesto di comunanza, di donazione, che rende partecipi della famiglia anche gli ospiti.
Questo condividere e unire raggiunge nell’ultima cena di Gesù una profondità mai immaginata prima. Nello spezzare il pane egli compie quel «li amò sino alla fine» (Gv 13,1) in cui egli dona se stesso e diventa pane «per la vita del mondo» (Gv 6,51). Evidentemente il particolare gesto con cui Gesù spezzò il pane è penetrato profondamente nelle anime dei discepoli, come possiamo evincere dal racconto dei discepoli di Emmaus. Ricordando quel gesto, essi vi hanno visto racchiuso tutto il mistero della consegna di sé messa in atto da Gesù.
L’espressione «spezzare il pane» nella Chiesa nascente andò così a designare l’Eucaristia, dunque ciò che la caratterizzò e la tenne unita come nuova comunità. Dal ricordo dell’ultima cena però emergeva anche chiaramente che l’Eucaristia è più di un semplice atto di culto che si esaurisce nella celebrazione liturgica. Lo spezzare il pane era di per sé un’immagine di comunione, dell’unire attraverso la condivisione. I cristiani ora possono vedere nell’atto di spezzare il pane compiuto da Gesù un’immagine dell’ospitalità di Dio, nella quale il Figlio incarnato dona se stesso come pane di vita. Di conseguenza la frazione del pane eucaristico deve proseguire nello «spezzare il pane» della vita quotidiana, nella disponibilità a condividere quanto si possiede, a donare e così unire. È semplicemente l’amore in tutta la sua immensità che si manifesta in questo gesto, e con esso il nuovo concetto cristiano di culto e di cura per il prossimo: l’Eucaristia deve divenire «spezzare il pane» a tutti i livelli, altrimenti il suo significato non si compie. Deve divenire «diaconia», servizio e dono nella vita quotidiana. E specularmente la premura sociale della caritas non è mai solo agire pragmatico, bensì sorge dalle radici profonde della comunione con il Signore che si dona, dalla dinamica dell’amore partecipe di Dio per noi.
Mi rallegro che il cardinale Cordes abbia raccolto e spiegato, con grande energia, l’impulso che ho cercato di avviare con l’enciclica Deus caritas est. Saluto come parte della sua fatica questo suo libro L’aiuto non cade dal cielo. Caritas e spiritualità, in cui viene mostrato da varie prospettive quanto è racchiuso nella parola fondamentale caritas - amore. Perciò auguro a questo libro l’ascolto attento che penetra nei cuori e, andando oltre la ricezione e la lettura, conduce ad agire con amore e a una comunione più profonda con Gesù Cristo.
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- Critiche a Ratzinger, due libri (di Filippo Gentiloni)24 gennaio 2012, di Federico La Sala
Critiche a Ratzinger, due libri
di Filippo Gentiloni (il manifesto, 24 gennaio 2012)
Proprio negli ultimi giorni dell’anno scorso sono uscite alcune voci fortemente critiche nei confronti del cattolicesimo, in particolare del pontificato di Benedetto XVI. Voci particolarmente interessanti sia perché autorevoli sia, e soprattutto, perché dichiaratamente e sinceramente cattoliche: proprio per questo più significative. "Salviamo la Chiesa" è il titolo drammatico del famoso teologo Hans Küng (Rizzoli in traduzione italiana). Una «dura analisi che ripercorre la storia e gli errori del Vaticano, ne diagnostica con chiarezza i mali e propone le uniche cure possibili per risanarli, una terapia che si rifà alla più efficace delle medicine, il ritorno del cristianesimo a Gesù Cristo e alle sue parole».
Questi i principali punti che Küng vorrebbe che il Vaticano correggesse: permettere il matrimonio ai sacerdoti e ai vescovi, consentire alle donne l’accesso ai ministeri ecclesiastici, fare intervenire il clero e i laici nella elezione dei vescovi, non vietare più la comunione eucaristica di protestanti e cattolici, intesa ecumenica e collaborazione senza scuse e silenzi. Che il papa esaudisca le preghiere di moltissimi cattolici, istituisca una commissione per la riforma e convochi al più presto un concilio ecumenico. Küng insiste che non può essere salvata una chiesa innamorata del Medioevo, una chiesa patriarcale, esclusivamente maschile, caratterizzata dall’esclusivismo confessionale, fondamentalmente eurocentrica. Ma Küng conclude che non ha abbandonato la speranza che la Chiesa cattolica possa sopravvivere.
Un altro autore importante, ben noto ai lettori italiani, è Marco Politi, con il suo "Joseph Ratzinger, Crisi di un papato", Editori Laterza. Il profilo è quello di un pontefice non politico, di un papato pieno di errori di comunicazione, a partire dalla errata valutazione dell’importanza dei vescovi che si erano espressi sulla questione ebraica. E anche sulla teologia della liberazione. Per Politi un papa buon teologo, ma non buon politico e che non sa affrontare il calo dei sacerdoti nel mondo e il ruolo della donna. Una discussione aperta, dunque, destinata a continuare.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- SIAMO AL "MODELLO CRISTOLOGICO" DELLA TEOLOGIA DEL "LATINORUM" E AL "CRISTO IMPRENDITORE ALLA DON VERZE’.3 dicembre 2011, di Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- Discorso di inizio anno di Benedetto XVI per il corpo diplomatico.9 gennaio 2012, di Federico La Sala
CRISI
Il Papa: "Ora diamoci nuove regole" Monito sulla Siria: "Basta violenze"
Benedetto XVI al discorso di inizio anno per il corpo diplomatico. "Non sono colpiti solo i paesi più avanzati, ma anche quelli in via di sviluppo. Giovani frustrati e disorientati nelle loro aspirazioni ad un avvenire sereno". E sulla repressione del regime di Damasco: "La politica dialoghi, bene osservatori indipendenti" *
CITTA’ DEL VATICANO - "Nuove regole che assicurino a tutti" di vivere dignitosamente e sviluppare le proprie capacità a beneficio di tutti. Le chiede il Papa per la crisi economica che, nata in Occidente, incide anche sui Paesi in via di sviluppo. Uscire dalla crisi, dice, non significa solo "arginare le perdite individuali" o "nazionali". Parole inequivocabili che Benedetto XVI ha pronunciato parlando al Corpo diplomatico.
La crisi economica e finanziaria mondiale "non ha colpito soltanto le famiglie e le imprese dei Paesi economicamente più avanzati, ma ha inciso profondamente anche sulla vita dei Paesi in via di sviluppo", ha detto Benedetto XVI nel suo discorso d’inizio anno rivolto al Corpo diplomatico accreditato in Vaticano, nel quale ha parlato toccaro diversi temi, dalla primavera araba alle violenze contro i cristiani, dall’Africa alla libertà religiosa, "primo dei diritti umani".
Ma è sulla crisi economica che il Pontefice si è concentrato particolarmente. Nei paesi dell’Occidente dove ha avuto origine, ha detto Benedetto XVI, si è creata una situazione difficile "in cui molti, soprattutto tra i giovani, si sono sentiti disorientati e frustrati nelle loro aspirazioni ad un avvenire sereno". In particolare, infatti, "gli effetti dell’attuale momento di incertezza colpiscono particolarmente i giovani". "Dal loro malessere - ha ricordato Papa Ratzinger - sono nati i fermenti che nei mesi scorsi hanno investito, talvolta duramente, diverse regioni".
La crisi attuale è anche "politica e sociale", ha ricordato, e rappresenta "la drammatica espressione di un profondo malessere" della società. Deve diventare l’occasione per "riflettere sull’esistenza umana e sull’importanza della sua dimensione etica, prima ancora che sui meccanismi che governano la vita economica: non soltanto per cercare di arginare le perdite individuali o delle economie nazionali, ma per darci nuove regole che assicurino a tutti la possibilità di vivere dignitosamente e di sviluppare le proprie capacità a beneficio dell’intera comunità", sottolinea il Papa.
Siria, bene osservatori internazionali. Sul fronte estero, un riferimento preciso va alla crisi in Siria 1, in cui, secondo il Pontefice occorre fermare subito le violenze. "Sento una grande preoccupazione per le popolazioni dei Paesi in cui si susseguono tensioni e violenze, in particolare la Siria, dove auspico una rapida fine degli spargimenti di sangue e l’inizio di un dialogo fruttuoso tra gli attori politici, favorito dalla presenza di osservatori indipendenti".
Iraq e Medio Oriente: Riconciliazione e politiche coraggiose per la pace. Benedetto XVI ha deplorato anche i recenti attentati in Iraq 2, incoraggiando le autorità a "proseguire con fermezza sulla via di una piena riconciliazione nazionale". In Medio Oriente, il Pontefice auspica una politica coraggiosa da parte dei leader israeliani e palestinesi, in favore della pace.
Libertà religiosa primo dei diritti umani. Commentando poi, i recenti attacchi alle chiese in Nigeria 3, il Papa chiede maggiore protezione per i cristiani, che in diverse parti del mondo sono marginalizzati, senza diritti, vittime di violenza. "Nel continente africano... è essenziale che la collaborazione fra le comunità cristiane e i governi aiuti a percorrere un cammino di giustizia, di pace e di riconciliazione, in cui i membri di tutte le etnie e di tutte le religioni siano rispettati. E’ doloroso constatare che tale meta, in vari paesi di quel continente, è ancora lontana". La libertà religiosa, continua, è il "primo dei diritti umani, perché essa esprime la realtà più fondamentale della persona. Troppo spesso, per diversi motivi, tale diritto è ancora limitato o schernito".
Italia, rapporto equilibrato fra Chiesa e Stato. Per quel che riguarda l’Italia, il Papa chiede che "si continui a promuovere un rapporto equilibrato fra Chiesa e Stato e in tal modo possa essere da esempio anche per altri Paesi. "Le relazioni tra la Santa Sede e lo Stato italiano - ha aggiunto Papa Ratzinger - hanno attraversato momenti difficili dopo l’unificazione. Nel tempo, però, hanno prevalso la concordia e la reciproca volontà di cooperare, ciascuno nel proprio ambito, per favorire il bene comune".
Difendere la famiglia. Preoccupazione è stata espressa dal Papa per "le misure legislative che non solo permettono, ma talvolta addirittura favoriscono l’aborto, per motivi di convenienza o per ragioni mediche discutibili". Sullo stesso piano Benedetto XVI ha collocato anche "le politiche lesive della famiglia" che "minacciano la dignità umana e il futuro stesso dell’umanità". La famiglia, "fondata sul matrimonio di un uomo con una donna", va invece difesa, ha concluso.
* la Repubblica, 09.01.2012:
http://www.repubblica.it/esteri/2012/01/09/news/papa_nuove_regole-27796412/?ref=HREA-1
-
>A DIFESA DEL "MODELLO CRISTOLOGICO" DELLA TEOLOGIA DEL "LATINORUM" ---- Lettera del Vaticano sullo spettacolo di Romeo Castellucci: «Il Papa auspica che ogni mancanza di rispetto incontri la reazione ferma e composta della comunità cristiana» (di Andrea Tornielli).19 gennaio 2012, di Federico La Sala
Lettera del Vaticano sullo spettacolo di Castellucci
IL CONTROVERSO SPETTACOLO DI CASTELLUCCI
La Segreteria di Stato risponde all’appello di padre Cavalcoli: «Il Papa auspica che ogni mancanza di rispetto incontri la reazione ferma e composta della comunità cristiana»
di ANDREA TORNIELLI (La Stampa, 19/01/2012)
CITTÀ DEL VATICANO
Il Papa, « auspica che ogni mancanza di rispetto verso Dio, i santi e i simboli religiosi incontri la reazione ferma e composta della comunità cristiana, illuminata e guidata dai suoi pastori». Lo scrive la Segreteria di Stato in una lettera indirizzata al domenicano padre Giovanni Cavalcoli, del convento bolognese di San Domenico, che l’8 gennaio aveva inviato al Pontefice una missiva parlando dello spettacolo «Il concetto del volto del Figlio di Dio» di Romeo Castellucci, in programma al Teatro Parenti di Milano la prossima settimana. La lettera vaticana, datata 16 gennaio, è firmata dall’assessore della Segreteria di Stato, lo statunitense Brian B. Wells.
Padre Calavalcoli, nella lettera inviata a Benedetto XVI, scriveva a nome di un gruppo di fedeli definendo «indegno e blasfemo» lo spettacolo di Castellucci, un’opera «gravemente offensiva della persona del nostro Divin Salvatore Gesù Cristo». «Ci addolora inoltre in modo particolare - continuava il teologo domenicano - la consapevolezza che questo inqualificabile atto di empietà colpisca pure, benché indirettamente, la venerabile e da noi amata persona di vostra Santità», in quanto vicario di Cristo. Padre Cavalcoli osservava che l’avvenimento non rappresenta «un fenomeno casuale, isolato e senza radici», ma si inserisce in «una crescente ostilità nei confronti del cristianesimo che si sta diffondendo nel mondo, nonché di un sintomo ed effetto di un disagio e di una crisi spirituali profondi e diffusi ormai da decenni anche in Italia, in parte anche per una mancata o malintesa applicazione del Concilio Vaticano II».
Dopo aver citato le forze che dentro la Chiesa «remano contro» il Papa, Cavalcoli afferma che episodi come quello del controverso spettacolo di Castellucci «sono resi possibili non solo dagli attacchi della cosiddetta “cristianofobia”, ma anche da gravi vuoti e carenze dottrinali ed educative non dovutamente eliminati da parte di chi di dovere. Pensiamo in modo particolare - scrive il domenicano, riferendosi ai casi di pedofilia del clero - allo scandalo subito dai bambini, nei confronti del quale il Signore ha parole di estrema severità». «Siamo preoccupati - conclude Cavalcoli - per coloro che, come il Castellucci, cercano di trarre vantaggio da una situazione nella quale si fa desiderare una maggiore vigilanza da parte delle autorità civili ed ecclesiastiche».
Otto giorni dopo l’invio, dunque a stretto giro di posta, ecco la risposta della Segreteria di Stato, nella quale, citando la lettera del frate domenicano, si parla dell’opera teatrale «che risulta offensiva nei confronti del Signore nostro Gesù Cristo e dei cristiani». «Sua Santità - continua la missiva vaticana firmata dall’assessore Wells - ringrazia vivamente per questo segno di spirituale vicinanza e, mentre auspica che ogni mancanza di rispetto verso Dio, i santi e i simboli religiosi incontri la reazione ferma e composta della comunità cristiana, illuminata e guidata dai suoi pastori, le augura ogni bene per il ministero e invia di cuore l’implorata benedizione apostolica». La riproduzione originale della lettera della Segreteria di Stato è messa online da padre Cavalcoli sul sito Riscossa Cristiana e dal comitato San Carlo Borromeo.
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- ANDARE A NOI STESSI. NOTE SULLA VIA DELLA VITA, NON DELLA GUERRA E DELLA MORTE.9 novembre 2011, di Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ... - Se il Papa chiede ancora perdono. La differenza tra Wojtyla e Ratzinger ( di Luigi Accattoli)31 ottobre 2011, di Federico La Sala
VERITA’ E RICONCILIAZIONE. PAPA RATZINGER A SYDNEY, PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’: "IL RE E’ NUDO"!!! NON SOLO DEVE CHIEDERE PERDONO ALL’AUSTRALIA E ALL’ITALIA E AL "PADRE NOSTRO", MA CAMBIARE STILE DI VITA!!! Gesù, che non era schizofrenico, non si travestiva da imperatore._______________________________________________________________________________
Se il Papa chiede ancora perdono. La differenza tra Wojtyla e Ratzinger
di Luigi Accattoli (Corriere della Sera” del 30 ottobre 2011)
Le Giornate interreligiose di Assisi e i «mea culpa» sono forse le eredità wojtyliane più impegnative per Benedetto XVI: non intende eluderle, tanto centrali esse erano state nel Pontificato del predecessore, ma nel farle sue egli ambisce a correggerle in aspetti non secondari. Giovedì scorso le due sfide venivano a sommarsi, perché la prima Giornata di Assisi (1986) che egli andava a commemorare era stata anche l’occasione di un famoso «atto di penitenza» per le guerre combattute dai cattolici nella storia.
Si può dire - post factum - che il Papa teologo sia riuscito a garantire continuità e correzione insieme ad ambedue quelle imprese. Fedeltà e novità nell’articolazione della Giornata sono state evidenziate dalle cronache dell’evento che hanno dato - com’era ovvio avvenisse - minore attenzione al «mea culpa» sulle guerre che pure c’è stato, formulato con parole equivalenti a quelle del predecessore ma con un’aggiunta rivelatrice.
«Non siamo sempre stati dei costruttori di pace» aveva detto Wojtyla nel 1986, aggiungendo che quella Giornata voleva essere anche «un atto di penitenza». Benedetto ha analogamente riconosciuto che «nella storia anche in nome della fede cristiana si è fatto ricorso alla violenza» e che i cristiani ne sono «pieni di vergogna».
Fin qui le due «confessioni» si equivalgono. Ma quella di Benedetto si differenzia per un’aggiunta che riguarda il presente - non affatto privo di manifestazioni di violenza cristiana - mentre la «penitenza» wojtyliana in quell’occasione era rivolta al passato: «È compito di tutti coloro che portano una qualche responsabilità per la fede cristiana purificarla continuamente a partire dal suo centro interiore affinché sia veramente strumento della pace di Dio nel mondo».
Con questo sulle guerre sono tre i «mea culpa» pronunciati fino a oggi da Papa Benedetto: in due occasioni (12 febbraio del 2009 e il 17 gennaio 2010) aveva fatto sua la richiesta di perdono per la Shoah dettata dal predecessore e in un’altra (11 giugno 2010) aveva formulato una propria «confessione di peccato» per la pedofilia del clero.
-
> «I Comandamenti». Così fu aggiunta al Decalogo una regola in più (di A. Torno). Perché il «prossimo tuo» ha rivoluzionato la fede (di massimo Cacciari).22 ottobre 2011, di Federico La Sala
Così fu aggiunta al Decalogo una regola in più
di Armando Torno (Corriere della Sera, 22 ottobre 2011)
Esce l’ultimo volume, undicesimo della serie dedicata a «I Comandamenti», dell’editrice il Mulino. Il titolo Ama il prossimo tuo ricorda il supremo comandamento cristiano. Firmano il libro Enzo Bianchi e Massimo Cacciari. Il primo tratta nel suo saggio «Farsi prossimo con amore», il secondo analizza la «Drammatica della prossimità». Ed è dallo scritto di Cacciari che pubblichiamo un estratto nel quale il filosofo ricostruisce l’itinerario di amore (e di giustizia) che porta il cristiano a non odiare il nemico.
Diremo innanzitutto che il termine ebraico ricordato da Cacciari rea’ indica colui che è un compagno di gruppo, non scelto (può essere di etnia o un vicino appartenente a quelle dimensioni che ci precedono, come la famiglia, il clan, il popolo, il territorio).
Parola abbastanza generica, non troppo utilizzata nei libri profetici dove si preferisce il concreto, è però ben presente nella Bibbia, soprattutto nella formulazione del Decalogo. In esso quanto si riferisce al dovere sociale ha sempre come oggetto il prossimo. Per esempio, il divieto di uccidere o di commettere adulterio si riferisce al prossimo che sta alla fine di tutte le formulazioni.
Ora, l’avere unito questi due momenti sintetici, ovvero «Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Deuteronomio 6,5) e «Amerai il prossimo come te stesso» (Levitico 19,18), è la sintesi del Decalogo e di tutta la Tôrah.
Non a caso queste due dimensioni fondamentali delle «dieci parole» usano - e lo fanno soltanto questi due versetti - la formula «e amerai», we’ahavtà in ebraico. L’amore verso Dio della prima parte abbraccia la seconda, rivolta agli altri. I due amori tra l’altro, nella dimensione verticale e in quella orizzontale, si incrociano nel mezzo del Decalogo nel comandamento del sabato. Che diventa il baricentro della vita spirituale, teso tra Dio e il prossimo.
Aggiungere a questo progetto de il Mulino un comandamento è stata una sottolineatura doverosa. Non a caso esso rappresenta la sintesi dei cinque riguardanti il prossimo. Cacciari, scrivendo il percorso dell’amore verso gli altri, sino al nemico, ha anche offerto una sorta di genealogia della rivoluzione cristiana. Le cui radici sono ebraiche. Per questo l’ultima parola del Decalogo è «re’èka», ovvero «il tuo prossimo».
Perché il «prossimo tuo» ha rivoluzionato la fede
Il testo qui pubblicato è tratto dal saggio di Enzo Bianchi e Massimo Cacciari, «Ama il prossimo tuo» (pp. 144, 12), undicesimo e ultimo volume della collana «I Comandamenti» edita da il Mulino.
di Massimo Cacciari (Corriere della Sera, 22 ottobre 2011)
È necessario iniziare dai testi decisivi in cui risuona il mandatum novum: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima e tutte le tue forze e tutta la tua mente, e amerai il prossimo tuo come te stesso» (Luca 10,27). Il verbo agapán viene usato per indicare sia l’amore che è dovuto al Theós, che quello verso il prossimo, plesios. Anche la traduzione latina, proximus, rende bene l’importanza del termine: proximus è infatti un superlativo.
Non può trattarsi di un semplice «vicino». Il plesios in quanto proximus ci riguarda con una intensità che nessuna vicinanza, nessuna contingente contiguità potrebbero raggiungere. Neppure si tratta, certo, di una voce inspiegabilmente nuova, venuta da qualche misterioso altrove. Anche questo mandatum è pleroma, non katalysis della Legge, salvezza del nomos stesso nel suo radicale rinnovarsi.
Il precetto del pieno rispetto dei diritti dell’ospite, così come del compagno, dell’alleato, dell’amico era stato affermato, infatti, con pieno vigore dai profeti - e tuttavia il rea‘ del Primo Patto, che i Settanta traducono per lo più con plesios, anche quando designa lo straniero, lo concepisce sempre come legato a noi, o dal simbolo dell’ospitalità, o da rapporti di reciproca fiducia, garantiti da patti e forieri di accordi utili alle parti. Il timbro del mandatum evangelico «eccede» completamente questa dimensione. Già il fatto di accostare immediatamente l’amore per il Signore a quello per il prossimo costituirebbe vera novitas, anche se plesios qui traducesse esattamente rea‘.
Ciò che veniva comandato insieme ad altri doveri, qui completa addirittura la Prima Parola! Il Logos che sta a fondamento dell’intera vita di Israele non si esprimerebbe compiutamente, resterebbe imperfetto, se non significasse in se stesso amore per il prossimo. È evidente che plesios è chiamato, allora, in questo contesto, ad assumere una pregnanza in-audita - ma, ancor più, è evidente che la visione stessa di Dio muta per questa sua straordinaria prossimità al plesios.
Solo in un punto, forse, nel Primo Patto si giunge ad un’intuizione analoga - ed è del più grande significato che ciò avvenga in Giobbe. L’intero dramma di Giobbe potrebbe essere così interpretato: questo egli chiede, non che gli vengano risparmiati i supplizi (semmai le chiacchiere degli advocati Dei), ma che Dio gli si mostri rea‘, plesios, proximus (16,21): «come un mortale fa col suo rea‘ (plesion autoú)» egli vuole incontrarlo faccia a faccia e difendere l’uomo davanti a Lui.
Anche Mosè parlava col Signore come un uomo parla al suo rea‘ (Esodo 3,11), ma la scena in Giobbe è radicalmente mutata: in Esodo appare evidente la forma dell’accordo, anzi: dell’alleanza imperitura; rea‘ esprime qui una prossimità attuale e incontestabile; per Giobbe, invece, il Signore dovrebbe farsi rea‘; egli reclama che la relazione tra il mortale e il suo Dio divenga una relazione tra prossimi.
Si potrebbe però sostenere che Giobbe esiga la compagnia, l’amicizia, la vicinanza di Dio nel senso di quella fiduciosa reciprocità, che il termine rea‘ sostanzialmente esprime. Egli vuole amare il suo Signore come il prossimo, nell’aspetto del prossimo, ma ciò non equivale affatto a amare il prossimo come il Signore. E se ciò avviene, è evidente che il significato che attribuivamo a rea‘, e al plesios dei LXX, viene rivoluzionato. È stato detto: «Amerai il tuo prossimo (agapeseis ton plesion soú)»
 ma vi è stato anche detto: odierai il nemico, odierai chi non è con te nel vincolo delle leggi
dell’ospitalità, nel senso più ampio del termine. Ma questo non lo sanno forse anche i gentili?
ma vi è stato anche detto: odierai il nemico, odierai chi non è con te nel vincolo delle leggi
dell’ospitalità, nel senso più ampio del termine. Ma questo non lo sanno forse anche i gentili?«Questo però io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per chi vi perseguita». In Luca il paradosso dell’estrema vicinanza tra amore per Dio e amore per il prossimo; in Matteo quello della relazione che viene a stabilirsi tra plesios e echthrós, tra proximus e inimicus. Il nemico non può essere amato sul fondamento di un patto, né in vista di qualche utile, né sperando reciprocità. E tuttavia va amato come plesios. Nel termine viene compresa, cioè, la massima lontananza. Prossimo, «superlativamente» prossimo, è lo stesso nemico (l’hospes che non solo si dichiara apertamente hostis, ma addirittura inimicus, echthrós).
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- “Joseph Ratzinger. Crisi di un papato” . Un brano del libro di Marco Politi.8 ottobre 2011, di Federico La Sala
Un papato immobile. La solitudine di Benedetto XVI
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 08.10 2011)
- Pubblichiamo un brano del libro “Joseph Ratzinger. Crisi di un papato”, in uscita la prossima settimana
Le polemiche sull’affare Williamson (il vescovo lefebvriano negazionista cui Benedetto XVI toglie nel 2009 la scomunica insieme ad altri tre presuli scismatici) mette in discussione esplicitamente il modo con cui Benedetto XVI governa la Chiesa. Gli osservatori denunciano una curia allo sbando, un papa chiuso nel suo palazzo e costretto a fronteggiare una bufera che l’Osservatore Romano definisce senza esempi in tempi recenti.
Sono giorni in cui un veterano di curia confida off record: “Benché sia stato in Vaticano per più di un ventennio in qualità di prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Ratzinger non conosce affatto la curia. Ieri era chiuso nella sua stanza nel Sant’Uffizio, oggi è chiuso nel suo studio di pontefice. Lui è un teologo, non è uomo di governo. Passa metà della giornata a occuparsi dei problemi della Chiesa e l’altra metà concentrato sulle sue ricerche su Gesù”. Certo esistono intorno a lui i fedelissimi. In testa il cardinale segretario di Stato, Bertone. Ma la fedeltà non basta.
Le avvisaglie che qualcosa non funziona sul ponte di comando in Vaticano si sono intraviste presto. Se il conflitto con il mondo islamico esploso a Regensburg poteva essere ancora considerato un incidente dai più indulgenti, le cose cambiano nel 2007: allorchè va in scena a Varsavia la nomina senza precedenti - e poi la precipitosa revoca - di un vescovo informatore dei servizi segreti comunisti, l’opinione pubblica avverte l’assenza di una leadership sicura. Commentano sull’Herald Tribune gli inviati Craig S. Smith e Ian Fisher: “Sebbene la sua grande esperienza in dottrina e teologia sia indiscussa, qualche critico afferma che (a papa Benedetto) manchi una piena padronanza dell’abilità politica necessaria ad un’organizzazione così vasta e complessa come la Chiesa cattolica... C’è chi suggerisce che il papa non sia ben coadiuvato dai suoi consiglieri oppure abbia la tendenza a prendere importanti decisioni principalmente di testa sua”.
Benedetto XVI studia attentamente i dossier, che gli vengono sottoposti, però il suo modo di lavorare è tendenzialmente solitario. I contatti con i suoi collaboratori si concentrano prevalentemente nelle cosiddette “udienze di tabella”, i regolari incontri settimanali con il segretario di Stato, il Sostituto, il ministro degli esteri, i prefetti delle Congregazioni per la dottrina della fede e dei vescovi. Solo due volte l’anno si tiene la riunione collegiale dei responsabili di tutte le congregazioni. Come se il capo di stato o di governo di una potenza internazionale riunisse il consiglio dei ministri unicamente ogni sei mesi. Giovanni Paolo II riceveva singolarmente ogni due anni gli ambasciatori papali per avere il polso della situazione internazionale. Benedetto XVI concede loro un’udienza di protocollo in occasione del trasferimento ad una nuova sede.
Nessuna guida politica
Benedetto XVI non utilizza nemmeno i pranzi di lavoro, strumento di cui approfittava largamente Giovanni Paolo II. “Wojtyla governava ascoltando”, commenta lo storico Andrea Riccardi leader della comunità di sant’Egidio, e “non mangiava mai da solo”.
Così si è creato in Vaticano un clima, la cui caratteristica dominante è di “non disturbare il manovratore”. Sostiene un cardinale del Nordeuropa che Benedetto XVI “è timido, ma si impunta nel difendere le proprie idee”. Quindi è difficile fargliele cambiare. Il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato, non può o non riesce a ovviare a questo complesso di fattori. Sin dal momento della sua nomina è stato considerato dalla curia un outsider e tale continua ad essere percepito. In curia lo si ritiene responsabile di non avere mano politica (nel senso tecnico del termine) nella conduzione del governo della Santa Sede. Molti curiali hanno nostalgia del pugno di ferro dell’ex segretario di Stato Sodano e rimpiangono l’era wojtyliana in cui “c’era una linea, una visione, orgoglio di fare e parole d’ordine precise”.
Bertone è giudicato con perplessità per avere coinvolto eccessivamente il suo ruolo nei giochi della politica italiana. È ricordata la sua partecipazione ad una cena, organizzata l’8 luglio 2010 da Bruno Vespa. La presenza del cardinale finisce per avallare un favore del conduttore televisivo all’ospite principe della serata, il premier Silvio Berlusconi che tenta di convincere il commensale Pier Ferdinando Casini, leader dell’ Udc, ad entrare nel suo governo. Sapere che il massimo collaboratore del pontefice accetta (finisce) per fare da cornice ad un tete a tete squisitamente politico, suscita parecchi malumori in curia.
Il teologo che non ascolta
A Benedetto XVI si riconosce un’intelligenza particolarmente acuta, uno stile di vita austero, una vasta formazione teologica, un rifiuto di qualsiasi familismo di cordata. L’osservazione, che gli viene rivolta, è di affrontare i problemi esclusivamente secondo un’impostazione teologica. Un problema essenziale, che mette a nudo le difficoltà del governo centrale della Chiesa, riguarda l’insufficiente dibattito sulle decisioni da prendere. Rispetto alle dimensioni della comunità cattolica mondiale e allo scenario internazionale, in cui opera la Santa Sede, la discussione è praticamente asfittica. Più di un cardinale sostiene l’urgenza di lasciare che i “vescovi parlino liberamente, ascoltando cosa dicono”. Un’altra critica riguarda l’instaurarsi di un clima di eccessiva apologia del pontefice.
Lo storico Giovanni Miccoli rileva: “È come se non ci fosse chi tiene in mano il timone del governo. Papa Ratzinger scrive libri, documenti, discorsi, si concentra sul rapporto tra fede e ragione”. Il sociologo cattolico Franco Garelli soggiunge: “Si avverte una debolezza del governo istituzionale. Spesso più del consenso prevale l’ossequio”.
Teoricamente Ratzinger ha avuto presente fin dall’inizio l’esigenza di non vincolare la Chiesa nel terzo millennio al modello assolutistico. “Una Chiesa dalle dimensioni mondiali, ed in questa situazione del pianeta, non può essere governata in modo monarchico”, garantì cinque mesi prima di essere eletto. Non è stato così. In sei anni si sono tenute soltanto tre riunioni plenarie del collegio cardinalizio.
Una cattolicità divisa
Il papa ottantaquattrenne viaggia, pubblica documenti, fa i suoi interventi, ma al di là di queste attività molti fedeli percepiscono una situazione di immobilismo. Nel frattempo si approfondisce all’interno della comunità cattolica la frattura fra due grandi tendenze. Coloro che si arroccano nella riaffermazione dell’ “identità cattolica” e coloro che si aspettano una Chiesa capace di misurarsi con le tematiche nuove. Ai vertici ecclesiastici si finge di non vedere la realtà di una cattolicità divisa, dove si moltiplicano fedeli, che in tema di fede, morale, dottrina e rapporto con la società contemporanea hanno approcci lontani dal magistero pontificio. Dopo una prima fiammata di consensi, l’attrazione per papa Ratzinger è scesa. Il calo è iniziato al terzo anno di pontificato. L’Italia, con la sua copertura giornalistica quasi quotidiana, resta un caso a parte. Nell’arena internazionale Ratzinger continua ad essere percepito come personalità di alto profilo che colpisce le élites culturali. Però è diminuita la risonanza planetaria del papato.
È soprattutto la concezione del rapporto tra Chiesa e società ad aprire interrogativi sull’attuale pontificato. Questo mondo così multiforme nelle sue credenze, così secolarizzato, così irriducibile al vecchio schema di “una fede - un popolo - un’autorità di Chiesa”, e al tempo stesso così vitale nelle sue pulsioni religiose, appare alla Chiesa ratzingeriana sotto la maschera del nemico.
Benedetto XVI intravvede nello scenario contemporaneo una “multiforme azione tesa a scardinare le radici cristiane della civiltà occidentale”. A volte la situazione attuale gli sembra simile - e lo dice apertamente - al tramonto dell’impero romano. Un programma di governo Ratzinger non lo ha maipresentato. Con gli anni questa impostazione - l’aver spostato l’accento dalla progettualità alla predicazione - pesa. Papa Wojtyla ha creato il suo progetto strada facendo. Paolo VI si era posto la missione di portare a termine il concilio Vaticano II e completarlo con i documenti e le istituzioni necessari. Pio XII, dopo la seconda guerra mondiale, aveva il chiaro obiettivo di riorganizzare la “società cristiana”, modernizzandola nelle sue forme d’azione. Benedetto XVI, al fondo, è rimasto un pensatore più che un uomo di governo.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H") ---- La lettera che ’non conta nulla’ e il ... "non capire niente"!!!2 ottobre 2011, di Federico La Sala
LA GRAMMATICA
di Gianfranco Ravasi (Avvenire, 30.09.2011)
Il rabbí di Gher raccontava: «Da ragazzo non volevo applicarmi allo studio della grammatica perché la consideravo una scienza come tante altre. Più tardi, invece, mi ci sono dedicato con passione perché ho visto che i segreti della Bibbia sono legati ad essa».
Sono stato per anni docente di esegesi biblica; ho passato buona parte della mia vita a studiare le Sacre Scritture e, anche se ora la mia missione è un’altra, considero sempre il santo di oggi, Girolamo, il mio ideale patrono. Non c’è bisogno di spiegare che questo personaggio dal carattere piuttosto rubesto, morto il 30 settembre del 420 nell’aspra solitudine delle grotte di Betlemme, è stato il più famoso traduttore e studioso antico della Bibbia. Io, però, sono ricorso - per commemorarlo - a uno degli apologhi che il filosofo Martin Buber ha raccolto nei suoi Racconti dei Chassidim.
Un maestro ebreo, appartenente a questa corrente mistica mitteleuropea, ammoniva il suo discepolo sulla necessità dello studio della grammatica. Apparentemente essa è arida, è un sistema di regole, è un minuzioso gioco a incastro di elementi variabili secondo le diverse lingue. Eppure, è l’ossatura senza la quale il pensiero si sfalda, la bellezza si scolora, il messaggio si estingue. Un altro scrittore cristiano del VII secolo,
Massimo il Confessore, dichiarava: «Se non conosci le parole [umane] della Scrittura, come potrai raggiungere la Parola [divina]?». Come accade in Cristo che è Verbo divino ma è anche «carne», cioè linguaggio e realtà umana, così è per la Bibbia. Per questo, l’antica tradizione ecclesiale ha sempre esaltato come fondamentale - prima di ogni senso «spirituale» - il senso «letterale», e Lutero ribadiva che il «grammaticale» è il primo dato teologico e non solo letterario. Riflettano quelli che si vantano di letture bibliche solo «spiritualistiche», senza «grammatica»!
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- "SALVIAMO LA CHIESA": "RATZINGER HA FALLITO". IL MANIFESTO DI KUNG1 ottobre 2011, di Federico La Sala
 Il manifesto di Küng per una nuova Chiesa.
Il manifesto di Küng per una nuova Chiesa.
 "Ratzinger ha fallito"
"Ratzinger ha fallito" Anticipiamo un brano del nuovo libro di Hans Küng “Salviamo la Chiesa” (Rizzoli) Il saggio del
teologo Küng affronta gli abusi sessuali e la crisi del cattolicesimo.
Anticipiamo un brano del nuovo libro di Hans Küng “Salviamo la Chiesa” (Rizzoli) Il saggio del
teologo Küng affronta gli abusi sessuali e la crisi del cattolicesimo.
 Quello che rende malata la
situazione attuale è il monopolio del potere e della verità, il clericalismo, la sessuofobia e la
misoginia. Il papato deve essere rinnovato, ai sacerdoti non si può negare il calore di una famiglia
ed è necessaria l’ordinazione femminile.
Quello che rende malata la
situazione attuale è il monopolio del potere e della verità, il clericalismo, la sessuofobia e la
misoginia. Il papato deve essere rinnovato, ai sacerdoti non si può negare il calore di una famiglia
ed è necessaria l’ordinazione femminile.di Hans Küng (La Repubblica, 01.10.2011)
Nella situazione attuale non posso assumermi la responsabilità di tacere: da decenni, con successo alterno e, nell’ambito della gerarchia cattolica, modesto, richiamo l’attenzione sulla grande crisi che si è sviluppata all’interno della Chiesa, di fatto una crisi di leadership. È stato necessario che emergessero i numerosi casi di abusi sessuali in seno al clero cattolico.
Abusi occultati per decenni da Roma e dai vescovi in tutto il mondo, perché questa crisi si palesasse agli occhi di tutti come una crisi sistemica che richiede una risposta su basi teologiche. La straordinaria messinscena delle grandi manifestazioni e dei viaggi papali (organizzati di volta in volta come "pellegrinaggi" o "visite di Stato"), tutte le circolari e le offensive mediatiche non riescono a creare l’illusione che non si tratti di una crisi durevole. Lo rivelano le centinaia di migliaia di persone che solo in Germania nel corso degli ultimi tre anni hanno abbandonato la Chiesa cattolica, e in genere la distanza sempre maggiore della popolazione rispetto all’istituzione ecclesiastica.
Lo ripeto: avrei preferito non scrivere questo testo.
E non l’avrei scritto:
 1) se si fosse avverata la speranza che papa Benedetto avrebbe indicato alla Chiesa e a tutti i
cristiani la strada per proseguire nello spirito del concilio Vaticano. L’idea era nata in me durante
l’amichevole colloquio di quattro ore avuto con il mio ex collega di Tubinga a Castel Gandolfo, nel
2005. Ma Benedetto XVI ha continuato con testardaggine sulla via della restaurazione tracciata dal
suo predecessore, prendendo le distanze dal concilio e dalla maggioranza del popolo della Chiesa in
punti importanti e ha fallito riguardo agli abusi sessuali dei membri del clero in tutto il mondo;
1) se si fosse avverata la speranza che papa Benedetto avrebbe indicato alla Chiesa e a tutti i
cristiani la strada per proseguire nello spirito del concilio Vaticano. L’idea era nata in me durante
l’amichevole colloquio di quattro ore avuto con il mio ex collega di Tubinga a Castel Gandolfo, nel
2005. Ma Benedetto XVI ha continuato con testardaggine sulla via della restaurazione tracciata dal
suo predecessore, prendendo le distanze dal concilio e dalla maggioranza del popolo della Chiesa in
punti importanti e ha fallito riguardo agli abusi sessuali dei membri del clero in tutto il mondo;
 2) se i vescovi si fossero davvero fatti carico della responsabilità collegiale nei confronti dell’intera
Chiesa conferita loro dal concilio e si fossero espressi in questo senso con le parole e con i fatti. Ma
sotto il pontificato di Wojtyla e Ratzinger la maggior parte di loro è tornata al ruolo di funzionari,
semplici destinatari degli ordini vaticani, senza dimostrare un profilo autonomo e un’assunzione di
responsabilità: anche le loro risposte ai recenti sviluppi all’interno della Chiesa sono state titubanti e
poco convincenti;
2) se i vescovi si fossero davvero fatti carico della responsabilità collegiale nei confronti dell’intera
Chiesa conferita loro dal concilio e si fossero espressi in questo senso con le parole e con i fatti. Ma
sotto il pontificato di Wojtyla e Ratzinger la maggior parte di loro è tornata al ruolo di funzionari,
semplici destinatari degli ordini vaticani, senza dimostrare un profilo autonomo e un’assunzione di
responsabilità: anche le loro risposte ai recenti sviluppi all’interno della Chiesa sono state titubanti e
poco convincenti;
 3) se la categoria dei teologi si fosse opposta con forza, pubblicamente e facendo fronte comune,
come accadeva un tempo, alla nuova repressione e all’influsso romano sulla scelta delle nuove
generazioni di studiosi nelle facoltà universitarie e nei seminari. Ma la maggior parte dei teologi
cattolici nutre il fondato timore che, a trattare criticamente in modo imparziale i temi divenuti tabù
nell’ambito della dogmatica e della morale, si venga censurati e marginalizzati. Solo pochi osano
sostenere la KirchenVolksBewegung, il Movimento popolare per la riforma della Chiesa cattolica
diffuso a livello internazionale. E non ricevono sufficiente sostegno nemmeno dai teologi luterani e
dai capi di quella Chiesa perché molti di loro liquidano le domande di riforma come problemi
interni al cattolicesimo e nella prassi qualcuno talvolta antepone i buoni rapporti con Roma alla
libertà del cristiano.
3) se la categoria dei teologi si fosse opposta con forza, pubblicamente e facendo fronte comune,
come accadeva un tempo, alla nuova repressione e all’influsso romano sulla scelta delle nuove
generazioni di studiosi nelle facoltà universitarie e nei seminari. Ma la maggior parte dei teologi
cattolici nutre il fondato timore che, a trattare criticamente in modo imparziale i temi divenuti tabù
nell’ambito della dogmatica e della morale, si venga censurati e marginalizzati. Solo pochi osano
sostenere la KirchenVolksBewegung, il Movimento popolare per la riforma della Chiesa cattolica
diffuso a livello internazionale. E non ricevono sufficiente sostegno nemmeno dai teologi luterani e
dai capi di quella Chiesa perché molti di loro liquidano le domande di riforma come problemi
interni al cattolicesimo e nella prassi qualcuno talvolta antepone i buoni rapporti con Roma alla
libertà del cristiano.Come in altre discussioni pubbliche, anche nei più recenti dibattiti sulla Chiesa cattolica e le altre Chiese la teologia ha avuto un ruolo ridotto e si è lasciata sfuggire la possibilità di reclamare in modo deciso le necessarie riforme.
Da più parti mi pregano e mi incoraggiano di continuo a prendere una posizione chiara sul presentee il futuro della Chiesa cattolica. Così, alla fine, invece di pubblicare articoli sparsi sulla stampa, mi sono deciso a redigere uno scritto coeso ed esauriente per illustrare e motivare ciò che, dopo un’attenta analisi, considero il nocciolo della crisi: la Chiesa cattolica, questa grande comunità di credenti, è seriamente malata e la causa della sua malattia è il sistema di governo romano che si è affermato nel corso del secondo millennio superando tutte le opposizioni e regge ancora oggi. I suoi tratti salienti sono, come sarà dimostrato, il monopolio del potere e della verità, il giuridismo e il clericalismo, la sessuofobia e la misoginia e un uso della forza religioso e anche profano. Il papato non deve essere abolito, bensì rinnovato nel senso di un servizio petrino orientato alla Bibbia.
Quello che deve essere abolito, invece, è il sistema di governo medievale romano. La mia "distruzione" critica è perciò al servizio della "costruzione", della riforma e del rinnovamento, nella speranza che la Chiesa cattolica, contro ogni apparenza, si mantenga vitale nel terzo millennio.
[* * *]
Certamente alcuni sacerdoti vivono la loro condizione di celibato apparentemente senza grossi problemi e molti, a causa dell’enorme carico di lavoro che grava su di loro, non sarebbero quasi in grado di preoccuparsi di una vita di coppia o di una famiglia. Viceversa, il celibato obbligatorio porta anche a vivere situazioni insostenibili: parecchi sacerdoti desiderano ardentemente l’amore e il calore di una famiglia, ma nel migliore dei casi possono solo tenere nascosta un’eventuale relazione, che in molti luoghi diventa un "segreto" più o meno pubblico. Se poi da una relazione nascono dei figli, le pressioni provenienti dall’alto inducono a tenerli nascosti con conseguenze devastanti sulla vita degli interessati.
La correlazione tra gli abusi sessuali dei membri del clero a danno di minori e la legge sul celibato è continuamente negata, ma non si può fare a meno di notarla: la Chiesa monosessuale che ha imposto l’obbligo del celibato ha potuto allontanare le donne da tutti i ministeri, ma non può bandire la sessualità dalle persone accettando così, come spiega il sociologo cattolico della religione FranzXaver Kaufmann, il rischio della pedofilia. Le sue parole sono confermate da numerosi psicoterapeuti e psicanalisti.
È auspicabile che sia reintrodotto il diaconato femminile, ma tale misura, da sola, è insufficiente: se non viene accompagnata dal permesso di accedere al presbiterato (sacerdozio), non condurrebbe a una equiparazione dei ruoli bensì a un differimento dell’ordinazione femminile. Un servizio che dà loro la stessa dignità degli uomini, completamente diverso dalla posizione e dalla funzione subalterna che recentemente ricoprono numerose donne dei "movimenti" nell’ambito della curia romana. Che in seno alla Chiesa cattolica la resistenza, e in determinate circostanze anche la disobbedienza, possano pagare, è dimostrato dall’esempio delle chierichette. Anni fa, il Vaticano vietò a bambine e ragazze di servir messa. L’indignazione del clero e del popolo cattolico fu grande e in molte parrocchie si continuò semplicemente a tenerle. A Roma la situazione venne da principio tollerata, infine accettata. Così cambiano i tempi. Anzi, un articolo uscito il 7 agosto 2010 sull’Osservatore Romano ha elogiato questa evoluzione come il superamento di un’importante frontiera poiché oggi non si può più ascrivere alla donna alcuna "impurità" e in questo modo è stata eliminata una "disuguaglianza profonda". Quanto tempo ci vorrà ancora perché in Vaticano capiscano che lo stesso argomento vale per la consacrazione sacerdotale, meglio l’ordinazione femminile? Molto dipende dalla posizione e dall’impegno dei vescovi.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA .... Dura critica di Eco al Papa: non è un grande teologo (di Maria Antonietta Calabrò)20 settembre 2011, di Federico La Sala
Dura critica di Eco al Papa: non è un grande teologo
di Maria Antonietta Calabrò (Corriere della Sera, 20 settembre 2011)
«Non credo che Ratzinger sia un grande filosofo, né un grande teologo, anche se generalmente viene rappresentato come tale». Lo ha affermato, a due giorni dall’inizio del viaggio in Germania di Benedetto XVI, Umberto Eco intervistato dal quotidiano tedesco «Berliner Zeitung» in edicola ieri. «Le sue polemiche, la sua lotta contro il relativismo sono, a mio avviso, semplicemente molto grossolane - ha commentato Eco riferendosi ancora a papa Ratzinger - nemmeno uno studente della scuola dell’obbligo le formulerebbe come lui. La sua formazione filosofica è estremamente debole».
Per argomentare il suo giudizio Eco fa riferimento proprio alla questione del relativismo, che è stata il cuore dell’approccio di Ratzinger al declino della cultura occidentale e in particolare europea. In una risposta diretta al suo intervistatore Eco ha detto: «In sei mesi potrei organizzarle un seminario sul tema. E può starne certo: alla fine presenterei almeno venti posizioni filosofiche differenti sul relativismo. Metterle tutte insieme come fa papa Benedetto, come se ci fosse una posizione unitaria è, per me, estremamente naïf». Eco, infine, ha fatto anche un paragone con Giovanni Paolo II, sostenendo che dopo papa Wojtyla era difficile per Ratzinger essere una «big star».
«Naturalmente Eco è un grande filosofo ed un grande teologo!», commenta con una punta d’ironia Jorg Bremer, vaticanista della «Frankfurter Allgemeine Zeitung», che pochi giorni fa ha intervistato il Papa a Castelgandolfo. «Sono stato da Sua Santità e ho visto in anteprima insieme all’editore Manuel Herder la mostra che, organizzata con la Libreria editrice Vaticana, per la prima volta mette insieme le copertine di 600 diverse edizioni di opere pubblicate in 25 paesi nei 50 anni di attività scientifica dal teologo Joseph Ratzinger, un’esposizione che si sposterà presso la sede della casa editrice a Friburgo, in occasione della visita che il Papa compirà in Germania da giovedì a domenica. Mi chiedo: è questo il teologo e il filosofo con un’educazione troppo debole?». Bremer, che pure è di religione protestante, sostiene «che i due pilastri del pensiero di Ratzinger sono da una parte la teologia del dogma cattolico, dall’altro il metodo e la ratio di Platone» (il quale combatté tutta la vita per demolire l’edificio relativista dei sofisti e sostituirlo con un sistema che rendesse possibile una conoscenza certa).
La lotta contro il relativismo e le sue conseguenze che rendono «senza radici» la costruzione dell’Europa è stato il leitmotiv di tutto il pontificato di Ratzinger che già il 18 aprile 2005 nell’omelia della Missa pro eligendo Pontifice affermava: «Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare "qua e là da qualsiasi vento di dottrina", appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie».
-
> BRUXELLES. CORTE PENALE DELL’AJA. Vittime preti pedofili denunciano il Papa:"E’ colpevole di crimini contro l’umanità".13 settembre 2011, di Federico La Sala
 CORTE PENALE DELL’AJA
CORTE PENALE DELL’AJA Vittime preti pedofili denunciano il Papa
Vittime preti pedofili denunciano il Papa
 "E’ colpevole di crimini contro l’umanità"
"E’ colpevole di crimini contro l’umanità" Clamorosa iniziativa dell’associazione Snap. "Benedetto XVI ha diretta e superiore responsabilità per gli stupri e le altre violenze sessuali commesse nel mondo" *
Clamorosa iniziativa dell’associazione Snap. "Benedetto XVI ha diretta e superiore responsabilità per gli stupri e le altre violenze sessuali commesse nel mondo" *BRUXELLES - Un gruppo di associazioni delle vittime dei preti pedofili, la Snap (Survivors network of those abused by priests) e il Centro per i diritti costituzionali (Center for Costitutional Right) ha depositato oggi presso la Corte penale internazionale dell’Aja un ricorso in cui accusa il Papa e tre alti esponenti del Vaticano - il segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone, il suo predecessore, il cardinale Angelo Sodano, e il prefetto della Congregazione della dottrina della fede, cardinale William Levada - di crimini contro l’umanità per la copertura dei reati commessi da prelati contro i minori. Sul suo sito l’associazione spiega di aver deciso questo "storico passo" per proteggere "tutti i bambini innocenti e gli adulti vulnerabili".
Nella denuncia si chiede alla Corte penale internazionale di "incriminare il Papa" per la sua "diretta e superiore responsabilità per i crimini contro l’umanità degli stupri e altre violenze sessuali commesse nel mondo". Nei prossimi giorni i responsabili della Snap lanceranno un tour in Europa per illustrare le loro accuse e sostenere la denuncia al Cpi, che si occupa di crimini di guerra e contro l’umanità.
I legali delle associazioni hanno presentato all’Aja un dossier di 80 pagine ed hanno spiegato che il ricorso alla Corte internazionale si è reso necessario "poiché le azioni legali condotte a livello nazionale non sono state sufficienti a impedire che gli abusi contro i minori continuassero". La denuncia, a quanto si è appreso, riguarda in particolare cinque casi di abusi sessuali avvenuti in Congo e negli Stati Uniti e commessi da prelati provenienti dal Belgio, dall’India e dagli Usa.
Sarà ora il procuratore generale della Corte, Louis Moreno-Ocampo, a dover decidere se accogliere o meno il ricorso andando incontro al rischio di sollevare un acceso quanto delicato dibattito sul ruolo e le competenze della Cpi. La speranza dei ricorrenti è che la Corte dell’Aja decida quanto meno di aprire un’indagine preliminare per verificare se il caso rientra sotto la sua giurisdizione. La Corte penale internazionale, organismo indipendente dall’Onu, è diventata operativa il primo luglio de 2002 e, in base al trattato costitutivo sottoscritto a Roma, viene chiamata a giudicare i presunti responsabili di crimini contro l’umanità e i genocidi. L’ultima iniziativa partita della Corte è stato il mandato d’arresto emesso nei confronti di Muammar Gheddafi.
Il primo commento all’iniziativa da parte Vaticana è arrivato da Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e prefetto emerito di Propaganda Fide. "Qui c’è, dobbiamo dirlo molto concretamente, il solito tentativo anti-cattolico che tende in qualche maniera ad offuscare un’immagine che, dal punto di vista umano, è quanto di più prestigioso abbiamo nella nostra società", ha affermato il cardinale.
* la Repubblica, 13 settembre 2011
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- EU-carestia, Eu-caristia, e Magistero del "Ma voi non così! (di Enzo Bianchi).23 luglio 2011
L’eucaristia, magistero del «ma voi non così»
di Enzo Bianchi (Jesus, n. 7, luglio 2011)
Abbiamo già espresso su queste colonne la nostra sofferenza per la liturgia che dovrebbe essere luogo di comunione ed è diventata luogo di conflitto nella chiesa, ma proprio perché crediamo che l’eucaristia è il dono più grande che il Signore Gesù ci ha lasciato, vogliamo ancora ascoltarla e lasciarci istruire dal suo magistero silenzioso ma eloquente.
In quasi tutte le comunità cattoliche l’eucaristia è celebrata quotidianamente. Nei giorni feriali poche persone vi partecipano: sovente sono donne e anziane - anche loro sempre di meno - pochi gli uomini, praticamente assenti i giovani. Qualcuno potrà lamentarsi che vengono celebrate in modo troppo quotidiano, che manca la ricchezza del canto o della festa, che sono prive di una bellezza capace di meravigliare, che non si impongono e non richiamano spettatori...
Eppure, se celebrate seriamente e con consapevolezza, saranno “umili” eucaristie ma sempre con la verità di “cene del Signore”. Sì, povere e umili celebrazioni, ma il criterio per giudicarle non è la loro capacità di “fascino”, bensì se fanno risuonare per quanti vi partecipano l’“evangelo”, la buona notizia della morte e risurrezione di Gesù Cristo, se sono fonte di fiducia per la vita, fonte di speranza per il futuro, fonte di amore fraterno nella vita di famiglia e negli incontri, nel tessuto sociale dove i cristiani sono collocati, vivendo e lavorando con gli altri uomini. Sì, questa è la vera domanda che ci dobbiamo porre davanti all’eucaristia: la sua celebrazione determina qualcosa nella nostra vita, cambia i nostri pensieri e i nostri atteggiamenti sempre tentati dalla mondanità, converte le nostre vite?
È certamente molto importante, anzi decisivo, interessarsi sul “come” l’eucaristia è celebrata, ma non dobbiamo mai dimenticare che tutto ciò che noi predisponiamo o operiamo per la celebrazione può avere un solo fine: immergerci nella dinamica del mistero pasquale, quell’evento che Gesù ha raccontato con parole e gesti sul pane e sul vino.
 Ricordiamoci allora che partecipare all’eucarestia
è innanzitutto accogliere l’invito alla “tavola del Signore” (1Cor 10,21): è il Signore vivente che
invita noi, poveri e peccatori bisognosi della sua misericordia, malati assetati di guarigione,
affaticati e stanchi in cerca di riposo, umiliati e ultimi che anelano a essere riconosciuti e accettati
senza doverlo meritare... Tutti diciamo: “Signore, non sono degno...”. Così il pane è dato a tutti,
icona della condivisione, ispirazione e comando di condivisione di tutti i frutti della terra e del
lavoro umano, affinché non ci siano bisognosi nella comunità in cui si vive (cf. At 4,32).
Ricordiamoci allora che partecipare all’eucarestia
è innanzitutto accogliere l’invito alla “tavola del Signore” (1Cor 10,21): è il Signore vivente che
invita noi, poveri e peccatori bisognosi della sua misericordia, malati assetati di guarigione,
affaticati e stanchi in cerca di riposo, umiliati e ultimi che anelano a essere riconosciuti e accettati
senza doverlo meritare... Tutti diciamo: “Signore, non sono degno...”. Così il pane è dato a tutti,
icona della condivisione, ispirazione e comando di condivisione di tutti i frutti della terra e del
lavoro umano, affinché non ci siano bisognosi nella comunità in cui si vive (cf. At 4,32). Ma partecipare all’eucarestia significa anche essere coinvolti nel sacrificio di un uomo, il servo del
Signore, che ha speso e dato la sua vita per gli altri fino ad accogliere la morte violenta, la morte del giusto
in un mondo ingiusto, la morte dello schiavo in un mondo di padroni e di potenti, la morte di un uomo di
pace in un mondo violento...
Ma partecipare all’eucarestia significa anche essere coinvolti nel sacrificio di un uomo, il servo del
Signore, che ha speso e dato la sua vita per gli altri fino ad accogliere la morte violenta, la morte del giusto
in un mondo ingiusto, la morte dello schiavo in un mondo di padroni e di potenti, la morte di un uomo di
pace in un mondo violento...Non a caso, secondo il Vangelo di Luca, proprio nel contesto dell’ultima cena, dopo l’istituzione dell’eucaristia, Gesù ha detto: “Ma voi non così!” (Lc 22,26), non comportatevi come accade ogni giorno nel mondo, non come fanno tutti, non come viene spontaneo fare in base all’istinto della conservazione e della difesa di noi stessi fino a far prevalere l’amore per noi stessi senza gli altri e anche contro gli altri!
L’eucaristia è il magistero del “ma voi non così!”, della differenza cristiana, perché vuole plasmarci in uomini e donne eucaristici, capaci cioè di vivere e spendere la vita a servizio degli altri, amando gli altri fino all’estremo, fino al nemico stesso: corpo spezzato, sangue versato, sacrificio di una vita offerta e consumata nell’amore autentico dei fratelli.
E affinché comprendessimo che l’eucaristia è questo - altrimenti non è, ma si riduce a scena religiosa, sontuosità e falsità - Gesù ha anche affidato ai discepoli un gesto che la spiega e la interpreta: la lavanda dei piedi. In quel curvarsi di Gesù, in quel compiere il gesto dello schiavo nei confronti dei fratelli, Gesù ha detto parole che risuonano anche per noi oggi: “Avete capito ciò che vi ho fatto?”, avete capito che lo spezzare il pane e bere al calice è servizio ai fratelli, servizio quotidiano assunto come stile, lo stile del Signore e del Maestro?
L’eucaristia è questo! E se lo è autenticamente, allora può solo essere fonte di riconciliazione, di comunione, di amore fraterno. Se invece essa è intesa e vissuta soltanto come celebrazione, rito, come un’occasione di identità e appartenenza culturale e religiosa, se in essa si cerca la solennità come spettacolo che seduce e abbaglia, allora purtroppo è vero che noi ci dividiamo e di fronte all’eucaristia entriamo in conflitto gli uni con gli altri... Ma quello che celebriamo non è più l’eucaristia di Gesù, la cena del Signore (cf. 1Cor 11,21)! Non si può rispettare il corpo di Cristo, fissandolo nel pane e nel vino, e poi non riconoscere il corpo di Cristo che è la comunità, la chiesa, insieme di malati, poveri e peccatori che cercano di trovare senso nelle loro vite per poter pregustare la salvezza che viene dal Signore!
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI.7 luglio 2011, di Federico La Sala
 SONNO DOGMATICO, STATO DI MINORITA’, E INCAPACITA’ DI GIUDIZIO. DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! CARDINAL RAVASI, NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi coriggerete")?!
SONNO DOGMATICO, STATO DI MINORITA’, E INCAPACITA’ DI GIUDIZIO. DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! CARDINAL RAVASI, NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi coriggerete")?!
 LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI. Il cardinale Ravasi si rende conto che "è grave atrofizzare la facoltà, di cui è dotata la nostra mente, di sceverare tra vero e falso", ma continua a fare "sogni d’oro"! Un suo "mattutino" - con alcune note, a c. di Federico La Sala
LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI. Il cardinale Ravasi si rende conto che "è grave atrofizzare la facoltà, di cui è dotata la nostra mente, di sceverare tra vero e falso", ma continua a fare "sogni d’oro"! Un suo "mattutino" - con alcune note, a c. di Federico La Sala
 GIUDICARE E VALUTARE. (...) Montaigne, nei suoi Saggi non esitava ad affermare che «la cura e la spesa dei nostri padri mirano solo a riempirci la testa di sapere; di giudizio e di virtù, non se ne parla nemmeno!»
GIUDICARE E VALUTARE. (...) Montaigne, nei suoi Saggi non esitava ad affermare che «la cura e la spesa dei nostri padri mirano solo a riempirci la testa di sapere; di giudizio e di virtù, non se ne parla nemmeno!»
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- LA PIRATERIA RATZINGERIANA E LA PAROLA DI DIO: DIRITTI D’AUTORE E LETTERA DI EMBARGO.11 marzo 2011, di Federico La Sala
 LA PAROLA DI DIO, IL COPYRIGHT, E LA PIRATERIA RATZINGERIANA. LA "LUCE DEL MONDO" SONO IO! CHE SUCCESSO, QUANTI SOLDI CON I DIRITTI DI AUTORE!!!
LA PAROLA DI DIO, IL COPYRIGHT, E LA PIRATERIA RATZINGERIANA. LA "LUCE DEL MONDO" SONO IO! CHE SUCCESSO, QUANTI SOLDI CON I DIRITTI DI AUTORE!!!
 DIRITTI D’AUTORE E LETTERA DI EMBARGO. Gesù di Nazaret, Joseph Ratzinger - Benedetto XVI. Giallo sul nuovo libro del papa. Una nota di Piergiorgio Odifreddi
DIRITTI D’AUTORE E LETTERA DI EMBARGO. Gesù di Nazaret, Joseph Ratzinger - Benedetto XVI. Giallo sul nuovo libro del papa. Una nota di Piergiorgio Odifreddi
 (...) sono andato in libreria a comprare il libro del papa. Il libraio mi ha riconosciuto, e mi ha mostrato una sedicente “Lettera di embargo” che la RCS Libri aveva mandato nei giorni scorsi a tutti i librai. Poichè la cosa ha dell’inusuale (...) la riproduco qui, nonostante fosse ovviamente da tenere “segreta” (...)
(...) sono andato in libreria a comprare il libro del papa. Il libraio mi ha riconosciuto, e mi ha mostrato una sedicente “Lettera di embargo” che la RCS Libri aveva mandato nei giorni scorsi a tutti i librai. Poichè la cosa ha dell’inusuale (...) la riproduco qui, nonostante fosse ovviamente da tenere “segreta” (...)
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! PER IL CARDINALE RAVASI E’ LO STESSO!!! Dalla cattedra dei non credenti al cortile dei gentili. Una nota di Piero Stefani3 marzo 2011, di Federico La Sala
 DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! PER IL CARDINALE RAVASI E’ LO STESSO!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi corigerete")?!
DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! PER IL CARDINALE RAVASI E’ LO STESSO!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi corigerete")?!
 PROPAGANDA RATZINGERIANA A PARIGI: IL CORTILE DEL TEMPIO APERTO AL DIALOGO TRA MERCANTI ATEI E DEVOTI. Dalla cattedra dei non credenti al cortile dei gentili. Una nota di Piero Stefani
PROPAGANDA RATZINGERIANA A PARIGI: IL CORTILE DEL TEMPIO APERTO AL DIALOGO TRA MERCANTI ATEI E DEVOTI. Dalla cattedra dei non credenti al cortile dei gentili. Una nota di Piero Stefani
 In luogo della «cattedra dei non credenti», la Chiesa universale ora lancia un’iniziativa chiamata «cortile dei gentili». Affidata al Pontificio Consiglio della Cultura (prefetto card. Ravasi), il «cortile» è stato preinaugurato un paio di settimane fa a Bologna; mentre l’avvio ufficiale avverrà a Parigi verso fine marzo.
In luogo della «cattedra dei non credenti», la Chiesa universale ora lancia un’iniziativa chiamata «cortile dei gentili». Affidata al Pontificio Consiglio della Cultura (prefetto card. Ravasi), il «cortile» è stato preinaugurato un paio di settimane fa a Bologna; mentre l’avvio ufficiale avverrà a Parigi verso fine marzo.
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- Il Gesù storico secondo Ratzinger (di Vito Mancuso)11 marzo 2011, di Federico La Sala
Il Gesù storico secondo Ratzinger
di Vito Mancuso (la Repubblica, 11 marzo 2011)
Nel primo libro su Gesù pubblicato nel 2007 Benedetto XVI chiedeva ai lettori «quell’anticipo di simpatia senza il quale non c’è alcuna comprensione». Aveva ragione, perché occorre essere ben disposti verso l’autore di un libro o di una musica, come verso ogni persona che si incontra, per poter adeguatamente comprendere. È necessario però capire bene il senso della simpatia richiesta dal pontefice: nell’ambito teologico in cui si colloca non si tratta di un semplice sentimento, il quale peraltro c’è o non c’è perché nasce solo spontaneamente. Simpatia va intesa qui nel senso originario di patire-con, coltivando un comune pathos ideale. La domanda quindi è: qual è il pathos che ha mosso Benedetto XVI a pubblicare due volumi su Gesù di oltre 800 pagine complessive, di cui oggi arriva in libreria il secondo che riguarda, recita il sottotitolo, il periodo «dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione»?
La preoccupazione del Papa concerne il problema decisivo del cristianesimo odierno, a confronto del quale i cosiddetti "valori non negoziabili" (scuola, vita, famiglia) sono acqua fresca: cioè il legame tra il Gesù della storia reale e il Cristo professato dalla fede. Senza scuole cattoliche il cristianesimo va avanti, senza leggi protettive sulla famiglia e la bioetica lo stesso, anzi non è detto che una dieta al riguardo non gli possa persino giovare. Ma senza il legame organico tra il fatto storico Gesù (Yeshua) e quello che di lui la fede confessa (che è il Cristo) tutto crolla, e alla Basilica di San Pietro non resterebbe che trasformarsi in un museo. Nella fondamentale premessa del primo volume, una specie di piccolo discorso sul metodo, il Papa si chiede "che significato può avere la fede in Gesù il Cristo (...) se poi l’uomo Gesù era così diverso da come lo presentano gli evangelisti e da come, partendo dai Vangeli, lo annuncia la Chiesa", domanda retorica la cui unica risposta è "nessun significato" e da cui appare quanto sia decisiva la connessione storia-fede.
Chiaro l’obiettivo, altrettanto lo è il metodo: «Io ho fiducia nei Vangeli (...) ho voluto fare il tentativo di presentare il Gesù dei Vangeli come il Gesù reale, come il Gesù storico in senso vero e proprio»; concetto ribadito nella premessa del nuovo volume dove l’autore scrive di aver voluto «giungere alla certezza della figura veramente storica di Gesù» a partire da «uno sguardo sul Gesù dei Vangeli». Il Papa fa così intendere che mentre l’esegesi biblica contemporanea perlopiù divide il Gesù storico reale dal Cristo dei Vangeli e della Chiesa, egli li identifica mostrando che la costruzione cristiana iniziata dagli evangelisti e proseguita dai concili è ben salda perché poggia su questa esatta equazione: narrazione evangelica = storia reale. Questo è l’intento programmatico su cui Benedetto XVI chiede la sua "simpatia".
Peccato per lui però che in questo nuovo volume egli stesso sia stato costretto a trasformare il segno uguale dell’equazione programmatica nel suo contrario: narrazione evangelica ? storia reale.
Il nodo è la morte di Gesù, precisamente il ruolo al riguardo del popolo ebraico, questione che travalica i confini dell’esegesi per arrivare nel campo della storia con le accuse di "deicidio" e le immani tragedie che ne sono conseguite. Chiedendosi "chi ha insistito per la condanna a morte di Gesù", il Papa prende atto che "nelle risposte dei Vangeli vi sono differenze": per Giovanni fu l’aristocrazia del tempio, per Marco i sostenitori di Barabba, per Matteo "tutto il popolo" (su Luca il Papa non si pronuncia, ma Luca è da assimilare a Matteo). E a questo punto presenta la sorpresa: dicendo "tutto il popolo", come si legge in 27,25, "Matteo sicuramente non esprime un fatto storico: come avrebbe potuto essere presente in tale momento tutto il popolo e chiedere la morte di Gesù?".
Sono parole veritiere e coraggiose (per le quali sarebbe stato bello che il Papa avesse fatto il nome dello storico ebreo Jules Isaac e del suo libro capitale del 1948 Gesù e Israele, purtroppo ignorato), ma che smentiscono decisamente l’equazione programmatica che è il principale obiettivo di tutta l’impresa papale, cioè l’identità tra narrazione evangelica e storia reale.
Alle prese con uno dei nodi più delicati della storia evangelica, il Papa è stato costretto a prendere atto che i quattro evangelisti hanno tre tesi diverse, e che una di esse «sicuramente non esprime un fatto storico». Se questa incertezza vale per uno degli eventi centrali della vita di Gesù, a maggiorragione per altri. Ne viene quello che la più seria esegesi biblica storico-critica insegna da secoli, cioè la differenza tra narrazione evangelica e storia reale.
Significa allora che tutta la costruzione cristiana crolla? No di certo, significa piuttosto che essa è, fin dalle sue origini, un’impresa di libertà. Non è data nessuna statica verità oggettiva che si impone alla mente e che occorre solo riconoscere, non c’è alcuna "res" al cui cospetto poter presentare solo un’obbediente "adaequatio" del proprio intelletto, non c’è nulla nel mondo degli uomini che non richieda l’esercizio della creativa responsabilità personale, nulla che non solleciti la libertà del soggetto.
La libertà di ciascun evangelista nel narrare la figura di Gesù è il simbolo della libertà cui è chiamato ogni cristiano nel viverne il messaggio. Se persino di fronte ai santi Vangeli la libertà del soggetto è chiamata a intervenire discernendo ciò che è vero da ciò che "sicuramente non esprime un fatto storico", ne viene che non esiste nessun ambito della vita di fede dove la libertà di coscienza non debba avere il primato (compresa la libertà di non prendere così tanto sul serio l’etichetta "valori non-negoziabili" apposta dal Magistero alla triade scuola-famiglia-vita). Affrontare seriamente la figura di Gesù, come ha fatto Benedetto XVI in questo suo nuovo libro, significa essere sempre rimandati alla dinamica impegnativa e responsabilizzante della libertà
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ----- CONTRO LA LEZIONE DI DI GIOVANNI PAOLO II. Le parole del testo greco "chaire" e "kecharitoméne" presentano tra loro una profonda connessione (1996).15 gennaio 2011, di Federico La Sala
CON GRANDE CARISMA ("CHARISMA")! FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, TEOLOGIA.
L’angelo Gabriele, rivolgendosi alla Vergine di Nazaret, dopo il saluto chaire, "rallegrati", la chiama kecharitoméne, "piena di grazia". Le parole del testo greco chaire e kecharitoméne presentano tra loro una profonda connessione (...)
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE --- YOUCAT. Una nuova versione del Catechismo della Chiesa cattolica per i giovani firmato da Benedetto XVI (di Aldo M. Valli).)3 febbraio 2011, di Federico La Sala
 GATTO ("CAT") E TOPO ("MOUSE")!
GATTO ("CAT") E TOPO ("MOUSE")!
 "YOUCAT": UN MANUALE DI AGGIORNAMENTO PER LA GIOVENTU’ CAT-TOLICA PER DIVENTARE ESPERTI ACCHIAPPA-TOPI!!! *
"YOUCAT": UN MANUALE DI AGGIORNAMENTO PER LA GIOVENTU’ CAT-TOLICA PER DIVENTARE ESPERTI ACCHIAPPA-TOPI!!! *
Youcat, abbiate fede
di Aldo Maria Valli (Europa, 2 febbario 2011)
Quando i giovani di tutto il mondo si ritroveranno a Madrid, nel prossimo agosto, per la Giornata mondiale della gioventù, avranno nei loro zaini, assieme al sacco a pelo, alla lampada per leggere sotto la tenda e alla mappa della città, un dono tutto particolare, firmato Benedetto XVI. Si tratterà di Youcat, nuova versione del Catechismo della Chiesa cattolica pensato proprio per i giovani del nostro tempo, con prefazione dell’attuale papa.
Ma perché il pontefice vuole che i giovani possiedano e, possibilmente, leggano il catechismo? È lui stesso a spiegarlo nelle pagine iniziali, anticipate nel fascicolo di febbraio del mensile Il messaggero di sant’Antonio: questo libro, dice il papa, è straordinario sia per il suo contenuto, sia per il modo in cui è nato.
Youcat nasce infatti, per così dire, da una costola del nuovo catechismo voluto da Giovanni Paolo II negli anni Ottanta del secolo scorso, quando papa Wojtyla si rese conto della necessità di alfabetizzare di nuovo i credenti, troppo spesso ignari delle principali verità della fede e della dottrina cattolica.
Il compito di coordinare il gruppo di lavoro (un lavoro immane) fu assegnato all’allora cardinale Joseph Ratzinger, che oggi confessa tutto il suo spavento di fronte a un simile incarico. I dubbi sulla riuscita dell’impresa erano forti, anche perché i vescovi chiamati a collaborare provenivano da tutto il mondo e c’erano grossi problemi di coordinamento. «Anche oggi - scrive il papa - mi sembra un miracolo il fatto che questo progetto alla fine sia riuscito». Gli incontri si fecero via via più frequenti e piano piano, nonostante le difficoltà, il nuovo testo prese forma e sostanza. Ne uscì un documento semplice nella struttura ma sostanzioso nei contenuti, elaborato a partire dalle domande alle quali tutti i credenti dovrebbero saper rispondere: che cosa crediamo, in che modo celebriamo, in che modo dobbiamo pregare?
Il papa non nasconde che durante la lavorazione ci furono anche scontri, inevitabili in simili casi, perché «tutto ciò che gli uomini fanno può essere migliorato», ma l’obiettivo era chiaro a tutti: riuscire a parlare davvero a ogni persona, all’operaio come al professionista, all’europeo come all’americano, all’africano o all’asiatico, al colto come all’incolto, al giovane come all’anziano. Ne venne fuori un testo che, per forza di cose, mediava tra le diverse esigenze.
Nel frattempo papa Wojtyla aveva inventato le giornate mondiali della gioventù, e subito ci si pose il problema di come trasmettere i contenuti del nuovo catechismo, in modo efficace, ai milioni di giovani coinvolti in quelle iniziative. Ecco, Youcat vuole essere la risposta a quella domanda. Un catechismo per i giovani, pensato appositamente per loro che vivono nel mondo globalizzato e connesso dalle nuove tecnologie.
Lo “stile Ratzinger” tuttavia non viene meno. «Questo sussidio al catechismo - spiega - non vi adula; non offre facili soluzioni; esige una nuova vita da parte vostra». Nessuna concessione al giovanilismo. Piuttosto un nuovo modo di presentare le verità di sempre, con una raccomandazione molto diretta da parte del papa: «Studiate il catechismo con passione e perseveranza! Studiatelo nel silenzio della vostra camera, leggetelo in due, se siete amici. Formate gruppi e reti di studio, scambiatevi idee su Internet. Rimanete ad ogni modo in dialogo sulla vostra fede! Dovete conoscere quello che credete; dovete conoscere la vostra fede con la stessa precisione con cui uno specialista di informatica conosce il sistema operativo di un computer».
Papa Benedetto sa bene che i casi di pedofilia nella Chiesa possono aver causato l’allontanamento di tanti giovani, e dice: «Non prendete questo a pretesto per fuggire al cospetto di Dio! Portate il fuoco intatto del vostro amore in questa Chiesa ogni volta che gli uomini ne oscurano il volto!».
Youcat, stampato in tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese e polacco, farà dunque compagnia ai giovani che si riuniranno a Madrid ma, nelle intenzioni del papa, dovrà essere anche il principale strumento di quella nuova evangelizzazione da lui tanto auspicata nei paesi di anticatradizione cristiana che hanno perso progressivamente coscienza dei fondamenti della religione cattolica spostandosi sempre di più verso una fede fai da te.
*
Nota:
GATTO ("CAT") E TOPO ("MOUSE"): UN MANUALE DI AGGIORNAMENTO PER LA GIOVENTU’ CATTOLICA PER DIVENTARE ESPERTI ACCHIAPPA-TOPI - "YOUCAT"!!! *
BENEDETTO XVI, LA "LUCE DEL MONDO" SONO "IO"!!! CHE SUCCESSO, QUANTI SOLDI CON I DIRITTI DI AUTORE!!!
Dio è Amore ("charitas"), non "Mammona" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006)!!!
NUOVO CATECHISMO: PENA DI MORTE E TEOLOGIA DEGLI AFFARI: DIO E’ MAMMONA ("CARITAS")"
Nuovo Catechismo, art. 2267: “L’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell’ identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte”.
PAROLA DI DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?! La prima enciclica di Papa Benedetto XVI (Deus caritas est, 2006) è per Mammona!!! LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
BENEDETTO XVI, LA "LUCE DEL MONDO" SONO "IO"!!! CHE SUCCESSO, QUANTI SOLDI CON I DIRITTI DI AUTORE!!!
PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI.
Federico La Sala
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE --- I GUASTI DEL DENARO, ULTIMO TOTEM. Il libro di Vittorino Andreoli, "Il denaro in testa", fa ripensare al peso di questo fattore, nefasto ma sempre mutevole (di Salvatore Bragantino)..19 febbraio 2011, di Federico La Sala
I guasti del denaro, ultimo totem
di Salvatore Bragantini (Corriere della Sera, 19 febbraio 2011)
Il libro di Vittorino Andreoli, Il denaro in testa (Rizzoli), fa ripensare al peso di questo fattore, nefasto ma sempre mutevole. Tutta la storia dell’uomo narra le violenze fatte e le angherie subite, nel nome dei suoi grandi totem: il denaro e le religioni. Dio e Mammona hanno sempre trovato nel potere i loro modi di sontuosa convivenza; nel reciproco interesse. Alla fine, Andreoli elenca i bisogni veri dell’uomo: la sicurezza, l’amore, la continuità della vita attraverso i figli, la serenità e la gioia (più necessarie della libertà, scrive, e viene in mente l’arringa a Gesù del Grande Inquisitore) e così via.
«Per nessuno di questi bisogni serve il denaro, semmai aiuta a soddisfarli meglio». È questo, però, il problema. Certo, le società moderne sono tanto disossate da far dire a Margaret Thatcher (che ci ha messo del suo): «La società non esiste». Non credo però che, neanche in quell’era dorata che ci pare il nostro Rinascimento, si vivesse come in un’orchestra nella quale, «se tutti sono adeguatamente coordinati e danno il loro contributo all’insieme, la vita può diventare l’esecuzione della Nona sinfonia di Beethoven».
Da tempo, certo, il denaro deborda ben oltre i limiti propri di una convivenza ordinata. Da quando la società anonima ha circoscritto le responsabilità degli investitori, sono partite innovazioni che hanno rivoluzionato la vita; la ricchezza mobiliare fa a meno della terra, onde l’aristocrazia traeva potere e ricchezza. Ciò aumenta il numero dei ricchi, quindi la paura di diventare poveri; è chi sta male a sperare di stare meglio. I guadagni sono celati, le perdite lamentate in pubblico.
La finanza ha messo il turbo ai guadagni privati e alle perdite che le crisi finanziarie addossano al contribuente; se si può anticipare l’incasso anche di anni lontani, la tentazione di vendersi il vitello in pancia alla vacca mina il futuro. Ma il passato, aureo o no, non tornerà. Fra il 1950 e la metà degli anni Settanta gli eccessi del denaro non erano così visibili e dannosi. Le disuguaglianze erano minori. Le paghe dei megamanager avevano un rapporto con il loro lavoro, erano cinquanta volte quelle dei loro dipendenti, non cinquecento o mille; la deontologia professionale reggeva. Ciò costava nell’immediato, ma la reputazione era fonte di guadagni futuri; gli auditor non certificavano bilanci falsi per tenersi il cliente, le banche - settore sonnolento - non concedevano mutui farlocchi da rifilare a sprovveduti, vogliosi di strappare un lacerto di carne. La fine dello spauracchio comunista allentò le difese del capitalismo, mostrandone il volto peggiore; gli incassi immediati contarono più della reputazione.
I giudizi di Andreoli su finanzieri e imprenditori paiono a volte troppo tranchant; se (quasi tutti) sono mossi dalla maledetta fame di denaro, accostarli ai criminali è un po’ forte. E magari non è il mondo a essere mutato, ma la maggior esperienza di vita a mettere a nudo la realtà. Poco praticabili sono poi alcune sue ricette: sarebbe sì desiderabile che la psicologia dettasse all’economia la «giusta distribuzione dei compiti e dei mezzi... tenendo conto delle differenze, degli impegni e delle necessità di ognuno».
I tanti tentativi in tal senso della politica, tuttavia, pur ispirati alle migliori intenzioni, dicono che l’economia di mercato è il peggior allocatore delle risorse, a parte gli altri sistemi: come quella democrazia che con lei si è sviluppata, ma che dai suoi eccessi è messa a rischio. Ignoriamo gli esiti di una grave crisi che di quelle disuguaglianze s’è nutrita e deve ancora dispiegare le sue conseguenze economiche, sociali e politiche; la difesa, coltello fra i denti, della ricchezza impaurita ci darà forse brutte sorprese.
La direzione presa dal sistema negli ultimi trent’anni - più economia di business che di mercato - può farci tornare al punto di partenza; con la democrazia che conserva le forme ma trasmuta in aristocrazia, non della terra ma del denaro. Se per essere eletti servono troppi soldi, vince il più ricco o chi meglio si vende ai vested interest; con l’aiuto, troppo ignorato, di una tv che ha prima unito l’Italia, poi sfibrato gli italiani.
Le parole di Andreoli evocano nel lettore la sapienza laica - per cui è sventurato l’uomo che non dona e muore ricco - e religiosa: dalla «preghiera semplice» di Francesco - «È dando che si riceve» - al Vangelo: «Eppure vi dico che nemmeno Salomone in tutto il suo splendore fu mai vestito come i gigli del campo». Se hai bisogno di aiuto, si dice, chiedilo a un povero, lui ti aiuterà.
La ricchezza ci chiude, invece di aprirci al dono; fortunato chi per la cruna dell’ago sfugge a questa morsa. La povertà oggi diviene peccato, dice l’autore; peggio, il governo la considera spesso reato. Chi nasce povero ha più probabilità di restarlo oggi che nello scorso secolo breve.
La meta dell’uguaglianza dei punti di partenza, topos della democrazia liberale, che è morta con la tassa di successione, va risuscitata; deve però cessare l’atomizzazione dei saperi, deprecata dall’autore, per cui gli intellettuali più non leggono i libri di economia. Le colpe sono equamente ripartite, ma ricordiamolo: Adam Smith insegnava filosofia morale, non econometrica.
-
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- L’ITALIA E LA LOBBY DEL "DEUS CARITAS": MIRAFIORI E IL VANGELO DI MARCHIONNE (E DI BENEDETTO XVI E BERLUSCONI)11 gennaio 2011
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- SE LA VIOLENZA E’ QUELLA DEL PAPA (di don Enzo Mazzi).11 gennaio 2011, di Federico La Sala
Se la violenza verbale è quella del papa
di Enzo Mazzi (il manifesto, 11.01.2011)
I media hanno bisogno di parole forti per poter vendere. Raramente va in prima pagina il discorso dialettico, l’argomentare capace di confrontarsi col pensiero dell’altro. La sparata al contrario conquista immediatamente i titoloni e diviene argomento privilegiato delle chiacchiere da bar. La politica si adegua o forse essa stessa promuove questa subcultura dell’eccesso che spesso è individuazione del nemico da abbattere sia esso persona o idea. Finché l’eccesso straborda dalle colonne dei giornali e dalle agenzie di stampa e arriva ad armare fisicamente la mano omicida.
Se ne lamenta lo sceriffo di Tucson, Clarence Dupnik, tanto per uscire dal nostro pollaio di casa così denso di sparate di ogni colore, che di fronte al sangue di Gabrielle Giffords e delle altre vittime, davanti all’ipermercato Safeway, ha denunciato le sparate al vetriolo, gli slogan che aizzano la rabbia delle folle, di certa gente «che nelle tv e le radio della destra ha trasformato l’odio per gli avversari politici in un business».
Si adegua la politica e si adegua la religione. Anche lei, la religione del potere, bisognosa di bucare il video. Chi presterebbe attenzione alle parole dei prelati e dello stesso papa se si limitassero a recitar giaculatorie? Ci vogliono parole forti, condanne sopra le righe, individuazione di nemici della fede.
Benedetto XVI è un fine ragionatore, e talvolta fa notizia per le sue sottigliezze come quella sulla «passabilità» dell’uso del profilattico da parte delle prostitute o dei prostituti, che non si è capito se è principio di liceità etica o sovrana concessione. Ma anche lui infine deve cedere alla legge attuale della comunicazione: deve sparar condanne che facciano scalpore. «Profeti di sventura» li chiamò papa Giovanni.
L’ultima è venuta dal discorso d’inizio anno al corpo diplomatico in cui il papa ha parlato della «minaccia» che l’educazione sessuale e civile, impartita nelle scuole di alcuni Paesi europei, costituisce per la libertà religiosa insieme ai veti sui simboli religiosi e le feste. È davvero difficile non vedere l’eccesso nell’indicare come «minaccia» della libertà religiosa l’educazione sessuale e civile nelle scuole.
Chi sarebbe il nemico? Il professore Emilio Arisi, fondatore dei primi consultori in Italia, che ogni anno in collaborazione con la SIGO, società italiana ginecologi, organizza corsi nelle scuole. Lo fa - egli ha detto in una intervista a Repubblica pubblicata ieri - per «rompere la barriera dell’ignoranza. Perché ho conosciuto ragazzine convinte che la Coca Cola fosse un anticoncezionale, che se facevano l’amore in piedi non sarebbero rimaste incinta, che una lavanda al limone salvava da un rapporto non protetto». O Carlo Flamigni che ha scritto un libro sulla «pillola del giorno dopo», l’uso della quale specialmente fra i teenager ha visto un vero boom «perché - egli dice - si arriva alla contraccezione di emergenza di massa a causa della disinformazione».
Ogni educatore sa quanto sia deleterio il ritardo e la carenza della scuola, specialmente delle scuole cattoliche, della famiglia, della società nel suo insieme su questi temi. Favorisce e non ostacola la libertà religiosa e un pacifico convivere civile educare i giovani a una sessualità consapevole e responsabile offrendo anche una visione, non proselitistica, della fede religiosa e cristiana liberata dai sensi di colpa, dalla violenza del sacro che promana dalla stessa esibizione generalizzata del crocifisso, sacrificato per i nostri peccati, e anche da feste quali la Immacolata Concezione strettamente legata al dogma della verginità fisica di Maria diffuso coi catechismi in spregio alla sessualità.
Confondere la libertà religiosa con la libertà di dominare le coscienze da parte dei poteri religiosi attraverso l’ignoranza, che è anche ignoranza del Vangelo e dei messaggi di liberazione presenti in tutte le religioni, è roba da medioevo che si insinua nella post-modernità attraverso gli eccessi mediatici.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- La fede del carbonaio (di Christine Gilbert - “La Croix”)11 gennaio 2011, di Federico La Sala
 La fede del carbonaio (ovvero delle persone semplici)
La fede del carbonaio (ovvero delle persone semplici) di Christine Gilbert
di Christine Gilbert “La Croix” dell’8 gennaio 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)
“La Croix” dell’8 gennaio 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)Parlando con dei ragazzi, ho usato l’espressione “la fede del carbonaio” [ndr. “la foi du charbonnier” è un’espressione francese per indicare la fede delle persone semplici]. I ragazzi non avevano mai sentito quell’espressione... In un altro contesto, con degli adulti che seguivano un corso di formazione, ho detto che non c’è più “la fede del carbonaio”, molto semplicemente perché di carbonai non ce ne sono, o ce ne sono ben pochi nella nostra società. Era un invito, da parte mia, a formarsi, ad approfondire, ad avere una fede in relazione con il nostro tempo e con la nostra società, una fede d’informatico, di manager, di disoccupato, d’ingegnere, d’impiegato, ecc. Ma un pensionato mi ha ripreso, per spiegarmi come la fede del carbonaio fosse auspicabile...
È un’espressione che valorizza la fede proposta a tutti, indipendentemente dal livello intellettuale e sociale. Che ammira la fede del cuore, la fiducia cieca in Dio. Che sottolinea la capacità di comprendere e vivere la fede da parte della gente semplice. È una cosa formidabile! Ma è servita anche a rifiutare delle domande pertinenti, a nascondere la paura di una fede che non sapeva affrontare la necessità di rimettersi in discussione, se non anche a denigrare “gli intellettuali”. Oggi, la nostra società postmoderna, tecnica, scientifica, globalizzata, ha bisogno di “carbonai di questo tempo”, di credenti che le corrispondano, che abbiano familiarità sia con la fede che con i problemi della società.
Per questo può essere necessario informarsi, confrontarsi con altri e aprirsi. La formazione permette di approfondire la propria fede personale, di radicarsi nella parola di Dio, di comprendere e di amare la Chiesa, di accogliere una Rivelazione sconvolgente. È un percorso esigente, talvolta scottante, che insegna a far rimare passione e ragione, a comportarsi da cristiani, ad avere la fede del XXI secolo, a situarsi nella grande tradizione della Chiesa. La formazione cristiana aiuta anche a testimoniare, ad usare le parole adatte, comprensibili per l’interlocutore, a porre dei gesti significativi, ad accompagnare cammini diversi, ad essere duttili perché si è solidi.
Lo sforzo di approfondimento aiuta ad avanzare sui grandi problemi contemporanei, permette di beneficiare delle ricerche in corso. Ad esempio, il pluralismo religioso cambia il modo di proporre la fede? A proposito di indifferenza religiosa, come proporre la fede a delle persone che, rientrando a casa dopo lunghe giornate al lavoro e sui mezzi di trasporto, hanno un solo desiderio, quello di essere lasciate in pace? La secolarizzazione: nella società occidentale, in cui tutti i bisogni umani apparentemente sono soddisfatti, quale spazio rimane per Dio? E così via.
Questo mondo appassionante invita a reinventare proposte e parole che parlino davvero, a partecipare alla ricerca del senso della vita, a condividere, senza presunzione, la speranza e la fede in Cristo morto e risorto. La fede cristiana è un’esperienza da vivere, non un’idea. È da vivere con intelligenza e da dispiegare in tutte le sfaccettature dell’esistenza. L’approfondimento religioso aiuta a vivere da cristiani nel mondo che ci è donato.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- “Imparate l’affettività”. A lezione con i sacerdoti... A ventiquattr’ore dal monito papale contro l’educazione sessuale obbligatoria, al Vicariato di Roma è partito il corso per educatori su «affettività, amore e sessualità» (di Giacomo Galeazzi)12 gennaio 2011, di Federico La Sala
 GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! - CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! - CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! A LEZIONE DI AFFETTIVITA’ DA SACERDOTI E CATECHISTI, CHE NON SANNO NULLA DELL’AMORE DI GIUSEPPE E MARIA E CHE CONTRABBANDANO L’AMORE PIENO DI SOLDI ("CARITAS") COME AMORE PIENO DI GRAZIA ("CHARITAS"). Una nota di Giacomo Galeazzi, con alcune note
A LEZIONE DI AFFETTIVITA’ DA SACERDOTI E CATECHISTI, CHE NON SANNO NULLA DELL’AMORE DI GIUSEPPE E MARIA E CHE CONTRABBANDANO L’AMORE PIENO DI SOLDI ("CARITAS") COME AMORE PIENO DI GRAZIA ("CHARITAS"). Una nota di Giacomo Galeazzi, con alcune note (...) A ventiquattr’ore dal monito papale contro l’educazione sessuale obbligatoria, al Vicariato di Roma è partito il corso per educatori su «affettività, amore e sessualità», per contribuire a un’educazione sessuale cristianamente fondata (...)
(...) A ventiquattr’ore dal monito papale contro l’educazione sessuale obbligatoria, al Vicariato di Roma è partito il corso per educatori su «affettività, amore e sessualità», per contribuire a un’educazione sessuale cristianamente fondata (...)__________________________________________________________________
“Imparate l’affettività”. A lezione con i sacerdotidi Giacomo Galeazzi (La Stampa, 12. 01.2011)
A lezione di affettività da sacerdoti e catechisti. «La Chiesa non può tacere sul tema della sessualità: nell’educazione bisogna insistere sull’affettività». L’educazione cristiana non può e non deve prescindere dall’affettività e dal rapporto uomo-donna. Perciò i preti devono riscoprire e potenziare il lavoro di «accompagnamento spirituale» dei fedeli. «Affettività, questione antropologica, stili di vita fondati sui valori», annuncia il segretario generale della Cei, Mariano Crociata.
A ventiquattr’ore dal monito papale contro l’educazione sessuale obbligatoria, al Vicariato di Roma è partito il corso per educatori su «affettività, amore e sessualità», per contribuire a un’educazione sessuale cristianamente fondata. Oggi, sostiene Crociata, «non può essere perseguita una educazione cristiana che non abbia una visione, una parola, un modello da indicare circa il rapporto uomo-donna». Inoltre «l’evoluzione intervenuta nella mentalità e nella prassi di tante persone richiede una posizione chiara e coerente sul piano antropologico ed etico, e quindi anche culturale e spirituale, oltre che su quello teologico». Se manca tale posizione «il rischio è semplicemente di risultare insignificanti e di far apparire insignificante la stessa proposta cristiana». Via libera ad insegnare «affettività» in scuole e parrocchie.
Non però la sessualità ridotta a «meccanica» come per l’insegnamento obbligatorio dell’educazione sessuale negli istituti nel Regno Unito (per tutti gli studenti dai 15 anni in su e senza possibilità di esenzione) dove l’episcopato ribadisce che «l’educazione dei giovani nelle scuole deve essere organizzata nell’ambito di un processo che li aiuti a sviluppare stili di vita salutari e rispettosi della santità della vita».
L’obiettivo è fare in modo che «i giovani abbiano più stima in se stessi e credano al valore della vita matrimoniale, proteggendoli dalle pressioni esterne che invitano le nuove generazioni a praticare una vita sessuale precoce e ad avere relazioni sessuali al di fuori del matrimonio». E’ necessaria «la collaborazione tra genitori, insegnanti e comunità parrocchiali nell’educazione cattolica dei giovani» perché «mantenere i giovani nell’ignoranza dei fatti, ovvero impedire una comprensione adatta all’età delle forme di contraccezione e dei suoi rischi, oppure nascondere le conseguenze negative dell’aborto, non contribuisce a ridurre le gravidanze in età adolescenziale». Un’esigenza comune ai vari paesi. La nostra opera educativa - evidenzia il numero due della Chiesa italiana - è irrilevante se non tocca questioni che riguardano l’identità della persona particolarmente decisive nel nostro tempo».
Tra le «questioni decisive» il vescovo Crociata ha elencato «l’ambito dell’affettività», «l’attenzione alle età della vita» e «il conseguimento di una sintesi compiuta di maturità umana e cristiana». Su questo aspetto, ha invitato ad evitare il rischio della «dissociazione tra fede e vita, tra culto e occupazioni profane, tra servizio ecclesiale e responsabilità pubbliche, insomma tra credente e cittadino».
Visto che è in gioco la verità e l’autenticità della proposta cristiana i sacerdoti devono «recuperare ampiamente, se non privilegiare risolutamente, l’accompagnamento spirituale delle persone in una relazione educativa che conferisce forza decisiva alla maturazione personale». Citando Benedetto XVI, Crociata puntualizza che «anche i più grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati, vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta personale».
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA ---- E IL DISASTRO ANTROPOLOGICO. L’invito del segretario della Cei, monsignor Mariano Crociata, è a «superare le risse, le guerre di tutti contro tutti» (di Roberto Monteforte)29 gennaio 2011
I vescovi staccano la spina: «Italia, disastro antropologico»
di Roberto Monteforte (l’Unità, 29 gennaio 2011)
«Siamo di fronte a un disastro antropologico: fermiamoci in tempo prima che degeneri ancora di più». L’invito del segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata è a «superare le risse, le guerre di tutti contro tutti», a recuperare «oggettività» e «pacatezza» per perseguire il «bene comune» e l’«interesse del paese». Questo chiedono i vescovi al termine del loro Consiglio permanente. «Ma pacatezza non vuole dire mancanza di indignazione». Precisa il segretario della Cei, attento a dare voce anche allo sconcerto e all’indignazione di tanta parte del mondo cattolico scandalizzato da quanto è emerso dalla «vicenda Ruby» che ha coinvolto il premier Berlusconi. Assicura che i vescovi si ritrovano pienamente nell’analisi accorta e preoccupata del presidente della Conferenza episcopale, cardinale Angelo Bagnasco.
Presentando ai giornalisti il documento conclusivo della Conferenza permanente il vescovo insiste molto sul bisogno di «mantenere pacatezza ed equità di giudizio, tanto più in un clima che, per ragioni oggettive, si fa più teso».
PACATEZZA E SCONCERTO
È solo così che per la Cei è possibile uscire dall’attuale situazione di crisi. Questo però chiarisce rispondendo a l’Unità, non vuole dire «lasciare marcire i problemi» o «restare indifferenti», ma guardare le cose «con sforzo di oggettività, volontà di risolvere, ciascuno secondo le responsabilità che ricopre». «Non vedo contrapposizione - ha voluto sottolineare - tra indignazione e pacatezza». Mette in guardia. «Finchè la ricerca del bene del Paese viene strumentalizzata e resta tacciabile di essere una difesa di parte, si prolunga la difficoltà di prendere in mano la situazione». Senza alzare i toni i vescovi confermato quanto detto dal loro presidente, Bagnasco. Compreso l’allarme sul degrado morale, ancora meno sostenibile se si considera l’impegno della chiesa per l’«emergenza educativa» e l’esigenza di offrire, in particolare ai giovani, valori positivi e di speranza. È esplicito Crociata. «Chi ha maggiori responsabilità ha un maggiore impegno a risultare esemplare nel suo comportamento, nella sua vita, affinché le giovani generazioni crescano secondo un modello di autentica riuscita morale».
Nelle sue parole non vi sono riferimenti diretti al «caso Ruby» e alle accuse rivolte dalla magistratura al premier Berlusconi. Non è compito della Chiesa - sottolinea il vice di Bagnasco - prendere una posizione «politica», come sull’eventualità di elezioni anticipate come esito della drammatica crisi politica del Paese. «Gli sviluppi di temi strettamente politici - chiarisce Crociata - sono affidati agli attori responsabili di questi sviluppi e dei meccanismi istituzionali che presiederanno a questo ambito». «Tutti - ha aggiunto Crociata - siamo chiamati a seguire gli eventi con senso civico per il bene della vita del paese, perché questo momento di tensione va superato».
Ha pure chiarito come l’attenzione della Chiesa ai temi etici non si limiti soltanto all’inizio e «al fine» vita. A proposito del «federalismo fiscale» i vescovi chiedono attenzione a «non produrre divari tra una parte e l’altra dell’Italia», salvaguardandone «l’unità».
Sull’inchiesta G8 che vede coinvolto oltre all’ex ministro Lunardi anche il cardinale Sepe per quando era a capo di «Propaganda Fide», monsignor Crociata ha espresso la sua solidarietà al porporato ora arcivescovo di Napoli, ma anche fiducia nella magistratura, confidando «che le cose saranno chiarite nelle sedi opportune».
-
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE ---- ALLA DOMANDA DELL’ECONOMISTA MICHELE SALVATI, RISPONDE IL CARDINAL TONINI E CERCA DI RICORDARE COSA SIGNIFICAVA ALL’ORIGINE ESSERE "AMMINISTRATORE DI CARITA’" ("CHARITAS").23 aprile 2009, di Federico La Sala
PERCHÉ LA CHIESA NON FA PIÙ CARITÀ E MENO POLITICA? ALLA DOMANDA DELL’ECONOMISTA MICHELE SALVATI, RISPONDE IL CARDINAL TONINI.
IL CARDINALE TONINI CERCA DI RICORDARE COSA (a se stesso, alla cei, e al papa) SIGNIFICAVA ALL’ORIGINE ESSERE "AMMINISTRATORE DI CARITA’", MA CONTINUA A NEGARE L’ERRORE DI AVER SCAMBIATO PER TROPPO TEMPO "ERODE" CON "CESARE", e "DIO" CON "MAMMONA"!!! (Federico La Sala)
IL CASO
MICHELE SALVATI: PERCHÉ LA CHIESA NON FA PIÙ CARITÀ E MENO POLITICA?
Nell’articolo pubblicato ieri sulla prima pagina del « Corriere della Sera » , l’economista Michele Salvati mette in evidenza il largo consenso raccolto da alcune iniziative promosse in tempi recenti dalla Chiesa italiana a sostegno di poveri e disoccupati e dei terremotati dell’Abruzzo. E si chiede: « Perché la Chiesa non accentua questa sua missione di carità più di quanto, o almeno quanto, essa sottolinea la sua intransigenza in materie di procreazione assistita o di testamento biologico? ». Secondo Salvati, la Cei si comporta a volte come soggetto politico, per contrastare l’approvazione di provvedimenti che a suo giudizio configgono con i principi da essa difesi. *
Comportamento legittimo, riconosce, ma che la porta a subire « le logiche e le oscillazioni, del consenso » . Non converrebbe dunque alla Cei, conclude Salvati, concentrarsi maggiormente su un terreno, quello della carità, « in cui di sconfitte non ne può subire? »
TONINI
La Chiesa ama tutta la persona
DI FRANCESCO OGNIBENE (Avvenire, 22.04.2009)
A 95 anni, la lettura di un articolo di giornale può infiammarlo come un ventenne. Al cardinale Ersilio Tonini i ragionamenti di Michele Salvati ieri sulla prima pagina del Corriere della Sera hanno suscitato un torrente di riflessioni: perché, a loro modo, sono andati al cuore delle ragioni per le quali la Chiesa sta in mezzo agli uomini come un riferimento certo, riconoscibile, fedele. Dal terremoto ai grandi temi del dibattito pubblico.
Eminenza, Salvati scrive che la Chiesa farebbe meglio ad accentuare la carità rispetto ad altro...
È un articolo sostanzialmente positivo, ma con un punto debole.
Quale?
Si dimentica che la Chiesa non può non amare l’uomo, tutto l’uomo. La verità è che egli è un mistero immenso, il più grande apparso sulla Terra. Non è solo il cristianesimo a dirlo: l’avevano già intuito i greci, ci sono pagine magnifiche a documentarlo. Pensi a I persiani di Eschilo, la tragedia che narra la battaglia di Salamina con l’attenzione non tanto rivolta alle operazioni belliche quanto alle mamme persiane cui tocca di ascoltare notizie sui loro figli, impegnati nei combattimenti, da messaggeri che le raggiungono a turno. Per l’autore l’accento non è sul trionfo militare ma sulla grandezza d’animo delle madri. Questo è l’uomo.
In terra d’Abruzzo la Chiesa sta mostrando una volta ancora il suo impegno caritativo. Ma viene capito lo spirito dal quale è mosso?
È giusto, e anche bello, che venga notata l’opera di tanti uomini di Chiesa che testimoniano come la carità non sia un’enunciazione generica ma un lasciarsi scegliere dalla realtà più vera, quella più dura, ovvero dalle esigenze primarie dell’uomo. C’è infatti una graduatoria per la Chiesa nei suoi interventi, difficile da definire a priori perché le urgenze umane sono infinite. I grandi pastori, i maestri nella Chiesa, sono quelli che hanno avuto il coraggio di fare una scelta degli obiettivi cui dedicare il meglio delle proprie forze. Don Bosco puntò sui ragazzi, con una scelta che parrebbe affettiva e invece è ispirata da straordinaria sapienza. San Francesco Saverio è l’uomo dell’ardimento, che spalanca orizzonti, non in forza di uno slancio fine a se stesso ma per un’intuizione ispirata. C’è un’intelligenza profonda in queste scelte, ieri come oggi, che non sempre viene colta. Anche oggi ci sono strade da aprire, in nome di una vocazione e di un mandato che urge nel cuore della Chiesa di ogni tempo.
Anche davanti al terremoto?
La Chiesa coglie segnali. Il mondo greco, come quello medievale, aveva capito che tutti i grandi problemi, compreso quello dello Stato, al dunque si riducono alla grande questione dell’uomo, che è sempre fine e mai strumento. È ciò che la Chiesa ha ricevuto come mandato: non è solo l’uomo a meritare la massima stima e attenzione ma soprattutto la persona umana più debole, quella che ha meno potenzialità naturali. Che gli ultimi siano destinati a diventare i primi è Gesù stesso a dirlo.
Quando si muove sul terreno della carità la Chiesa riceve un consenso pressoché unanime. Come lo spiega?
«Perché la sua è l’azione più pura, quella nella quale meno si vede emergere la potenza umana, supplita dal meglio dell’uomo racchiuso nella paternità e maternità.
Salvati si chiede perché allora la Chiesa non accentua questa sua missione di carità - che riscuote tanti applausi - anziché insistere sui nodi della bioetica. Come risponde?
È una domanda che pare opportuna e che invece mi sembra un po’ sfasata. E le spiego perché. Il parroco - lo sono stato anch’io, a suo tempo - è l’amministratore della carità, non solo dei sacramenti; egli aiuta anzitutto ogni uomo a riconoscere la propria missione, il posto che occupa nel suo tempo, nella comunità, nella storia. Il buon parroco è colui il quale aiuta ciascun giovane a scoprire la sua vocazione, la destinazione nella vita, persino il mestiere cui è chiamato. Intendo dire che il compito primo della Chiesa è aiutare ognuno a trovare la propria ragion d’essere, a capire che è Dio il suo vero bene. La sublimità della vita si svela grazie all’incontro dell’uomo con Dio, che ha voluto addirittura imparentarsi con lui: non poteva stimarlo più di così. Per questo la Chiesa difende fieramente l’uomo da ogni degrado. Ma se si legge la Chiesa solo come erogatrice di opere buone - per quanti applausi raccolga - un simile orizzonte scompare.
È per impulso di questa certezza che la Chiesa si esprime anche sui temi della vita?
Chi dubita che debba farlo dovrebbe venire qui, all’Opera Santa Teresa di Ravenna, dove ho scelto di vivere. Lo porterei a visitare il reparto dei bambini cerebrolesi: vedrebbe una meraviglia infinita dentro quelle creature, e un’infinita tenerezza in chi le assiste. Avrebbe un motivo di stupore continuo di fronte alla materializzazione dell’humanitas. Attraverso le opere di carità la gente tocca con mano cos’è la Chiesa, a cosa è ispirata la sua presenza. Ed è grazie alla fedeltà della Chiesa alla propria identità che all’uomo di ogni epoca è garantito di restare uomo, con tutta la sua dignità.
Ma c’è chi obietta che quando la Chiesa parla di procreazione o fine vita, smette di essere ’caritatevole’ e inizia a far politica.
Quando ricorda chi è l’uomo la Chiesa esprime la massima esaltazione della persona umana. Si parla di testamento biologico, ma si intende il momento in cui l’uomo si ammala, diventa più debole e rischia proprio per questo di contare meno, di essere meno uomo. Chi, e perché, lo difende? La politica consiste forse nel comporre graduatorie, nel far pesare di più chi è sano, nel mettersi d’accordo su chi ha valore e chi no? L’aveva intuito già Socrate, con una specie di presentimento del messaggio cristiano: il più debole non vale meno del più forte, perché ciò che conta non è la potenza o la ricchezza ma la capacità di amare.
Scrive ancora Salvati: non converrebbe alla Chiesa concentrarsi sul terreno nel quale non teme concorrenza - la carità, appunto - anziché scendere nell’arena delle idee, dove la sua immagine può venire ridimensionata?
Ma senza princìpi, cosa valgono tutte le sue opere? Siamo di fronte a un sintomo che rivela il degrado della nostra cultura, incline a dare più valore a ciò che sembra meglio rispondere al clima del momento. La Chiesa ha il dovere di ricordare a tutti - con la parola e le opere - qual è il criterio sul quale misurare il valore dell’uomo. È forse il denaro, l’efficienza, la salute? O risiede in altro? La carità mostra cos’è questo ’altro’, non soggetto al fascino di alcuna propaganda.
Parlare con nettezza di inizio e fine vita espone al rischio dell’impopolarità...
Ma non si può credere che soccorrere i terremotati sia una cosa e parlare della dignità della vita umana sia tutt’altro! È un errore formidabile. Nelle nostre famiglie quali sono i momenti più solenni? La nascita e la morte, l’inizio e la fine della vita. E che dire della malattia, ovvero del momento in cui l’uomo è più fragile? Di questo si occupa la Chiesa: di tutto l’uomo, dal principio alla fine, in ogni circostanza della vita, specie quando attraversa la prova. Non si danno due cuori, due intelligenze, due Chiese.
Eppure c’è chi continua a contrapporre un volto all’altro...
Nella Chiesa c’è una maternità verso i più deboli che rispecchia la maternità naturale, ovvero il rapporto più umano che esista. Dico di più: trovo pienamente me stesso accanto ai bambini ospiti in questa struttura di Ravenna, che sembrano deformi ma danno un volto all’essere umano più fragile di cui in ogni famiglia ci si prende cura con speciale attenzione. Il cuore con cui la Chiesa cammina tra le macerie d’Abruzzo e si china sulle fragilità umane è lo stesso con cui insegna il Vangelo della vita. Ci sono valori più alti da testimoniare. Diversamente, perché i missionari partirebbero per l’Africa, l’Asia o l’America Latina? Benedico la Chiesa, la benedico per davvero, perché è la comunità dove i più deboli sono quelli che contano di più. Essere cristiani vuol dire testimoniare questo in ogni epoca, e interpretare le esigenze del tempo, rendersi responsabili dell’umanità del proprio momento storico. Aiutare l’uomo a ritrovare la sua grandezza.
Eppure, si legge ancora sul Corriere, gli italiani non apprezzerebbero quel che dice la Chiesa sulla vita...
Ma per fortuna c’è qualcuno che considera l’uomo come sommo valore! No, non credo a questa affermazione, anche perché nessuno ha mai rimproverato la Chiesa per essersi presa cura degli uomini. Cosa ci dicono giganti della fede come don Orione se non questo? Salvati lo elogia: giusto, ma a patto di ricordare che don Orione non era solo un uomo di buon cuore. La sua carità era mossa da un’intelligenza superiore e da un ardimento senza pari. Le opere non camminano senza la fede, la sapienza e il coraggio.
*
Nella sez. delle Lettere al Corriere (22.04.200), all’intervento di Savino Pezzotta, così replica Michele Salvati:
"Non ho sostenuto che l’azione della Chiesa debba ridursi a carità o filantropia, ma ho espresso l’auspicio che questo apspetto prevalga rispetto a quello di testimoniare - e chiedere che lo Stato recepisca nelle sue leggi - ciò che ritiene Verità su alcuni temi eticamente sensibili. Pezzotta sa meglio di me che non pochi di coloro che hanno recentemente assecondato la Cei in questa sua azione sono pronti ad abbandonarla se si accorgono che non è redditizia in termini di consenso politico. E lo vedremo presto" (Corriere della Sera, 22.04.2009, p. 37).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- E’ la crisi della leadership di Papa Benedetto e della curia romana. La severa opinione del movimento internazionale "Noi Siamo Chiesa".21 aprile 2009, di Federico La Sala
La severa opinione del movimento internazionale "Noi Siamo Chiesa" sui quattro anni del pontificato di Benedetto XVI *
 Pubblicato il 20 Aprile 2009
Pubblicato il 20 Aprile 2009
 a.. Documenti NSC
a.. Documenti NSC
 Roma/ Madrid / Monaco 16 Aprile 2009 In occasione del 4° Anniversario del Pontificato di
Roma/ Madrid / Monaco 16 Aprile 2009 In occasione del 4° Anniversario del Pontificato di
 Papa Benedetto, "Noi siamo Chiesa" fa la richiesta di profonde e urgenti riforme. Fiduciosi
Papa Benedetto, "Noi siamo Chiesa" fa la richiesta di profonde e urgenti riforme. Fiduciosi
 nello Spirito Santo e nello Spirito del Concilio.
nello Spirito Santo e nello Spirito del Concilio.Il movimento Internazionale Noi siamo Chiesa, in occasione del 4° Anniversario dell’elezione di Papa Benedetto ( 19 Aprile 2005) rinnova la richiesta al Papa, a tutti i vescovi e a tutti i credenti affinché rimangano fedeli agli indirizzi e allo spirito promosso dal Concilio Vaticano II.
Il tentativo incerto del Papa di riportare all’unità i Lefebriani, a inizio anno, ha segnato un rifiuto degli insegnamenti e dello spirito del Concilio Vaticano II. (1962-65). Questo Concilio, tra i tanti risultati positivi, ha promosso una nuova visione della collegialità, dell’ecumenismo e il Il dialogo inter-religioso, specialmente con gli ebrei, ha promosso la libertà religiosa, la libertà di coscienza, anche nei confronti della Chiesa, e una positiva considerazione della società, insieme ad una liturgia in cui tutti si sentano coinvolti.
Benché la decisione autonoma di Papa Benedetto sia stata presentata come un tentativo di riunificare i cattolici, in effetti è risultato un cattivo servizio verso la Chiesa Cattolica in quanto comunità di fede e in quanto istituzione presente nel mondo di oggi. In un periodo di grave crisi sociale ed economica e con tanti problemi di carattere ecologico, Noi siamo Chiesa deplora il fatto che la Chiesa Cattolica,essendo la comunità più numerosa nel mondo, abbia perso molta della sua credibilità a causa della crisi interna alla Chiesa.
 Questa è una crisi di leadership
Questa è una crisi di leadership
 E’ la crisi della leadership di Papa Benedetto e della curia romana.
E’ la crisi della leadership di Papa Benedetto e della curia romana.Il Papa persiste con uno stile di governo della Chiesa che non concede nulla alla trasparenza, all’autorevolezza e persino alla stessa competenza. Le speranze di milioni di cristiani, riposte sul Concilio Vaticano II e sulla promessa fatta dal Papa subito dopo la sua elezione, per promuovere l’ecumenismo e la collegialità, ben prest, sono rimaste deluse .
C’è una progressiva delusione per l’involuzione nell’attività pastorale: Conservando l’obbligatorietà della legge del celibato e quella che vieta l’ordinazione delle donne, il Papa nega il diritto canonico che garantisce ai fedeli la partecipazione eucaristica della domenica (can. 213 CIC Codice di Diritto Canonico) nelle comunità attive. Tutti questi fatti e Il mantenimento dei riti preconciliari Tridentini e la preghiera modificata per la conversione degli ebrei, nel Venerdì Santo, sono solo alcune prove che indicano che Papa Ratzinger si è incamminato verso una contro-riforma in opposizione al Concilio Vaticano II. Il Papa, durante la sua recente visita in Africa, ha parlato con particolare accento contro la corruzione, il tribalismo, la violenza sulle donne, a favore del buon governo e della sicurezza dei confini. Tuttavia, il suo infelice intervento su l’uso del condom per prevenire l’AIDS ha distolto l’attenzione da tali argomenti. L’enfasi e l’insistenza data alla discussione sull’aborto, su l’uso del condom, ecc. hanno oscurato i messaggi più importanti quali l’impegno per la giustizia, la pace e la lotta per assicurare a tutte le popolazioni "il loro pane quotidiano".
A questo proposito Noi siamo Chiesa pensa che sia importante sottolineare che il Papa non dovrebbe considerare le varie critiche, manifestate in tutto il mondo, come segno di ostilità nei suoi confronti, ma piuttosto come espressione di preoccupazione per il modo come viene governata la Chiesa, come d’altra parte è previsto nel can. 213 § 3 CIC : " Tutti i cristiani... hanno il diritto e, talvolta, persino il dovere di esprimere la loro opinione ai sacri pastori sui problemi riguardanti il bene della Chiesa e di far conoscere la loro opinione a tutta la Cristianità".
Petizione internazionale da presentare alla Congregazione della Fede:
L’enorme risposta data alla petizione internazionale "Per una totale accettazione dei decreti del Concilio vaticano II," promossa dal Movimento Internazionale Noi siamo Chiesa è prova della reale aspettativa di numerosi teologi, sacerdoti, membri delle congregazioni religiose, operatori nel campo della pastorale e numerosissimi fedeli in tutto il mondo per una riforma della nostra Chiesa secondo gli indirizzi del Concilio Vaticano II.
La petizione (www.petition-vaticanum2.org) ha raccolto 50.000 firme durante il Giovedì Santo.
I promotori di questa iniziativa, ora, vogliono presentare questi risultati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) a Roma al più presto possibile.
-
> SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ---- Il Papa: la Scrittura può essere compresa soltanto nella Chiesa.24 aprile 2009, di Federico La Sala
Ieri mattina Benedetto XVI ha ricevuto in udienza i membri della Pontificia Commissione Biblica.
Di seguito il testo del discorso pronunciato dal Papa. (Avvenire, 24.04.2009)
 Il Papa: la Scrittura può essere compresa soltanto nella Chiesa
Il Papa: la Scrittura può essere compresa soltanto nella Chiesa Alla Pontificia Commissione Biblica: lo studio scientifico dei testi sacri non basta
Alla Pontificia Commissione Biblica: lo studio scientifico dei testi sacri non basta Tre i criteri indicati dal Vaticano II per una retta interpretazione: attenzione al contenuto e all’unità di tutta la Sacra Scrittura, l’inserimento nel contesto della Tradizione vivente della Chiesa, e l’analogia della fede, ossia «la coesione delle singole verità tra di loro e con il piano complessivo della Rivelazione»
Tre i criteri indicati dal Vaticano II per una retta interpretazione: attenzione al contenuto e all’unità di tutta la Sacra Scrittura, l’inserimento nel contesto della Tradizione vivente della Chiesa, e l’analogia della fede, ossia «la coesione delle singole verità tra di loro e con il piano complessivo della Rivelazione» «L’interpretazione delle Scritture non può essere solo uno sforzo scientifico individuale, ma deve essere sempre confrontata, inserita e autenticata dalla Tradizione vivente della Chiesa.
L’esegeta cattolico non nutre l’illusione individualista che, al di fuori della comunità dei credenti, si possano comprendere meglio i testi biblici»
«L’interpretazione delle Scritture non può essere solo uno sforzo scientifico individuale, ma deve essere sempre confrontata, inserita e autenticata dalla Tradizione vivente della Chiesa.
L’esegeta cattolico non nutre l’illusione individualista che, al di fuori della comunità dei credenti, si possano comprendere meglio i testi biblici»Signor cardinale, cari membri della Pontificia Commissione Biblica, sono lieto di accogliervi ancora una volta al termine della vostra annuale Assemblea plenaria. Ringrazio il signor cardinale William Levada per il suo indirizzo di saluto e per la concisa esposizione del tema che è stato oggetto di attenta riflessione nel corso della vostra riunione. Vi siete nuovamente radunati per approfondire un argomento molto importante: l’ispirazione e la verità della Bibbia. Si tratta di un tema che riguarda non soltanto il credente, ma la stessa Chiesa, poiché la vita e la missione della Chiesa si fondano necessariamente sulla Parola di Dio, la quale è anima della teologia e, insieme, ispiratrice di tutta l’esistenza cristiana. Il tema che avete affrontato risponde, inoltre, a una preoccupazione che mi sta particolarmente a cuore, poiché l’interpretazione della Sacra Scrittura è di importanza capitale per la fede cristiana e per la vita della Chiesa.
Come ella ha già ricordato, signor presidente, nell’enciclica Providentissimus Deus papa Leone XIII offriva agli esegeti cattolici nuovi incoraggiamenti e nuove direttive in tema di ispirazione, verità ed ermeneutica biblica. Più tardi Pio XII nella sua enciclica Divino afflante Spiritu raccoglieva e completava il precedente insegnamento, esortando gli esegeti cattolici a giungere a soluzioni in pieno accordo con la dottrina della Chiesa, tenendo debitamente conto dei positivi apporti delle scienze profane. Il vivo impulso dato da questi due Pontefici agli studi biblici ha trovato piena conferma nel Concilio Vaticano II, cosicché tutta la Chiesa ne ha tratto beneficio. In particolare, la Costituzione conciliare Dei Verbum illumina ancora oggi l’opera degli esegeti cattolici e invita i pastori e i fedeli ad alimentarsi più assiduamente alla mensa della Parola di Dio.
Il Concilio ricorda, al riguardo, innanzitutto che Dio è l’Autore della Sacra Scrittura: «Le cose divinamente rivelate che nei libri della Sacra Scrittura sono contenute e presentate, furono consegnate sotto l’ispirazione dello Spirito Santo. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché, scritti sotto ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore e co- D me tali sono stati consegnati alla Chiesa» ( Dei Verbum, 11). Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, invisibile e trascendente Autore, si deve dichiarare, per conseguenza, che «i libri della Scrittura insegnano fermamente, fedelmente e senza errore la verità che Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle sacre Lettere» ( ibid., 11).
Dalla corretta impostazione del concetto di divina ispirazione e verità della Sacra Scrittura derivano alcune norme che riguardano direttamente la sua interpretazione. La stessa Costituzione Dei Verbum, dopo aver affermato che Dio è l’autore della Bibbia, ci ricorda che nella Sacra Scrittura Dio parla all’uomo alla maniera umana. Per una retta interpretazione della Scrittura bisogna dunque ricercare con attenzione che cosa gli agiografi hanno veramente voluto affermare e che cosa è piaciuto a Dio manifestare con le loro parole. «Le parole di Dio infatti, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al linguaggio degli uomini, come già il Verbo dell’eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell’umana natura, si fece simile agli uomini » ( Dei Verbum, 13).
Queste indicazioni, offerte per una corretta interpretazione di carattere storico-letterario, richiedono un indispensabile collegamento con le premesse della dottrina sull’ispirazione e verità della Sacra Scrittura. Infatti, essendo la Sacra Scrittura ispirata, c’è un sommo principio di retta interpretazione senza il quale gli scritti sacri resterebbero lettera morta: la Sacra Scrittura deve «essere letta e interpretata con l’aiuto dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta» ( Dei Verbum, 12).
Al riguardo, il Concilio Vaticano II indica tre criteri sempre validi per una interpretazione della Sacra Scrittura conforme allo Spirito che l’ha ispirata. Anzitutto occorre prestare grande attenzione al contenuto e all’unità di tutta la Scrittura. Infatti, per quanto siano differenti i libri che la compongono, la Sacra Scrittura è una in forza dell’unità del disegno di Dio, del quale Cristo Gesù è il centro e il cuore (cfr Lc 24,25-27; Lc 24,44-46). In secondo luogo occorre leggere la Scrittura nel contesto della Tradizione vivente di tutta la Chiesa. Secondo un detto dei Padri « Sacra Scriptura principalius est in corde Ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta » ossia «la Sacra Scrittura è scritta nel cuore della Chiesa prima che su strumenti materiali». Infatti la Chiesa porta nella sua Tradizione la memoria viva della Parola di Dio ed è lo Spirito Santo che le dona l’interpretazione di essa secondo il senso spirituale (cfr Origene, Homiliae in Leviticum, 5,5). Come terzo criterio è necessario prestare attenzione all’analogia della fede, ossia alla coesione delle singole verità di fede tra di loro e con il piano complessivo della Rivelazione e la pienezza della divina economia in esso racchiusa.
Il compito dei ricercatori che studiano con diversi metodi la Sacra Scrittura è quello di contribuire secondo i suddetti principi alla più profonda intelligenza ed esposizione del senso della Sacra Scrittura. Lo studio scientifico dei testi sacri non è da solo sufficiente. Per rispettare la coerenza della fede della Chiesa l’esegeta cattolico deve essere attento a percepire la Parola di Dio in questi testi, all’interno della stessa fede della Chiesa. In mancanza di questo imprescindibile punto di riferimento la ricerca esegetica resta incompleta, perdendo di vista la sua finalità principale, con il pericolo di diventare addirittura una sorta di mero esercizio intellettuale.
L’interpretazione delle Sacre Scritture non può essere soltanto uno sforzo scientifico individuale, ma deve essere sempre confrontata, inserita e autenticata dalla Tradizione vivente della Chiesa. Questa norma è decisiva per precisare il corretto e reciproco rapporto tra l’esegesi e il Magistero della Chiesa. L’esegeta cattolico non nutre l’illusione individualista che, al di fuori della comunità dei credenti, si possano comprendere meglio i testi biblici. È vero invece il contrario, poiché questi testi non sono stati dati ai singoli ricercatori « per soddisfare la loro curiosità o per fornire loro degli argomenti di studio e di ricerca» ( Divino afflante Spiritu, EB 566). I testi ispirati da Dio sono stati affidati alla comunità dei credenti, alla Chiesa di Cristo, per alimentare la fede e guidare la vita di carità. Il rispetto di questa finalità condiziona la validità e l’efficacia dell’ermeneutica biblica. L’enciclica Providentissimus Deus ha ricordato questa verità fondamentale e ha osservato che, lungi dall’ostacolare la ricerca biblica, il rispetto di questo dato ne favorisce l’autentico progresso.
Essere fedeli alla Chiesa significa, infatti, collocarsi nella corrente della grande Tradizione che, sotto la guida del Magistero, ha riconosciuto gli scritti canonici come parola rivolta da Dio al suo popolo e non ha mai cessato di meditarli e di scoprirne le inesauribili ricchezze. Il Concilio Vaticano II lo ha ribadito con grande chiarezza: «Tutto quello che concerne il modo di interpretare la Scrittura è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa, la quale adempie il divino mandato e ministero di conservare e interpretare la Parola di Dio» ( Dei Verbum, 12).
Come ci ricorda la summenzionata Costituzione dogmatica esiste una inscindibile unità tra Sacra Scrittura e Tradizione, poiché entrambe provengono da una stessa fonte: «La sacra Tradizione e la Sacra Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro. Ambedue infatti, scaturendo dalla stessa divina sorgente, formano, in un certo qual modo, una cosa sola e tendono allo stesso fine. Infatti la Sacra Scrittura è parola di Dio in quanto è messa per iscritto sotto l’ispirazione dello Spirito Santo; invece la sacra Tradizione trasmette integralmente la parola di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli apostoli, ai loro successori, affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano. In questo modo la Chiesa attinge la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Sacra Scrittura. Perciò l’una e l’altra devono esser accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di riverenza » ( Dei Verbum, 9). Soltanto il contesto ecclesiale permette alla Sacra Scrittura di essere compresa come autentica Parola di Dio che si fa guida, norma e regola per la vita della Chiesa e la crescita spirituale dei credenti. Ciò comporta il rifiuto di ogni interpretazione soggettiva o semplicemente limitata a una sola analisi, incapace di accogliere in sé il senso globale che nel corso dei secoli ha guidato la Tradizione dell’intero popolo di Dio.
Cari membri della Pontificia Commissione Biblica, desidero concludere il mio intervento formulando a tutti voi i miei personali ringraziamenti e incoraggiamenti. Vi ringrazio cordialmente per l’impegnativo lavoro che compite al servizio della Parola di Dio e della Chiesa mediante la ricerca, l’insegnamento e la pubblicazione dei vostri studi. A ciò aggiungo i miei incoraggiamenti per il cammino che resta ancora da percorrere. In un mondo dove la ricerca scientifica assume una sempre maggiore importanza in numerosi campi è indispensabile che la scienza esegetica si situi a un livello adeguato. È uno degli aspetti dell’inculturazione della fede che fa parte della missione della Chiesa, in sintonia con l’accoglienza del mistero dell’Incarnazione. Cari fratelli, il Signore Gesù Cristo, Verbo di Dio incarnato e divino Maestro che ha aperto lo spirito dei suoi discepoli all’intelligenza delle Scritture (cfr Lc 24,45), vi guidi e vi sostenga nelle vostre riflessioni. La Vergine Maria, modello di docilità e di obbedienza alla Parola di Dio, vi insegni ad accogliere sempre meglio la ricchezza inesauribile della Sacra Scrittura, non soltanto attraverso la ricerca intellettuale, ma anche nella vostra vita di credenti, affinché il vostro lavoro e la vostra azione possano contribuire a fare sempre più risplendere davanti ai fedeli la luce della Sacra Scrittura. Nell’assicurarvi il sostegno della mia preghiera nella vostra fatica, vi imparto di cuore, quale pegno dei divini favori, l’apostolica benedizione.
Benedetto XVI
-
